De Carugo, de Carugati, von Carugo, von Karuck
I de Carugo sono una famiglia lombarda di antica nobiltà, attestata dal IX secolo[1], feudataria fino alla fine del XV secolo di Carugo, comune della Brianza comasca occidentale, presso il quale possedeva un castello e dal quale prese l’origine ed il nome. Famiglia storicamente di parte ghibellina filoimperiale, con atto del 20 aprile 1377 venne ascritta nella Matricula nobilium familiarum Mediolani, ossia nella lista delle duecento famiglie patrizie milanesi per le quali era stabilito il diritto esclusivo all'Ordinalato della Metropolitana di Milano[2].
Ramificatasi attraverso i secoli, oltre che a Milano la famiglia è annoverata altresì nella nobiltà decurionale di Como, tra le famiglie di “antica nobiltà e di gloriose gesta” della Valtellina[3], nonché nel Libro d’Argento della Cittadinanza Originaria veneziana regolata sin dal 1305[4].
Diede abati e badesse a diversi monasteri, capitanò e si distinse in battaglia, ebbe familiari ed ambasciatori presso la corte viscontea e sforzesca, rettori e dottori presso le università di Milano e Pavia, fece parte del circuito podestarile, si impegnò nei massimi organi di governo nelle vesti di consoli, giudici, deputati, decurioni, commissari, famigliari ducali e consiglieri. Infine, nonostante le proprie origini guerriere, non disdegnò ed ebbe successo nell’attività mercantile.
A partire dalla seconda metà del XVII secolo, mentre l’influenza della famiglia cominciò ad eclissare nei territori sottoposti al controllo spagnolo, la stessa crebbe nell’ambito dei domini austriaci, nel cui contesto alcuni rami conobbero cambiamenti antroponimici dettati dall’influenza della lingua tedesca: da “von Carugo”, sostituendo la particella nobiliare originaria “de” con quella tedesca “von”, fino a “von Karuck”.
Arma della famiglia de Carugo, estratta dallo stemmario “Familienwappen kleinerer Adelshäuser im Herzogtum Mailand” commissionato dalla famiglia Fugger intorno al 1550-1555, e conservato presso la Biblioteca Nazionale Bavarese (Bayerische Staatsbibliothek).
Blasonatura
D'argento, al mastio di rosso, aperto del campo, merlato alla ghibellina il tutto racchiuso tra due trecce di capelli di rosso (Tricia Casatorum)
L’Epoca di Dominazione Spagnola 1535 – 1713
L’Ascesa del Ramo Valtellinese: i de Carugo Cancellieri Generali di Tutta la Valtellina
Dottori di diritto Civile e Canonico, Pronotai, Notai e Notai Imperiali
La Prima Dominazione Austriaca 1713 - 1796
Torna all’indice
Storia: Dalle Origini al XII secolo
Radici etimologiche
L’origine del nome della famiglia coincide con quella del rispettivo toponimo. Il Dizionario di Toponomastica Lombarda di Dante Oliveri suggerisce una possibile radice nel nome comune latino Calugo, per Caligo, Caliginis, ossia “Caligine” o nebbia[5]. Tale denominazione è altresì riscontrabile in alcuni documenti notarili del X secolo[6], nonché nel trattato del XIII secolo “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” dello storico Goffredo da Bussero. Il nome indicherebbe quindi “un territorio nebbioso, probabilmente a causa dell’esposizione a tramontana, nonché della presenza di fontanili e da questi molti ruscelli e laghetti, sotto a fitti ed estesi boschi”[7].
Non è da escludersi anche un’origine celtica in quanto tale è solitamente l’origine dei numerosi toponimi caratterizzati dalle desinenze celtiche ago, igo, ugo, ino e loro affini[8].
Infine, “Carugo” potrebbe essere un derivato a livello di oralità del termine latino Quadrivium, ossia un incontro di quattro vie, interpretazione che viene suggerita dall’antica situazione del nucleo di Carugo all’incrocio di quattro strade. Secondo questa visione l’originale latino quadrivium col tempo sarebbe divenuto possibilmente “Cadruvu”, “Caruvu”, “Caruu”, ed infine Carugo con “g” estirpatrice di iato[9].
Stadelberto de Carugo Giudice Imperiale
Il documento più antico attestante il nome della famiglia consiste in una pergamena scritta nel mese di agosto dell’anno 892 d.C., nella quale si registra il placito comitale indetto dal conte di Milano e del contado milanese Magnifredo I di Milano. A deliberare furono chiamati presso la Loggia della Corte del Ducato tredici nobili: Rotcherio Visconte di Milano, due Iudices imperiali, quattro Iudices della Città di Milano, Stadelberto “Iudex de Carugo”, due Germani di Agrate, e tre notai. La causa riguardò una permuta tra due rilevanti istituzioni e personalità del periodo: Pietro II arciprete e custode del Duomo di Monza, e Pietro II abate della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano[10].
Stadelberto de Carugo è pertanto il primo membro dell’omonima famiglia di cui si ha notizia nelle fonti storiche. Originario di Carugo, ebbe anche residenza a Milano ove fu inizialmente scabino. Fu infatti intorno all’870 che gli scabini milanesi cominciarono ad adottare il titolo di Iudices Mediolanensis o più semplicemente di Iudices al fine di riflettere lo status di missus permanente dell’arcivescovo di Milano[11]. Stadelbertus de Carugo passò al gruppo di nomina reale dei iudex domini regis dopo l’890[12].
In epoca carolingia l’esercizio di una funzione pubblica era generalmente accompagnato da un dovere di esercizio della funzione giudiziaria: conti, vescovi, conti di palazzo, missi imperiali, giudici, ebbero tutti il compito di presiedere e partecipare ai placiti ordinari e straordinari[13]. Il titolo di Iudex (i.e. “giudice”) venne assegnato per la prima volta a singoli membri dei collegi in un placito tenutosi a Pistoia nell’anno 812 d.C., ed identificava vassalli regi ed imperiali[14]. Gradualmente lo stesso titolo cominciò ad identificare solo quei membri dei collegi giudicanti che fossero anche letterati ed avessero una conoscenza del diritto[15]. Fu infatti solo nell’arco di un certo tempo che gli stessi scabini acquisirono una certa competenza tecnica professionalizzante[16]. Per tutto il secolo IX, il carattere collettivo dei giudizi e la necessità della presenza nei comitati giudicanti di uomini liberi, ossia di nobili prima che di tecnici, rimasero fattori essenziali[17].
La serie dei successivi placiti nei quali Stadelberto de Carugo fece parte del comitato giudicante, testimoniano la sua affermazione ed ascesa sociale[18]: nel placito tenutosi a Pavia il 4 marzo 899 dal vescovo e messo regio Giovanni, notiamo ch’egli fu promosso a “Iudex Domini Regis” ossia giudice reale[19]. Nel febbraio del 901 partecipò ad un placito tenutosi a Roma dall’imperatore Lodovico III e dal pontefice Benedetto IV, assieme ai più importanti vescovi, duchi, conti e giudici del regno, in qualità di “Iudex Domini Imperatoris” ossia giudice imperiale[20]. Con la stessa carica presenziò al placito tenutosi a Piacenza nel gennaio del 903 dal re Berengario, dal conte di palazzo e del contado di Piacenza Sigefredo, e dalla badessa del monastero della Resurrezione Adelberga[21]. Infine, il 14 maggio del 927 a Pavia intervenne nuovamente nelle vesti di giudice reale in un placito indetto dal conte di palazzo Giselberto nel quale si confrontarono l’avvocato del monastero di S. Pietro di Civate ed un certo Giselberto del fu Gaidaldo di Merate[22]. Entrambe le nuove qualifiche di giudice reale ed imperiale adottate da Stadelberto de Carugo furono di nomina reale[23].
Nel decimo secolo i giudici reali o imperiali, spesso a capo di una propria rete vassallatica[24], formarono un gruppo omogeneo assimilabile a quello dell’aristocrazia, sia quanto a posizione sociale che in materia di stili di vita: il re d’Italia Lotario nell’agosto del 949 donò al giudice Nazario le mura e le torri della città di Como[25]; nel 967 l’abate dell’Abbazia di Cluny ricevette la prima donazione italiana dal giudice di Pavia Gaidulfo e da sua moglie Ima, consistente in una serie di edifici ed una chiesa[26]; nella iudiciaria laumellese il giudice del Sacro Palazzo di Pavia Cuniberto nel 996 venne nominato conte di Lomello, mentre suo fratello Pietro divenne vescovo di Como; il fratello del giudice Gisulfo fu vescovo ed arcicancelliere di Novara[27], ed il giudice Leone fu vicedomino della stessa città[28]; a Pavia la figlia del giudice Walpertus andò in sposa al conte palatino[29]; Ingelbertus, figlio del giudice Pietro, divenne abate del monastero di Nonantola[30]; infine a Verona, il giudice Eriberto competé con il vescovo Ratherii e costituì una propria rete vassallatica.
Nella città di Milano, alcuni discendenti dei giudici milanesi divennero ordinari della Cattedrale, e lo storico Hagen Keller notò l’integrazione dei giudici milanesi nell’ordo dei capitanei, nonché il loro ruolo di guida del movimento patarino. In linea generale, l’ascesa delle famiglie dei giudici dell’Italia Settentrionale ebbe la sua massima e più frequentemente annoverata espressione nell’acquisizione della posizione di dominatus loci, mediante l’appropriazione di signorie rurali e di immobili di prestigio, al prezzo di una dipendenza personale e finanziaria con il vescovo di Milano[31]. Il percorso intrapreso nello stesso periodo dai de Carugo non si discosta con quanto delineato dalle suddette fonti: essi divennero infatti principalmente vassalli primi milites del vescovo di Milano, “dal quale ricevettero in beneficio il controllo delle località rurali, e per il quale svolgevano azioni di difesa mediante il controllo delle fortificazioni e la facoltà di chiamare alle armi gli uomini liberi del feudo”[32].
L’iniziale appartenenza di Stadelberto al collegio di scabini milanesi poi elevati a giudici di Milano, permette di estendere ulteriormente l’indagine circa le origini della famiglia de Carugo. Infatti, la professione e la posizione sociale degli scabini vennero tramandate di padre in figlio, profilandosi così più generazioni consecutive di scabini all’interno della stessa famiglia. Alternativamente i figli degli scabini, grazie al prestigio sociale dei propri padri, divennero proprietari terrieri o percorsero la carriera ecclesiastica[33]. Del resto prestigio sociale ed economico furono anche criteri in base alla quale avvenne il loro reclutamento. Non sorprenderà pertanto che gli scabini siano anch’essi considerati a tutti gli effetti membri della nobiltà locale[34], e che le fonti superstiti confermino il loro possesso occasionale di curtis, d’immobili in città, nonché la fondazioni di cappelle private[35]. Gli scabini furono responsabili anche di un’ampia gamma di attività al di fuori dei tribunali: presiedettero investiture, risolsero controversie e supervisionarono transazioni private, esecuzioni testamentari e alienazioni di beni. L’impatto quotidiano di queste attività e la loro presenza molto richiesta come boni homines, li spinse a divenire intermediari tra le popolazioni e l’amministrazione centrale, in particolare durante i giuramenti collettivi, e ad assumere naturalmente la guida delle comunità[36].
Il titolo di scabino e i suoi vantaggi servirono senza dubbio come ricompensa per servizi resi al conte o al vescovo[37]. La remunerazione degli scabini consistette principalmente in una dotazione di diritti e rendite fondiarie, denominata beneficium, sussistenti su fondi e comunità tendenzialmente limitrofi con quelli direttamente sottoposti al re, al vescovo, o al conte, in un’ottica di concessioni fondiarie indirizzate a rafforzare i legami tra gli interessi degli scabini e quelli delle autorità sia laiche che ecclesiastiche alle quali erano sottoposti[38]: lo scabino senese Aipo fu vassallo del re d’Italia Lotario I; agli inizi del secolo X lo scabino longobardo Pietro da Verona ebbe un proprio vassallo; diversi scabini del ducato di Spoleto ebbero ascendenti nella famiglia comitale; il vescovo di Lucca Pietro II (896-932) fu figlio del notaio e scabino magister Roffridus; infine, nelle città di Milano e Chiusi, la vicinanza tra gli scabini e l’autorità regnante alla quale rispondevano si caratterizzò in taluni casi anche in termini di legami di parentela[39].
La maggior parte della documentazione superstite profila lo scabino lombardo del decimo secolo come membro di famiglie di diritto longobardo, ma talvolta anche franco o romano[40], avente le proprie origini famigliari nelle località rurali e dotato di un’abitazione presso la città[41]. Carugo, è uno dei centri della Brianza settentrionale per i quali si hanno ancora documenti comprovanti una stabile presenza longobarda[42]. Tra questi, un atto di vendita datato primo di giugno 990 d.C., testimonia la discendenza longobarda dei de Carugo nonché la loro connessione con importanti famiglie ed istituzioni monzesi di medesima origine[43]. In particolare, Pietro, presbitero dell’Ordine di San Giovanni, ossia presbitero presso la basilica di san Giovanni Battista in Monza, fondata dalla regina Teodolinda come cappella palatina del suo Palazzo Reale monzese, residenza estiva della corte longobarda; assieme ad un certo Magnus ed Aldo de Villola, figli del fu Aldegisi, famiglia di legge longobarda, acquistano da Arnaldo e Garibaldo de Carugo, figli di Andrei “de loco Calugo” (ossia Carugo), “qui professi sumus lege vivere langobardorum” ossia anch’essi di legge longobarda, un terreno inclusivo di palazzo, corte ed orto presso la Contrada d’Arena in Monza. La proprietà sembrerebbe però essere appartenuta inizialmente alla famiglia monzese della moglie di Garibaldo, Ficia, figlia di Tadoni de loco Modicia (ossia Monza). Essa riconosce Garibaldo de Carugo quale suo marito e mondualdo, e conferma ai propri genitori di non essere stata forzata alla vendita né da lui né da nessun’altro membro della famiglia del marito.
Del resto l’introduzione ed attribuzione del titolo di scabino da parte dei carolingi intorno all’810 d.C.[44], interessò inizialmente proprio il preesistente “personale” longobardo: i vecchi funzionari longobardi nell’Italia Settentrionale, gli sculdasci a Spoleto, i locopositi e i locoservatores a Pisa e a Lucca, i quali mantennero le proprie funzioni aggiornando solamente il proprio titolo[45]. Ciò si riflesse anche in un crescente accostamento di titoli di origine longobarda e titoli di origine franca come “guastaldus scabinus” o “scabinus sculdassius” ancora presente in molti luoghi fino all’inizio del X secolo[46].
In età longobarda i titoli di Dux, Gastaldius, e Iudex vennero sostanzialmente parificati dall’Editto di Rotari del 643 d.C., e delineavano un governatore delle province con poteri amministrativi, giudiziari e militari[47]. A seguito di tal editto, i testi normativi longobardi designarono come “Iudex” sia il duca che il gastaldo. I testi di pratica giudiziaria invece raggruppavano sotto il nome di “Iudices” tutti i pubblici funzionari, laici o ecclesiastici, dotati di potere di comando, ossia il duca, vescovo, gastaldo, i missi e gli sculdasci presi singolarmente o raggruppati[48]. Importanti distretti limitrofi di Carugo, come quello di Castelseprio, o poco più distanti, come Stazzona, Angera, e Bellinzona, si costituirono già a partire dal VII-VIII secolo come iudiciarie sottoposte all’autorità di un gastaldo (Iudex) longobardo. In particolare, la gastaldia di Claro (Bellinzona) sopravvisse fino agli inizi del XV secolo come complesso di diritti, fitti e decime[49].
Nel formulare delle ipotesi circa il profilo socio economico degli ascendenti di diritto longobardo del giudice imperiale Stadelberto de Carugo, si potrebbe supporre che il loro titolo franco di scabino fosse stato inizialmente assegnato ad un membro della famiglia detentore del titolo longobardo di sculdascio, con competenze legate alle funzioni di polizia, di giustizia, all’esazione e sanzione dei debiti e dei debitori, nonché al comando della leva militare[50]. A tale supposizione si giunge tenendo conto che al titolo longobardo di gastaldo, più importante di quello di sculdascio, a partire dall’anno 810, venne più comunemente assegnato quello di “visconte”, talvolta con un semplice cambiamento di nome[51]. A partire dal regno di Ludovico II (844) gli sculdasci sono intesi quali vassalli diretti del conte o del vescovo, “vassi episcoporum”[52], una caratteristica questa che si traslò appieno nel titolo di scabino. Le fonti Milanesi confermano l’esistenza di sculdascie a Sesto San Giovanni, Abbiategrasso, Cavenago, fino a Lugano, e sculdasci residenti a Milano e diretti vassalli del conte[53]. Infine, gli storici individuano tra le principali cause della graduale scomparsa del titolo di sculdascio l’avvento degli scabini e dei giudici reali, i quali ben presto si sostituirono agli sculdasci nell’esercizio delle loro funzioni. La tendenza è particolarmente evidente in ambito giudiziario. Non si trattò tanto di concorrenza quanto di progressiva fusione, chiaramente visibile anche nella doppia attribuzione del titolo di sculdascio e scabino “scavinus et sculdasssio” nella medesima persona[54].
I de Carugo “conti rurali”
Tra i molteplici fenomeni che a partire dal IX e X secolo caratterizzarono nel regno italico il cosiddetto particolarismo postcarolingio, si hanno l’eclissi delle antiche “dinastie funzionariali” sia in ambito cittadino che in quello rurale, la sostituzione, soprattutto ad opera della dinastia ottoniana, degli antichi “conti urbani” con “vescovi-conti”, l’emergere di nuovi centri di potere locali a causa della frammentazione della rete vassallatica, la quale vide nuove investiture, la patrimonializzazione dei benefici, l’usurpazione, l’incastellamento, e l’affermarsi della signoria di banno[55]. Lo storico Ludovico Antonio Muratori, nella sua monumentale opera Antiquitates Italicae Medii Aevi, identifica tali nuovi centri di potere locali del contado nei cosiddetti “conti rurali”[56].
I conti rurali furono pertanto i signori di quelle famiglie nobili del contado che nel sopradescritto periodo storico si emanciparono dalla loro condizione vassallatica e cominciarono ad esercitare nei loro distretti un potere sovrano[57]. Nella maggior parte dei casi i conti rurali esercitarono tale potere “di fatto”, ossia solo per un ristretto numero di località si conservano tuttora i diplomi regi od imperiali per mezzo dei quali i signori locali vennero eletti al rango comitale prima dell’anno mille[58]. Il più antico di siffatti diplomi, di cui si ha notizia, venne promulgato dal re d’Italia Ugo di Provenza e suo figlio Lotario II il 4 marzo del 945 a favore di Gropardo, loro fedele, divenuto conte de Castro Fontaneto nei pressi di Novara[59]. Secondo quanto riportato da Galvano Fiamma, fu proprio nello stesso periodo, e per tramite degli stessi Ugo di Provenza e Lotario II, che si istituì anche un Vicario generale nella Martesana, dal quale ebbero origine alcune delle famiglie della Consorteria dei Giussano.
Il Contado della Martesana, al quale apparteneva il territorio controllato dalla famiglia de Carugo, fu per lungo tempo sottoposto alle influenze contrastanti dell’impero e del papato, nonché spesso terreno di battaglia tra gli eserciti imperiali e quelli comunali, e tra le principali partes (fazioni) nelle quali si strutturò la società. Nel 1036 le milizie dei de Carugo vennero in soccorso ai valvassori milanesi, cacciati dalla città dall’arcivescovo Ariberto da Intimiano. Giunto in Italia l’Imperatore Corrado II Il Salico, nel 1037 mise sotto assedio la città di Milano e promulgò a sostegno della nobiltà minore l’Edictum de Beneficiis Regni Italici. Tale nuova costituzione imperiale estese anche ai valvassori i benefici fino ad allora riservati al rango dei capitanei, ossia di irrevocabilità (se non per giusta causa, identificata dal giudizio di propri pari) e di ereditarietà dei propri feudi, anticipando così di oltre un secolo la promulgazione di equiparabili protezioni legali emanate nella meglio nota Magna Carta[60]. Nel 1042 le famiglie nobili della Martesana verranno in soccorso dell’intera nobiltà cittadina, sia quella dei capitanei che quella dei valvassori, nonché del vescovo Ariberto da Intimiano, i quali furono tutti cacciati dalla città dalla Pars Populi in armi. Dopo un assedio durato circa tre anni, i nobili riuscirono a fare ritorno a Milano[61].
In siffatto contesto, i nobili della Martesana rimasero politicamente indipendenti fino al 1183[62]. Nel caso specifico, l’indipendenza dei nobili martesani è chiaramente esemplificata da quanto riportò il cronista Sire Raul nella sua raccolta sincrona Annales Mediolanenses, nella quale si narra dell’incontro tra l’Imperatore Federico Barbarossa ed i nobili martesani avvenuto a Monza nei giorni successivi all’8 settembre 1158. Per aggiudicarsi l’appoggio militare dei nobili martesani, l’imperatore dovette elargire loro promesse ed importanti somme di denaro. I martesani, accettando l’invito dell’Imperatore, venivano meno a quanto avevano in precedenza già promesso ai milanesi, con i quali erano “federati” e “in gran numero legati da legami di parentela”[63]. In altre parole, all’alba di questi eventi, le famiglie nobili del contado non sembrerebbero essere sottoposte ad un rigoroso rapporto vassallatico né con l’Imperatore né con Milano. Tale dovette essere pertanto la condizione della famiglia de Carugo e di molte famiglie nobili del contado della Martesana, fintantoché questo territorio rimase oggetto d’irrisolta contesa.
Ciò detto, in base al criterio deduttivo adottato dagli studiosi Giovanni Dozio e Giuseppe Prestinoni, è d’uopo affermare che i de Carugo furono indubbiamente fedeli all’imperatore in quanto legati al Capitolo del Duomo di Monza e all’abbazia benedettina di San Pietro al Monte presso Civate[64]. Il 27 aprile del 1162 entrambe queste istituzioni ricevettero riconoscimenti a nome dell’imperatore: la cattedrale di Monza fu formalmente investita di beni e giurisdizioni feudali[65], mentre l’abbazia venne sottoposta alla diretta giurisdizione dell’imperatore mediante diploma di protezione imperiale[66]. In più occasioni le milizie dei de Carugo parteciparono attivamente allo scontro armato al fianco dell’imperatore. Nel novembre 1162 i de Carugo si schierarono in armi con l’imperatore Federico Barbarossa e contribuirono alla distruzione di Milano[67]. In particolare, alle milizie del Contado della Martesana venne affibbiato il compito di distruggere le fortificazioni cittadine a cominciare da quelle afferenti a Porta Nuova[68]. Nell’anno 1239 si unirono agli eserciti di Federico II, il quale diede mandato di espropriare i beni di quanti fossero rimasti fedeli a Milano.[69]
La riaffermazione dei loro seniores passò innanzitutto dalla proposta dell’imperatore che a capo sia del contado del Seprio che di quello della Martesana fosse posto il conte Gozwin von Heinsberg. Questi venne poi affiancato dal cavaliere teutonico Ruino in qualità di podestà del territorio della Martesana. Infine, a partire dal 25 giugno del 1183, giorno in cui venne conclusa la Pace di Costanza, il contado della Martesana cadde stabilmente sotto la giurisdizione della città di Milano[70].
Quindi i de Carugo furono principalmente vassalli primi milites del vescovo di Milano, “dal quale ricevettero in beneficio il controllo delle località rurali, e per il quale svolgevano azioni di difesa mediante il controllo delle fortificazioni e la facoltà di chiamare alle armi gli uomini liberi del feudo”[71]. Furono inoltre vassalli diretti dell’Imperatore del Sacro Romano Impero, nella persona di Ser Rodolfo de Carugo, in quanto Abate della potente abbazia benedettina di San Pietro al Monte, soggetta alla diretta protezione dell’Imperatore[72]. Come riportato dal cancelliere imperiale infatti, per ordine dell’imperatore Federico Barbarossa, “su tutta la giurisdizione del monastero di Civate nessuna città, nessun Milanese, e nessuna persona pubblica o privata, grande o piccola, potrà avere alcun diritto, se non ch'egli solo e i suoi successori re ed imperatori dei Romani, e l'abate dello stesso monastero”[73].
Detentori del dominatus loci su Carugo, sia il castello, ma anche i possedimenti allodiali ed i diritti signorili della famiglia, si inquadravano tra quelli detenuti dalle restanti famiglie appartenenti alla consorteria e radicate sui territori limitrofi, costituendo così una rete di castra e cassine, sia ad uso militare che per il coordinamento della produzione fondiaria[74].
Come scrisse Giovanni Dozio nella sua opera storiografica sul Contado della Martesana, dei “conti rurali ormai eran rimasti null’ altro che ricchi proprietari col nudo titolo di conte”[75]. Ad oggi i de Carugo vengono ricordati quali conti nella leggenda locale del "Cunt de Carüc" (ossia conte de Carugo)[76], nonché come tali sono riferiti in alcuni musei locali[77]
L’Età Comunale 1183-1276
Il secolo dell’epoca comunale, che intercorse tra la Pace di Costanza e l’inizio del dominio Visconteo, fu per la famiglia de Carugo, così come per molte altre famiglie ghibelline del contado, inclusi i Visconti, un periodo di sfide e di tenace resistenza. I de Carugo mantennero uno schieramento filoimperiale, e furono in prima linea al fianco dell’arcivescovo di Milano nella lotta contro i regimi del Comune di Popolo e dei della Torre[78]. Fino all’avvento dei Visconti nel 1277, essi rimasero relativamente estranei alla vita politica cittadina milanese, coinvolti, al più, fornendo l’appoggio del proprio castello alla Pars Nobilium[79].
Nell’ambito delle trattative che precedettero la stipulazione della Pace di Costanza, i messi dell’imperatore Federico Barbarossa riuscirono ad imporre l’istituzione delle curie imperiali giudiziarie d’appello dalle sentenze dei magistrati comunali. Alle stesse curie imperiali veniva altresì attribuita la giurisdizione nelle controversie tra Comuni e vassalli imperiali. Il 30 aprile 1186 dal palazzo vescovile di Lodi, il giudice della curia imperiale Ottone Zendadario, pronunciando una delle prime sentenze delle neocostituite curie d’appello, dichiarò che l’Abate del monastero di Sant’Ambrogio di Milano, aveva il diritto di appellarsi contro la sentenza consolare col quale era stato deferito d’ufficio il giuramento dovuto al Monastero dai vicini di Cologno sul Lambro[80]. Nelle fonti permangono le dettagliate condizioni di scelta dei testimoni compilate dal causidico dell’abate, il quale prescrisse d’interrogare i testimoni singolarmente ed in dettaglio per amore dell’Abate di Sant’Ambrogio: “Interrogate testes omnes singilatim et diligenter pro amore beati confessoris sancti Ambrosii”[81]. La presenza di Iohannes (Giovanni) de Carugo tra i testimoni chiamati a supportare le argomentazioni a favore del monastero, esemplifica la perdurante vicinanza tra gli esponenti della famiglia de Carugo e le autorità imperiali ed ecclesiastiche, con le quali ebbero un rapporto di vassallaggio.
In particolare ai testimoni venne richiesto di confermare che il monastero, nel proprio territorio di competenza, era solito richiedere il giuramento di fedeltà e imporre precetti e sanzioni su suoi districtabiles, che allorquando si fosse reso necessario, il monastero espulse i trasgressori ed ebbe rimosso i decani eletti senza il suo consenso[82]. In altre parole, il monastero volle dare prova del fatto ch’esso deteneva sui propri possedimenti honor et districtus. In questo periodo storico di sviluppo e di emancipazione dei Comuni, siffatte questioni di giurisdizione fomentarono frequenti scontri e tensioni. Alle velleità del Comune di Milano di allargare la propria giurisdizione sulla campagna, si oppose la ferma volontà dell’aristocrazia e dei grandi enti ecclesiastici di mantenere i propri poteri signorili[83].
Furono probabilmente dispute afferenti alla giurisdizione temporale, che portarono nel 1221 l’arcivescovo di Milano Enrico da Settala a scomunicare il podestà di Monza[84], un atto al quale il Comune cittadino rispose bandendo il prelato. Al fallimento del tentativo di mediazione del legato pontificio Ugolino d’Ostia, seguirono quindi nuovi anni di guerra che videro contrapporsi da una parte la fazione del popolo e delle istituzioni cittadine da essi controllate, e dall’altra la nobiltà dei capitanei e valvassori e le istituzioni religiose. Secondo le Notae Sancti Georgii nel periodo natalizio di quell’anno cominciò un vero e proprio esodo della classe nobiliare la quale, capitanata dall’arcivescovo, abbandonò la città di Milano per prepararsi allo scontro armato. L’arcivescovo si rifugiò a Cantù, mentre le famiglie della nobiltà cittadina vennero accolte presso i castelli della nobiltà rurale incluso quello della famiglia dei de Carugo. I castelli del Contado della Martesana e del Seprio divenuti così le roccaforti della nobiltà sia rurale che cittadina, vennero attaccati dalle milizie popolari capitanate dal podestà Ardigotto Marcellino, le quali, nell’agosto del 1222, giunsero a distruggere il castello dei de Carugo[85]. Ad oggi, dell’antico fortilizio merlato, rimane solo parte di una torre
La Torre di Carugo (Carugo, CO), ultime vestigia dell’antico castello della famiglia de Carugo distrutto nel 1222. La merlatura ghibellina a coda di rondine, nonché la torretta sovrastante, vennero abbattute nel 1910.
Miky26930 - Own work
Oltre che durante gli eventi bellici, nel corso dell’età comunale la famiglia de Carugo e la consorteria d’appartenenza dovettero difendere le proprie prerogative anche dalla persecuzione politica e religiosa. Nel 1240 le istituzioni cittadine milanesi introdussero infatti lo strumento di persecuzione politica di massa detto “bando per malesardia”, destinato a colpire personalmente chiunque fosse accusato di schierarsi con l’Imperatore[86]. Il nove novembre del 1273 il giudice per le esazioni e le malesardie del comune di Milano Francesco Sterzato, su richiesta della badessa del Monastero Maggiore di Milano, condannò per malesardia Repellus de Carugo figlio del Dominus Ser Guidoni de Carugo di Porta Cumana in Milano, al quale seguì l’ordine di sequestro di alcuni dei suoi beni[87].
Nobili e Decurioni Comensi
La repressione politica indirizzata alle famiglie nobili di parte ghibellina, quale fu quella dei de Carugo, fu sicuramente una delle ragioni per le quali la famiglia rimase, fino all’avvento dei Visconti, essenzialmente estranea alla vita politica cittadina milanese. Nella città filoimperiale di Como invece, il ramo comense dei de Carugo copriva ruoli politici di grande prestigio già da alcuni decenni. Le fonti storiche ricordano, tra gli altri, Ambroxii (Ambrogio) de Carugo, testimone in un atto di permuta del 10 maggio 1176[88], tra il monastero di San Benedetto e la Chiesa di Santa Eufemia dell’Isola Comacina; Ottone de Carugo, Console di Giustizia di Como ed artefice della sentenza del 15 maggio 1202 nella lite dei Canonici di San Lorenzo di Chiavenna contro Bertramo e Pietro fratelli de Stoa[89]; Jacopo (o Giacomo) de Carugo, ambasciatore comense all’assemblea del governo della Lega Lombarda tenutasi l’8 dicembre 1229 presso il Palazzo Arcivescovile, alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Enrico da Settala, dei rettori e del Podestà[90]; Lanfrancus de Carugo, Decurione del Consiglio Generale di Como, figlio di Leone de Carugo[91], che su sua proposta del 24 novembre del 1260 decise con votazione che i Bormiesi dovessero versare duecento lire di denari «nostrorum» cioè di Como, piuttosto che di moneta imperiale[92]. Infine, in un atto d’investitura livellaria del 1290 circa, si registra Lanfranco de Carugo notaio per l’abbazia benedettina di San Pietro al Monte presso Civate, figlio di ser Pietro de Carugo[93].
Membri dell’Ordine sacro e degli Ordini Monastici: secoli XII e XIII
Nel contesto lombardo, in risposta allo sviluppo delle istituzioni cittadine in competizione con i privilegi storici della nobiltà, quest’ultima a partire dall’XI secolo non si distinse più semplicemente nel binomio milites – pedites, tipico delle clientele feudali e militari, ma in quello di capitanei et valvassores – populus. Nell’ambito di questa nuova definizione, la condizione fondamentale mediante la quale la classe aristocratica dei capitanei e dei valvassores si distingueva da quella popolare fu l’appartenenza della propria famiglia alla gerarchia vassallatica facente capo all’arcivescovo o, più raramente, all’imperatore[94]. Tale condizione dava ai membri delle famiglie nobili l’accesso esclusivo al capitolo maggiore della cattedrale di Milano il quale, sin dal XII secolo, non ammise le famiglie di estrazione popolare[95]. Come riportato nel Liber Consuetudinum del 1217, le famiglie aristocratiche imposero all’arcivescovo l’impegno a non creare nuovi legami feudali, creando così una classe nobiliare chiusa, che non riconosceva come pari nemmeno quelle famiglie che avessero raggiunto equivalente influenza mediante l’acquisto in denaro di giurisdizioni e diritti signorili. Infatti, la supremazia delle famiglie nobili, sancita giuridicamente ed ereditaria, non ebbe unicamente a che vedere con la capacità economica, ma piuttosto con la padronanza delle armi, la gestione della giustizia e l’imposizione fiscale, alla quale esse si sottraevano in quanto residenti nei propri castelli[96].
L’aristocrazia milanese, così definita, competeva da una posizione di vantaggio, contro la parte popolare, per il controllo dei beni della Chiesa e dei grandi enti ecclesiastici. I legami familiari dei religiosi contribuivano infatti ad influenzare lo schieramento politico dell’ente di appartenenza e ad indirizzarne l’attività economica. Un efficace meccanismo di allargamento dell’influenza famigliare vedeva abati e badesse dei grandi monasteri assegnare le cariche di governo delle comunità soggette, ai membri della propria famiglia di origine, creando in tal modo un “dominus” laico locale per conto dell’ente ecclesiastico (e.g. avvocati, rappresentanti e vicari abbaziali)[97]. Eventuali beni e diritti lasciati in legato agli enti ecclesiastici sarebbero effettivamente rimasti nell’ambito del controllo familiare ed allo stesso tempo protetti dalle istituzioni cittadine in quanto di pertinenza della Chiesa.
Abbazia di San Pietro al Monte, valle dell'Oro, comune di Civate in provincia di Lecco.
Di Laurom - Opera propria, CC BY-SA 3.0
La famiglia de Carugo ebbe un’importante presenza presso gli enti religiosi come testimoniato dalle fonti. Ser Rodolfo de Carugo fu abate della potente abbazia benedettina di San Pietro al Monte presso Civate per circa trent’anni, dal 1221 fino a circa il 1249 (sicuramente oltre il 1244)[98]. Per quanto concerne il dominatus direttamente gestito dai monasteri, i rispettivi abati e badesse esercitavano i diritti giurisdizionali al pari dei domini laici, adottando spesso anche forme di vita militare[99]. L’abbazia, che secondo alcune fonti fu fondata dal re longobardo Desiderio nel 772 d.C., nel periodo tra la seconda metà del XIII e l’inizio del XIV, venne attaccata e parzialmente distrutta dalle milizie del Comune di Milano. Ciò avvenne per ritorsione contro i monaci dell’abbazia che negli scontri del secolo precedente rimasero fedeli all’Imperatore Federico Barbarossa[100], e che nel gennaio del 1254 diedero rifugio all’Arcivescovo di Milano Leone da Perego, uscito dalla città assieme ai nobili a causa di un’insurrezione della parte popolare[101]. “Domini domini” Giordano de Carugo fu monaco presso la medesima abbazia nel 1293[102].
Domina Carenza de Carugo e domina Bellacara de Carugo, furono monache del monastero benedettino di San Vittore di Meda, il più ricco dei monasteri di benedettine del contado della Martesana, attestate rispettivamente già nel febbraio 1257 [103] e nell’aprile 1277 [103a], un periodo pluridecennale che testimonia il radicamento della famiglia de Carugo nella comunità monastica medese nel corso del XIII secolo. In questo periodo storico i monasteri femminili dell’area milanese e briantea rappresentarono un elemento strutturale della società sia cittadina che del contado, svolgendo una funzione che oltrepassava l’ambito strettamente religioso per inserirsi stabilmente nelle strategie familiari delle élite locali. La storiografia ha evidenziato come tali istituzioni accogliessero prevalentemente donne provenienti da famiglie aristocratiche o dal ceto dirigente rurale e urbano, per le quali la vita monastica costituiva una modalità alternativa al matrimonio, funzionale alla gestione del patrimonio, e al consolidamento dei rapporti con la Chiesa ambrosiana. I conventi femminili non operavano infatti come istituzioni isolate, ma come nodi di reti locali fondate su relazioni familiari, patrimoniali e territoriali, spesso rafforzate da legami di lunga durata con l’autorità episcopale [103b]. Accanto alle monache de Carugo, sono attestate infatti religiose appartenenti a famiglie di analogo radicamento territoriale, anch’esse originarie di località limitrofe, quali le de Besuzio (Besozzi), le de Buixio (Bovisio), le de Raude (Rho), le de Birago, le de Lantate (Lentate), le de Bucinigo (Buccinigo), e le de Madernis (Cesano Maderno).
Il 4 aprile 1277 Carenza e Bellacara de Carugo partecipano all’elezione della nuova badessa, Contessa de Besuzio, in luogo di Maria de Besuzio, la quale rinunciò alla carica in ragione della propria anzianità ed infermità. La conferma sarà consegnata nelle mani di Gaspare, preposito di Brebbia, inviato dallo stesso arcivescovo di Milano Ottone Visconti con lettera del 31 marzo [103c].
Infine, Guglielmo de Carugo fu cappellano presso la Chiesa di Santa Maria in Strada in Monza nell’aprile del 1286[104].
Santi Aimo e Vermondo Corio, conti di Turbigo, fondano il monastero di San Vittore a Meda in Brianza, in una miniatura della prima metà del 1400, attribuita ad Anovelo da Imbonate, miniatore e pittore italiano al servizio della corte viscontea.
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 26, fol. 4v, 87.MN.33.4v, Getty’s Open Content Program.
Conflitti giurisdizionali e scontri armati con gli enti ecclesiastici
Tra i fattori capaci di minacciare i rapporti tra gli enti ecclesiastici e la nobiltà ghibellina, della quale fece parte la famiglia de Carugo, si possono annoverare le ingerenze della Curia romana per mezzo del legato pontificio e dell’inquisizione ecclesiastica. Quest’ultima estese il concetto di eterodossia fino ad includere qualunque avversario della chiesa, facendone così un ulteriore strumento politico per mezzo del quale si colpirono le famiglie aristocratiche ghibelline; mentre il legato pontificio Gregorio da Montelongo, di fatto alla guida della politica cittadina, strinse un’alleanza tattica con la fazione Popolare. Le famiglie de Carugo e Giussani furono entrambe duramente attaccate in particolare nel periodo successivo alla disfatta comunale nella battaglia di Cortenuova del 1237.
Il 19 agosto 1254 con la Ad audientiam nostram, Papa Innocenzo IV ordinò la distruzione di uno dei più importanti tra i castelli della famiglia Giussani, il castello di Gattedo. L’ordine conseguì al coinvolgimento di almeno tre membri della famiglia, ser Tommaso da Giussano, Roberto da Giussano, detto Patta, signore del castello di Gattedo, e suo fratello Enrico Rosso da Giussano, nell’organizzazione dell’omicidio del frate inquisitore Pietro da Verona, perpetrato nei pressi di Barlassina il 6 aprile del 1252. Il castello di Gattedo, faceva parte di un esteso sistema difensivo anche del territorio dei de Carugo, che includeva altresì i castelli di Guardia (oggi Cascina Guardia), di Incasate, e di San Martino (ove rimane l’omonima chiesetta, probabilmente cappella di famiglia e prima ancora parte di un monastero). La distruzione del castello ebbe anche un alto valore simbolico e religioso dal momento che ivi furono sepolti i vescovi catari Nazario e Desiderio[105], le cui spoglie mortali, per lo stesso ordine del papa, furono dissotterrate e date alle fiamme dagli inquisitori[106].
Le famiglie de Carugo ed il Monastero di San Maurizio detto il Maggiore
Il Monastero Maggiore fu il più vasto ed antico monastero femminile di Milano, fondato tra la tarda età longobarda e la prima fase carolingia (VIII - IX secolo) e soppresso soltanto nel 1798. A partire dal 1078, la dedicazione a San Maurizio si affiancherà a quella originaria mariana, ridefinendone stabilmente anche il nome in Monastero di San Maurizio detto il Maggiore [107]. Fra il 1133 ed il 1134 il Monastero Maggiore acquistò dalla famiglia Cani, per 939 lire di buoni denari d’argento, le proprietà ed i relativi diritti giurisdizionali d’honor et districtus sui territori di Arosio, Pozzolo, Briosco, Cogliate e Romanò [108]. Il cenobio, che ospitava monache provenienti dalle più illustri famiglie milanesi, venne risparmiato dall’imperatore Federico Barbarossa, il quale lo escluse dalle incursioni e distruzioni impartite alla città di Milano nell’inverno del 1162 [107a].
Veduta della Torre Poligonale e della Torre Quadrangolare, sorte per volere dell’imperatore Massimiano Erculeo tra la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C. La prima fece parte delle mura urbiche della città, mentre la seconda fu una delle torri laterali del circo romano (lo stesso ove nel 604 d.C. il re dei Longobardi Agilulfo e la regina Teodolinda associarono pubblicamente il proprio figlio Adaloaldo al potere). Entrambe divennero poi parte del Monastero Maggiore, funzionando rispettivamente come cappella e campanile dell’antica chiesa.
Dettagli degli affreschi rinvenuti all’interno della Torre Poligonale, cappella del Monastero Maggiore, risalenti al XIII secolo. Le due monache benedettine rappresentate furono con ogni probabilità le committenti.
Copyright Immagini/Foto © Museo Archeologico di Milano. Comune di Milano. Tutti i diritti di legge riservati.
Fino al 1230 circa, ossia nel periodo antecedente all’elezione di Mattea Pirovano alla carica di badessa, il Monastero sembrò adottare una gestione mediata del territorio di Arosio, coinvolgendo sapientemente le famiglie nobili della consorteria, in primis quella dei de Giussano, ed in misura minore quella dei de Carugo [109]. Il territorio di Arosio confinava con quelli sotto il controllo delle famiglie della consorteria, e ne subì per lungo tempo le influenze. I de Giussano detennero sia alte cariche consolari in rappresentanza della popolazione locale, che importanti cariche rappresentative dello stesso Monastero. Sia la famiglia de Carugo che quella de Giussano possedevano nel territorio di Arosio grandi proprietà fondiarie ed immobili presso il centro abitato. Guido de Carugo e Tommaso de Giussano possederono edifici all’interno del Castello di Arosio[110]. Nel 1202 Ottone de Giussano fu messo del Monastero Maggiore in occasione del giuramento di fedeltà dovuto dai rustici alla badessa[111]. Il 25 novembre 1210 il Monastero Maggiore entrò in un contratto di vendita con alcuni esponenti della famiglia de Giussano per mezzo del quale avrebbe ceduto alla stessa tutti i suoi possedimenti e diritti giurisdizionali nei territori di Arosio, Bigoncio, Cogliate, Romanò, Guiano, Pozzolo, Brenna e Cremnago. Il 26 febbraio 1214 il Monastero riacquistò gli stessi possedimenti restituendo la caparra alla famiglia de Giussano. La dottoressa Elisa Occhipinti, docente di Storia Medievale dell’Università degli Studi di Milano, avanzò l’ipotesi che il negozio giuridico tra il Monastero e i de Giussano fosse fittizio, e che servisse invece a delegare ai potenti de Giussano il compito di imporre ai distrittabili l’onere di rifacimento del castello di Arosio[112]. I de Giussano in Arosio mantennero il controllo della carica podestarile in modo continuativo dal 1216 per oltre cinquant’anni[113]. Nel 1217 a Milano Ambrogio da Giussano venne nominato Rector per conto del Monastero ed alle dirette dipendenze della badessa Vittoria Cotta, esponente dell’omonima famiglia di antica nobiltà[114]. Ser Rodolfo de Carugo, “personaggio eminente”[115] di “cospicua origine”[116] potrebbe aver detenuto la carica di console[117].
All’elezione a badessa di Mattea Pirovano nel 1235, seguirono quelle di Agnese dell’Orto nel 1261, Pietra Osii nel 1277, e di Belengeria della Torre del 1298, succedendosi così alla guida del Monastero Maggiore solo esponenti di famiglie filo-torriane appartenenti alla fazione popolare[118]. Queste condussero una politica di acquisizioni caratterizzata da obiettivi politici, più che economici, e mossa principalmente dall’interesse al controllo del Castello di Arosio come luogo di potere[119]. Venne trascurato l’antico approccio gestionale inclusivo delle famiglie nobili locali, per adottarne uno oltranzista ed irrispettoso del diverso stato giuridico che distingueva i rustici distrittabili, dai nobili, sui quali il monastero non aveva giurisdizione. Fino al 1251, gli statuti promulgati dal Monastero, con la formula “convocatis prius vicinis ipsorum locorum”, specificavano nel proemio che ad essere convocati furono i soli vicini. Emessi nel 1282 i nuovi statuti dalla badessa donna Pietra Osii, venne ufficializzata l’intenzione di piegare le famiglie nobili locali alla giurisdizione del monastero, sostenendo che quest’ultima fosse “super hominibus tam nobillibus quam vicinis”[120]. Questo nonostante una recente sentenza del giudice ed assessore del podestà di Milano avesse chiaramente ribadito che il comune nobilium di Arosio non fosse sottoposto alla giurisdizione del Monastero, in quanto la superiore condizione giuridica dei nobili aveva precedenza sulla territorialità dei diritti di signoria[121]. Con tale sentenza del settembre 1270, Rainaldo Salimbene, giudice ed assessore del podestà di Milano, ad istanza dei nobili, vietò ai popolari di usare forza, di associarsi o congiurare contro i nobili, vietò inoltre a questi di astenersi dal servire i nobili, o dall’aiutarli o dal non comprare i loro beni. Infine, pose il divieto a che si usino i pascoli e i boschi dei nobili. I nobili in questione furono Boneto e Dolzeto (Dolcetto) de Carugo, figli del fu ser Rodolfo de Carugo. Nella contesa la pars popolare si definisce quale “comune vicinorum” e “comune loci de Aroxio”, mentre i secondi, definendosi unicamente quali nobiles, ed avendo nella sentenza confermata la propria superiorità giuridica, formavano di fatto come “uno stato nello stato”[122]. Non si può nemmeno affermare che la sentenza del Salimbene avesse carattere di novità nel panorama normativo dell’epoca, se già nel dicembre 1183 il giudice e console milanese Eriprando diede ragione ad alcuni esponenti della nobile famiglia de Canturio (Cantù), allorquando questi si rifiutarono di sottostare alle condiciones del Monastero[123].
Le frequenti controversie che afflissero il territorio di Arosio e che interessarono da una parte i nobili locali, e dall’altra il Monastero Maggiore, sono ascrivibili ai conflitti di carattere giurisdizionale tra fazioni avverse tipici del periodo comunale. Tuttavia, tali tensioni affondano le proprie radici in una fase anteriore, poiché le dispute relative all’esazione delle decime risultano attestate già prima dell’avvento dell’assetto comunale e si protrassero per un lungo arco di tempo: dall’acquisizione delle terre arosiane da parte del Monastero Maggiore, avvenuta nel 1134 per cessione della famiglia Cani, sino almeno al 1192. Ancora in quell’anno, infatti, Nazario de Carugo, chiamato a testimoniare in merito alla questione, dichiarava che “habebat plebs de Marliano decimam in ipso loco que vocabatur quarta”, precisando così che un quarto delle decime spettava alla chiesa pievana, mentre la parte restante alla famiglia capitaneale dei Visconti, o per loro conto agli stessi Cani[123a]. Con l’avvento del dominio visconteo a Milano, cominciò per il Monastero un periodo di crisi e declino. La badessa Belengeria della Torre venne esautorata e si ritirò in esilio a Como. Al suo posto venne nominata nel 1320 Marina Visconti[124].
L’analisi dei carteggi tra i nobili possidenti locali ed il Monastero Maggiore, permette d’individuare i principali nuclei familiari de Carugo “possessori di terre, conduttori di beni di enti diversi, ma anche rappresentanti delle istituzioni locali”, esponenti cioè del “corpo della nobiltà del contado”[125].
Ser Rodolfo de Carugo, detto “Gallia”[126], già abate della potente abbazia benedettina di San Pietro al Monte presso Civate, quindi vassallo diretto dell’imperatore, morì tra il 1244 ed il 1249[127]. Ebbe almeno quattro figli: ser Forzanus de Carugo, Giacomo, Boneto e Dulce, quest’ultimo anche detto “Dolcetto” o “Dolzeto” a seconda delle fonti. Ser Forzano ebbe almeno tre figli: Martino, Giacomo e Guglielmo de Carugo. Il 14 aprile 1202 gli esponenti di due fazioni avverse ed in lotta tra loro firmarono una tregua e giurarono fedeltà alla badessa del Monastero Maggiore ed al suo messo Ottone de Giussano. Il giuramento avvenne di fronte a Martino, Giacomo, e Guglielmo di ser Forzano de Carugo, ed a Leone, Manfredo e Bulgaro de Carugo, anch’essi membri della famiglia de Carugo e probabilmente imparentati con ser Forzano ed i suoi figli[128].
Il 25 febbraio 1235 Nazario Pirovano, a nome del Monastero Maggiore, concesse in locazione a Dolcetto figlio di ser Rodolfo de Carugo tutte le terre, i prati, le selve e i boschi che un tempo avevano tenuto Soldano de Carobio ad Arosio e nelle località vicine[129].
Nell’agosto del 1239 la badessa Mattea Pirovano, per tramite del suo procuratore Giacomo de Colzago, ammonì ser Rodolfo de Carugo, Ambrogio Tanzii e tutti i nobili e vicini di Arosio, che se non avessero rinunciato alla loro volontà di eleggere il nuovo cappellano delle chiese di Arosio, in contrasto con la nomina già indicata dalla badessa, questa si sarebbe appellata all’arcivescovo di Milano, al legato pontificio o addirittura direttamente al Papa[130].
Il 23 gennaio 1243 si evidenziano gravi liti pendenti presso i consoli di Milano tra il Monastero Maggiore, e ser Rodolfo de Carugo ed uno dei sui figli[131].
Mercoledì 15 settembre 1249 i fratelli Giacomo, Dolce, Forzano, ed il loro nipote Castellino de Carugo, perfezionarono tre contratti di permuta con la badessa Mattea Pirovano. Nel primo documento si specifica che la badessa diede ai figli di ser Rodolfo undici appezzamenti di terreno ed in cambio ottenne una “pecia” di terra situata nel comune di Arosio ed una “pecia” di brughiera di dieci pertiche[132]. Dal secondo atto emerge che gli stessi fratelli abitavano già a Casate nei pressi di Arosio. In questa occasione la badessa diede ai figli di ser Rodolfo undici appezzamenti di circa ventotto pertiche ed in cambio ottenne due “peci” di terra, per un totale di ventinove pertiche. In entrambi gli atti, ser Gregorio e ser Enrico de Gluxiano compaiono come proprietari di beni confinanti[133]. In base al terzo ed ultimo atto perfezionato il 15 settembre 1249, “Giacomo, Dolce e Forzano de Carugo, figli del defunto ser Rodolfo de Carugo, agenti per sé e per loro nipote Castellino, effettuano un cambio con la badessa del Monastero Maggiore di Milano, la quale ricevette alcune pecie di terra e di brughiera situate nel territorio di Arosio e di proprietà del solo Giacomo, ottenendo tutti e tre di essere investiti a massaricio di alcuni detti appezzamenti. I figli del defunto Petracio de Gluxiano sono documentati quali proprietari di beni confinanti”[134]. Alle prime due trattative, i fratelli de Carugo sono accompagnati da un notaio anch’esso appartenente alla stessa famiglia: Guglielmo Rubeo de Carugo.
Dolce de Carugo, figlio del fu ser Rodolfo, compare quale testimone in un atto di permuta tra il Monastero Maggiore ed alcuni membri della famiglia de Gluxiano (Giussano) datato venerdì 27 marzo 1254 “in castro loci de Aroxio”[135]. Anche suo fratello Giacomo de Carugo presenzierà in qualità di testimone in due atti tra il Monastero Maggiore e la famiglia Giussani, entrambi risalenti a mercoledì 8 luglio 1254, ed anch’essi rogati presso il castello di Arosio[136]. In uno dei due atti fu presente il pronotaro Ugo Iudex de Carugo del luogo di Arosio.
Trascorso circa un mese dalle vicende che incomberono sulla famiglia Giussano, nelle giornate del nove e dieci settembre del 1254, Forzano de Carugo figlio del fu Ser Rodolfo de Carugo, compare quale testimone o possidente di proprietà limitrofe in quattro degli otto atti di sequestro indetti per conto del Monastero Maggiore di Milano, su ordine di Giacomo Guarino, giudice e assessore del podestà. Il nove settembre, Brocardo de Cantono servitore del comune di Milano, immette Ruggero de Pirovano procuratore del monastero in possesso di un sedime nel luogo di Arosio di proprietà dei fratelli Pietro Giovannibello e Ugone Isembardi, accusati d’esser debitori del Monastero. Nello stesso giorno, sempre in Arosio, il monastero requisisce l’abitazione di Alberto de Castello e un sedime di proprietà dei fratelli Vicinolo e Gerardo detti de Lambrugo, tutti accusati d’esser debitori del monastero. Infine, il giorno successivo il sequestro è posto sulle proprietà di Dusio de Carubio confinanti con quelle di alcune delle famiglie facenti parte della consorteria. Infatti, nel descrivere i confini delle terre sequestrate, si fa menzione dei possidenti limitrofi, i quali includono lo stesso Forzano de Carugo, la famiglia Casati nella persona di Guidonis de Cassate figlio di ser Rugerio, nonché la famiglia Giussani con ser Tommaso de Giussano, possidente, già coinvolto nelle vicende sopradescritte, e domini Leonis de Gluxiano de loco Gluxiano tra i testimoni[137].
In questo contesto di conflittualità e di ingerenza da parte del Monastero Maggiore, Forzano de Carugo chiamò alle armi gli uomini di Carate e capitanò l’attacco armato al castello di Arosio. Preso possesso del castello, corsero il borgo ed assaltarono la casa del rappresentante del Monastero Maggiore. Minacciato di morte il gastaldo, sequestrarono il bestiame e si allontanarono indisturbati[138].
Fu forse anche grazie al proprio intervento manu armata che Ser Forzano de Carugo assistette nelle vesti di testimone in un atto risalente a domenica 2 gennaio 1256, per tramite del quale Rainaldo de Carrobio di Arosio, gastaldo del Monastero Maggiore di Milano, fece delle concessioni ai consoli di Arosio e Bugonzo[139]. Ad ogni modo, negli anni che seguirono le stesse tensioni emersero nuovamente. Lunedì 29 marzo 1260, ser Forzano agirà sempre in qualità di testimone in un atto di requisizione da parte del Monastero Maggiore di Milano, il quale richiese che Anselmo de Carugo e suo fratello Alberto, entrambi figli di ser Ruggero de Carugo, restituissero alcune “pecie” di terra collocate in Arosio per un totale di circa quarantatré pertiche[140]. Anselmo de Carugo ebbe lunghi rapporti con il Monastero Maggiore, per il quale fu testimone in un interessante atto d’investitura risalente a lunedì 10 marzo 1214, nel quale si menziona il fatto che il Monastero avesse recentemente riacquisito la propria signoria sul territorio di Arosio come risultava “dall’instrumentum di vendita fatto dalla Badessa ad Onrico e Iacobo de Gluxiano”[141].
Il 21 novembre del 1262, alla presenza di Ruggero Marcellino console di giustizia di Milano, per conto di Pietro, cappellano della chiesa di S. Nazaro di Arosio, Beltramo Caginosso, servitore del comune di Milano, riferisce di essersi recato presso Carugo alla dimora di Gasparini Petriniati de Carugo e di Girardi de Carugo per sequestrarne i beni, essendo essi accusati d’esser debitori della stessa chiesa, ma di non aver potuto procedere causa loro assenza. Ugualmente accusato fu anche Benazii de Casati dimorante alla Cassina de Cassate[142].
Il notaio Bellotto de Carugo figlio di ser Imblanado, nella giornata di domenica 5 aprile 1243 “in platea”, alla presenza dei servitori del Comune di Milano, redò le disposizioni ai consoli e a tutti i vicini del luogo di Arosio “per riattare e fare manutenzione al fossato ed al muro del castello”.
Un ultimo atto risalente a venerdì 26 aprile 1247 identifica due ulteriori nuclei familiari: Beltramo de Carugo e suo fratello, figli di ser Giordano (Yordanus) de Carugo; e Guido de Carugo figlio di ser Borgarius in qualità di testimone. Riunito l’intero capitolo del Monastero Maggiore, Beltramo diede alla badessa Mattea sei appezzamenti di terra di circa ventidue pertiche situati ad Arosio, ed in cambio ne ottenne nove di circa quarantaquattro pertiche collocati a Pozollo[145].
Nel 1262 Tommaso de Giussano risulta bannito dal monastero[146].
A partire dal 15 maggio 1271, Castellano de Carugo, abitante a Incasate, ebbe numerose controversie giurisdizionali con la badessa Agnese dell’Orto “occasione honoris et districtus”. Le liti si trascinarono per svariati anni, finché nel 1276 l’arbitro Francesco dell’Orto intimò Castellano de Carugo a non contestare la giurisdizione della badessa. Il fatto che Francesco dell’Orto prese le parti della badessa non dovette sorprendere essendo questi stretti da legami di parentela[147]. L’11 novembre 1286 Castellano de Carugo vendette al Monastero Maggiore un sedime con edifici, aia, corte e orto nel territorio di Arosio per 19 lire di terzoli[148].
Nel 1273 ser Guido de Carugo, abitante a Milano nei pressi di porta Comacina, fece ricorso ad Aliprando Visconti, vicario generale dell’Arcivescovo di Milano, affinché condannasse la badessa del Monastero Maggiore a restituirgli la propria casa nel Castello di Arosio[149]. Ser Guido sembrerebbe esser deceduto in quello stesso anno, lasciando la propria casa al figlio Repollo[150].
Il Monastero di San Vittore di Meda
Il 12 giugno del 1277 nei pressi di Pozzolo Inferiore situato tra i territori di Cascina La Guardia e Brenna, alla presenza di Ansaldo de Aviano giudice ed assessore del podestà di Milano, Azone de Marnate, servitore del comune, riferisce di essersi recato a seguito della petizione della Badessa del Monastero di Meda, a stimare e sequestrare le rendite delle terre di proprietà dei fratelli Ruggero ed Anselmo de Carugo, figli di Ianuarii de Carugo, accusati d’esser debitori nei confronti dello stesso monastero. Iacobum de Brena, “loco potestatis loci de Brena”, ossia signore di Brenna, ed il Console di Pozzolo Inferiore Iacobino de Carugo si rifiutano di eseguire quanto intimato dal giudice di Milano, ossia di consegnare al Monastero di Meda le rendite requisite dalle terre appartenenti ai fratelli de Carugo. Una simile intimazione fu consegnata anche al Console di Monticello Guidotum de Carugo. Trascorsi tre giorni, continuando Iacobum de Brena e Iacobino de Carugo a rifiutarsi di collaborare, essi vengono multati dal comune di Milano. Negli stessi giorni il monastero di Meda è in contradditorio anche con la famiglia dei Della Torre, accusati di usurpare i diritti del monastero sul comune di Nobile, da essa sottratti con la forza al tempo della battaglia di Desio[151].
Il Monastero di Sant’Apollinare
Il monastero femminile di Sant’Apollinare in Milano rappresenta una delle più antiche fondazioni monastiche cittadine del primo Duecento, sorto nell’area orientale della città, lungo l’asse dell’attuale via Sant’Eufemia–Santa Sofia, per iniziativa dell’arcivescovo Enrico Settala intorno al 1222–1224, su istanza di compagne della beata Agnese, sorella di santa Chiara d’Assisi, ed è tradizionalmente considerato il primo monastero femminile milanese a professare stabilmente la regola francescana in forma claustrale. Ad esso furono progressivamente aggregati i beni del monastero femminile di osservanza agostiniana del Comune di Oreno, attestato nelle fonti duecentesche nella forma Opreno[151a], ove emerse una controversia tra Sant’Apollinare e la comunità locale, commune nobilium et vicinorum, a risolvere la quale il 30 maggio 1292 venne inviato, in nome dell’arcivescovo Ottone Visconti, il vicario generale Omiabene, canonico della chiesa di Ravenna. Nel suo intervento nominò esplicitamente i principali esponenti dell’élite locale, rivolgendosi formalmente “ai diletti in Cristo Ariberto de Opreno e Apoldo Lanzono, consoli dei nobili e dei vicini del predetto luogo di Opreno”, nonché a “Guiberto de Opreno, Giovanni detto Brigata, Tantino de Carugo, […] consiglieri di quel luogo” (la famiglia de Opreno è attestata fin dal 1198 tra i capitanei e i valvassori del territorio milanese). Dal testo emerge che i consoli e i consiliari di Oreno esercitavano pienamente il controllo sulle proprie terre, in quanto espressione di un potere legittimo fondato sullo status nobiliare e sull’autonomia comunitaria, ma intervenivano anche sulle terre del monastero, compiendo atti quali l’espulsione del massaro monastico, l’interdizione del lavoro agricolo, l’abbattimento di alberi e vigne, il danneggiamento di raccolti e case, l’imposizione di fabula – ossia divieti e ordini informali – e, più in generale, l’impedimento della gestione ordinaria dei fondi monastici; comportamenti che presuppongono un controllo di fatto sul territorio nel suo complesso, non limitato alle sole terre comunali o private, ma esteso anche ai beni ecclesiastici presenti nel distretto. Il vicario generale minacciò la nobiltà rurale di scomunica e di interdetto territoriale[151b]; in questa prospettiva, il rifiuto dei nobili e notabili di Oreno di riconoscere la giurisdizione del monastero di Sant’Apollinare appare strutturalmente analogo ad altre controversie note nel territorio brianzolo e milanese, come quella che coinvolse la famiglia de Carugo nei rapporti con il Monastero Maggiore di Milano.
Infine il 27 gennaio del 1309, Anrighino de Carugo figlio di Maffeo de Carugo abitante in Casate abiura di fronte all’inquisitore per eresia e gli viene imposta la pena delle croci[152].
Napo Torriani in ginocchio implora la pietà del vescovo Ottone Visconti raffigurato a cavallo. Sullo sfondo gli scontri armati tra cavalieri e fanti della Battaglia di Desio. Ciclo di affreschi della Sala di Giustizia, Rocca Borromea di Angera (Varese).
La lotta per il dominio su Milano tra i Visconti e i Della Torre segnò, con la vittoria dei primi, la fine dell'esperienza comunale a Milano e l'inizio dell'epoca delle signorie. Nel gennaio del 1277, i de Carugo, così come le altre famiglie appartenenti alle consorterie del contado, acerrime nemiche dei regimi di popolo, entrarono trionfatrici in città al seguito dell’arcivescovo Ottone Visconti[153].
Con l’avvento dei Visconti, i de Carugo riuscirono finalmente ad introdursi stabilmente nelle sfera politica, economica ed accademica milanese, conquistandosi e mantenendo per secoli ruoli di grande prestigio. Alcuni rami della famiglia ebbero anche ragguardevole successo nella mercatura, affermandosi sia a Milano che oltre i confini del ducato, in particolare nei territori dell’attuale Svizzera, Austria e Francia (Lione).
Complessivamente, questi furono i secoli nei quali la famiglia de Carugo, originariamente ascrivibile a quella nobiltà rurale del contado strettamente legata ai valori ed alle prospettive dell’antica nobiltà feudale, divenne gradualmente una famiglia patrizia cittadina dalla nobiltà decurionale (consolare). A suggello della sua nuova identità, il 20 aprile 1377 la famiglia de Carugo venne ascritta nella Matricula nobilium familiarum Mediolani, ossia nella lista delle duecento famiglie patrizie milanesi per le quali era stabilito il diritto esclusivo all'Ordinalato della Metropolitana di Milano.
I primi membri della famiglia de Carugo ad essersi trasferiti nella città di Milano sembrerebbero essere stati ser Guido de Carugo e suo figlio Repollo, che in un atto del 1273 sono registrati nei pressi di porta Comacina: “qui modo habitat in civitate Mediolani, in burgo porte Cumane”[154].
E fu così che "el locho da Carugo", borgo dal quale ebbero il nome e l’antica origine, e del quale furono per secoli feudatari, sfuggì al controllo famigliare, e a partire dal 1450 venne sottoposto alla giurisdizione del Vicariato di Mariano[155], poi affidato alla famiglia Marliani, ed infine infeudato a Lucia Marliani, cortigiana ed amante del duca Galeazzo Maria Sforza, con atto d’investitura del 13 giugno 1476[156].
Si elencano di seguito solo alcuni dei molteplici personaggi notabili della nobile famiglia de Carugo, in ordine cronologico e, ove vantaggioso, raggruppati per contesto, fonte, posizione sociale o professione.
Membri dell’Ordine sacro e degli Ordini Monastici: secoli dal XIII al XVI
Il presbitero Francinus de Carugo il 14 giugno 1296, convocato e congregato l’intero Capitolo dall’Arciprete del Duomo di Monza, Avvocato degli Avvocati, e viste le sue qualità di uomo sapiente e discreto, è eletto a capo di tutta la “Decumania” monzese, nonché destinatario di tutti i benefici ad essa pertinenti[157]. La leggenda vorrebbe che a distanza di quattro anni dalla sua nomina, nel 1300, s. Elisabetta e la regina Teodolinda apparvero al chierico Franzio de Gluxiano, ossia ad uno dei preti della stessa decumania, mostrandogli ove rinvenire antiche reliquie[158].
Il 14 agosto 1346, Johanolus de Carugo, in considerazione della propria età avanzata, lascia spontaneamente la propria posizione quale Ministro dell’Ospedale San Bernardo del Terzo Ordine degli Umiliati di Monza[159]. L’8 febbraio 1378 Franzolino de Carugo è frate presso lo stesso ente[160].
Romirolo da Carugo intorno al 1390 fu rettore dell’Ospitale di S. Damiano, ossia del pio istituto limosiniero, anche detto Hospitale Pauperum, pertinente alla Chiesa di San Damiano di Milano. Venne sostituito dal prete Coradosio Foppaa nel 1400 circa[161].
Il 25 gennaio 1435 Papa Eugenio IV per sua volontà ordina che Domina Caterina de Carugo, già Madre Monaca del Monastero Senator di Pavia, “d'ottima e santa vita”, sia trasferita a Piacenza e consacrata prima Badessa del Monastero di San Girolamo[162].
Georgio de Carugo “uomo nobilissimo” appartenente al Monastero di San Celso in Milano, il 3 marzo del 1461 si oppone al decreto dell’arcivescovo per la demolizione della chiesa di Santa Tecla[163].
In una lettera del 16 novembre 1458, figura Paolo Carugo presbitero della diocesi di Milano presso la canonica di San Bartolomeo extra muros (Milano)[164].
Infine, nel 1488 Anastasia de Carugo è Superiora del Capitolo del Convento femminile di S. Domenico di porta Ticinese, parrocchia di S. Michele ad Clusam, presieduto dalla Priora Elisabetta de Cerutis[165]. Nel 1495 papa Alessandro VI stabilì il passaggio del convento alla cura degli osservanti della basilica e santuario di Santa Maria delle Grazie[166], ove negli stessi anni Leonardo da Vinci realizzava nel refettorio dell’adiacente convento, su commissione di Ludovico il Moro, il dipinto parietale rappresentante l’Ultima Cena.
Famigliari Ducali
In una sua missiva del 22 novembre 1368, Galeazzo II Visconti si lagna coi fratelli Guido e Ludovico Gonzaga, Signori di Mantova, dei mali trattamenti usati a un mercante monzese in Mantova. Per risolvere la questione, invia presso la corte dei Gonzaga Raynerium de Carugo, famigliare ducale, raccomandandone la piena fiducia[167].
Il duca di Milano Filippo Maria Visconti il 7 luglio 1425 ordina al famigliare ducale Bernardo da Carugo di recarsi urgentemente presso Cristoforo da Lavello, condottiere d’armi al servizio del duca di Milano, appartenente alla nobile famiglia dei Capitanei de Lavello, affinché egli si rechi al più presto con i propri associati a supporto delle operazioni militari viscontee in Romagna. La rivalità tra Cristoforo da Lavello e Francesco Sforza rendeva difficile a Filippo Maria Visconti la scelta di un comandante delle truppe milanesi in Romagna, in quanto Cristoforo non era disposto a rimanere al servizio milanese se la scelta fosse caduta sullo Sforza[168].
Il 25 giugno 1426 Bernardo da Carugo riceve copia delle lettere ducali attestanti la sua posizione di famigliare ducale presso la corte di Milano e gli ordini che esso deve trasmettere nelle diverse città del ducato, per sollecitare la requisizione di fanti ed il loro celere invio a Brescia. Gli ordini del duca di Milano sono categorici: “A Bernardo da Carugo obbediscano circa quanto imporrà per un più celere soccorso del campo”. Il da Carugo presentò le sue lettere a Como il primo luglio[169].
Da un documento conservato presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana sappiamo che l’8 febbraio 1444 Dominus Giovanni de Carugo, detto “Zanono”, nobile notaio residente nei pressi della parrocchia di Santo Stefano in Nosiggia, si obbligò nei confronti del mercante-banchiere milanese Stefanino Taverna, figlio di Marco Taverna, congiuntamente al proprio parente Cristoforo de Carugo, figlio di Ambrogio [170]. Nel mese di marzo del 1450, Francesco Sforza estese compensi e benefici a coloro che appoggiarono la sua ascesa al potere; in questo contesto, Giovanni de Carugo il 6 marzo venne eletto a capo dell’Ufficio delle Vettovaglie con la carica di Giudice[171]- Non sorprende pertanto che di lì a pochi giorni, l’11 marzo 1450, Giovanni de Carugo presiedette all’Assemblea Generale che ratificò il definitivo passaggio dei poteri nelle mani di Francesco Sforza[172]. Negli anni che seguirono, l’influenza di Giovanni de Carugo presso la corte sforzesca dovette indubbiamente consolidarsi. Attorno al 1458 infatti, Giovanni appare nelle vesti di famigliare ducale nelle memorie del pellegrinaggio in Terra Santa compiuto dal marchese di Castelnuovo Scrivia Roberto Sanseverino d’Aragona, condottiero al servizio degli Sforza. In particolare, D. Giovanni de Carugo in quel tempo servì come emissario di Roberto di Sanseverino presso la corte sforzesca[173]. Non riuscendo ad incontrarsi direttamente presso Palazzo Foscari a Venezia, D. Giovanni de Carugo riesce comunque a confermare, per tramite di Marchese da Varese, ambasciatore di Francesco Sforza a Venezia, “del bene stare de li presati Ill.mi S.re Duca de Milano, M.na Duchessa et soy figlioli et cossi de tutti quelli de loro case”[174].
Grecininus de Carugo e Paullinus (Paolino) de Carugo sono menzionati negli elenchi dei famigliari della corte ducale di Milano per l’anno 1408[175]. Grecininus figura nella lista de “Nobiles familiares et officiales de Curia nostri illustrissimi principis”, ossia dei nobili familiari e ufficiali della curia degli illustrissimi principi, quindi sembrerebbe essere al seguito sia del duca Giovanni Maria Visconti che della duchessa Antonia Malatesta di Cesena. Paolino invece sembrerebbe essere specificatamente al seguito della sola duchessa, essendo egli trascritto nel registro de “Nobiles familiares et officiales commorantes in Curia Illustriss. Et Eccellentiss. Dominae Ducisse Mediolani”, ossia nel registro dei nobili familiari e ufficiali residenti presso la corte dell’illustrissima ed eccellentissima duchessa di Milano[176]. Lo stesso Paolino de Carugo il 28 giugno del 1400, vendette alla duchessa di Milano Caterina Visconti, madre di Giovanni Maria, una casa in Pavia nella parrocchia di San Pietro al Muro per duecento fiorini aurei[177]. L’atto di vendita fu rogato da Giovanni de Oliariis, il più importante tra i notai viscontei, il quale ebbe l’onore di trascrivere le ultime volontà del duca.
Signori del Tribunale di Provvisione
Guglielmolo de Carugo nel 1391 venne nominato dal Signore di Milano Gian Galeazzo Visconti tra i Dodici Signori del Tribunale di Provvisione. Il Tribunale di Provvisione venne creato dall’arcivescovo Ottone nel 1277 e costituiva il più alto centro direttivo della città e del ducato con competenze in fatto di ordine pubblico, vettovagliamento, regolamentazione delle attività economiche, politica tributaria e assistenza pubblica, alle dirette dipendenze del Signore e poi duca di Milano[178]. Da un atto del 12 gennaio 1369 sappiamo che Guglielmolo era figlio di Beltramo de Carugo e fece procuratore suo fratello Giovannolo[179]. Giovanni de Carugo, figlio di Guglielmo, attorno alla metà del Quattrocento si spostò “in loco Castellino Plebis Incini” ossia a Caslino d’Erba, in provincia di Como, ove operò in qualità di notaio[180].
Ambasciatori e Vicari
Il 5 gennaio 1305, il conte Filippone di Langosco, governatore dei Milites, del Popolo e dei paratici di Pavia, assieme al proprio vicario Morando Carugo, al proprio sindaco e procuratore Francesco Oltrana, e al podestà Giovanni Battista, sottoscrissero un compromesso con Federico di Armellina, procuratore di Bochacio da Cairo, podestà di Dertona (Tortona)[181].
Nel 1337 il conte Aimone di Savoia acquistò dal Vescovo d’Ivrea i diritti signorili di sua spettanza su parte del Monferrato[182]. Vennero così a crearsi delle tensioni tra Ivrea e la viscontea Vercelli per il controllo di Piverone e Palazzo. La pericolosa contesa venne risolta tra il 6 ed il 15 maggio 1337 grazie agli incontri tra i rispettivi ambasciatori: uno dei due ambasciatori incaricati a trattare a nome del Signore di Milano Azzone Visconti e del Comune di Vercelli fu Druetto de Carugo[183]. Suo figlio Masiolus de Carugo nel 1350 fu Notaio Imperiale.
Podestà
Nel secondo Quattrocento, località come San Colombano al Lambro, Guastalla e Casalmaggiore esemplificano come il Ducato di Milano organizzasse il proprio controllo politico, giudiziario e militare nei territori di frontiera. In questi centri – diversi per storia istituzionale ma accomunati da una forte presenza dell’autorità ducale – le funzioni chiave erano regolarmente affidate a ufficiali di provata fiducia. In tale contesto si colloca la presenza di esponenti dei de Carugo, antica famiglia lombarda del patriziato milanese, inserita nel circuito delle magistrature ducali – fra cui quella podestarile – e impiegata nei centri politicamente più esposti del dominio visconteo-sforzesco. Giovanni de Carugo, detto “Zanone”, è attestato come podestà di San Colombano al Lambro già dall’aprile del 1478[184], in un contesto in cui il locale castello – riconosciuto come presidio di primo piano già dai Visconti – aveva alle spalle una storia secolare di importanza strategica. Il sito, infatti, dominava fin dall’antichità i principali assi viari e fluviali della regione: le vie commerciali romane, i collegamenti tra Milano, Pavia, Lodi e Piacenza, e il sistema dei fiumi Lambro, Adda e Po. Questa combinazione di elevazione naturale, controllo dei transiti e continuità insediativa rese la collina un punto di osservazione e difesa cruciale fin dall’epoca pre-romana, rafforzato nel 1034 dal castello di Ariberto d’Intimiano e poi rifondato dall’imperatore Federico Barbarossa nel 1164.
La successiva ricostruzione viscontea del XIV secolo consolidò definitivamente il ruolo del castello come uno dei più vasti apparati difensivi dell’Italia settentrionale: un complesso articolato, paragonabile per ampiezza alle rocche di Pavia e Milano, con doppia cinta muraria, oltre diciassette torri e un ricetto abitato, nodo dinamico tra giurisdizione civile, fiscale e militare. Non sorprende, quindi, che la Signoria viscontea e poi quella sforzesca vi mantenessero un controllo serrato, investendo costantemente nella manutenzione delle strutture e nella selezione degli ufficiali preposti alla podesteria.
In questo quadro s’inserisce pienamente la figura del podestà Giovanni de Carugo. La torre de’ Gnocchi, sede del podestà e del suo vice per tutto il Quattrocento e oltre, era al tempo stesso abitazione del magistrato, luogo di riunione del consiglio comunale e spazio di raccordo tra il potere ducale, gli interessi del Comune e le prerogative dei certosini, proprietari dell’immobile. Le frequenti dispute relative alla proprietà, ai diritti d’uso, alla gestione della parte superiore della torre e alle sue funzioni in caso di guerra rivelano quanto la struttura, ed il suo apparato podestarile, fossero fondamentali al fine di garantire la stabilità di un territorio conteso e militarmente vitale[184a].
Castello di San Colombano, veduta della Torre de’ Gnocchi, nucleo più antico del castello e residenza del podestà Giovanni de Carugo.
Di Iolanda Pensa - Opera propria,
CC BY-SA 3.0,
From Wikimedia Commons Date 2022 Feb. 27
La stessa logica si ritrova a Guastalla, centro strategico lungo il Po la cui importanza politica si consolidò a partire dal Trecento, quando i Visconti investirono i Torelli del titolo comitale. La contea, pur territorialmente ridotta, occupava una posizione di grande valore: frontiera naturale tra le sfere d’influenza di Mantova, Parma, Reggio e Milano, crocevia dei traffici fluviali e terrestri della pianura padana e punto di controllo dei guadi più sensibili del Po. Il castello, ampliato e fortificato in più riprese, custodiva non solo la residenza comitale, ma anche il cuore amministrativo e giudiziario del territorio. Luigi de Carugo fu eletto Podestà di Guastalla nel 1480, ed in quanto tale fu garante dell’ordine pubblico, della giustizia e delle relazioni formali del conte con Milano, assumendo così un ruolo cruciale in un territorio soggetto a forti pressioni esterne. Nel 1483, nell’ambito del conflitto tra i Torelli, conti di Guastalla, e Rossi di Parma, si distinse nell’efficace custodia e monitoraggio delle vie e dei passi, impedendo così per mesi l’avanzata dell’esercito veneziano alleato dei Rossi [185]. L’efficacia della sua azione risulta tanto più significativa se si considera che il Po, in quell’area, costituiva uno dei corridoi operativi più esposti agli attacchi e alle manovre degli eserciti impegnati nello scacchiere padano [185a].
L’esperienza maturata nella difesa territoriale si riflette anche nel ruolo diplomatico che Luigi esercitò negli anni successivi. Il 9 gennaio 1500 il conte di Guastalla Achille Torelli inviò il Podestà Luigi de Carugo, scortato dal condottiero Jacopo Cignacchi, in qualità di suo ambasciatore presso la Serenissima Signoria di Venezia, al fine di stringere un’alleanza militare e di definirne i dettagli. La missione si collocava in un momento delicatissimo, a tre mesi dall’inizio dell’assedio di Novara, nel quale Ludovico Maria Sforza verrà poi catturato dai francesi. Il Podestà Luigi de Carugo, a nome del conte Torelli, si impegnò ad inviare rinforzi alla Repubblica di Venezia.[186]
A Casalmaggiore, infine, l’ordinamento comunale conferma l’inserimento diretto della comunità nella sfera milanese: il podestà inviato da Milano esercita giurisdizione civile e criminale sulla terra e sulle ville soggette, riceve giuramento dei consoli, abita in una casa fornita dalla comunità e interviene stabilmente nell’amministrazione locale. Questa struttura istituzionale, rigidamente ancorata ai modelli amministrativi del Ducato, spiega perché la comunità abbia potuto adottare o riprodurre lo stemma dei de Carugo, lo stesso registrato negli stemmari milanesi: un segno dell’autorità podestarile e della proiezione del potere ducale sul Po.
Considerati insieme, questi elementi delineano con chiarezza il ruolo svolto dai de Carugo come podestà ducali nei punti più sensibili dell’Italia padana tardomedievale. Da San Colombano a Guastalla e Casalmaggiore, la loro presenza non è episodica, ma parte integrante della politica milanese di controllo del territorio. [186a].
Stemma della famiglia de Carugo adottato dalla Comunità di Casalmaggiore. Una scelta dettata presumibilmente dall’influenza del loro podestà milanese esponente della medesima famiglia.
Fogli estratti dallo Stemmario Archinto, seconda metà del XVI secolo. Archivio Storico della Città di Lugano, Fondo del Patriziato di Lugano.
copyright ©CittàdiLugano
Cancellieri
Il cancelliere Francesco Carugo, il 6 ottobre del 1451, invia una missiva da Lodi per conto del conte Gaspare da Sessa, all’attenzione del duca di Milano Francesco Sforza[187].
I de Carugo di Valtellina
La genealogia del ramo valtellinese dei de Carugo fu oggetto di attento studio da parte del dott. Francesco Palazzi Trivelli, archivista presso l’Archivio di Stato di Sondrio e membro della Società Storica Valtellinese. Si delineano in questa sede, sulla base dei suddetti studi, le vicende e le discendenze di alcuni degli esponenti più illustri.
La Valtellina divenne parte dei domini viscontei attorno al 1335, allorquando il signore di Como Franchino Rusca cedette la sua signoria ad Azzone Visconti[188]. A caratterizzare il territorio un complesso sistema giurisdizionale ed un pluralismo di ordinamenti, sviluppatosi a partire dall’anno Mille, ed emblematico di diverse influenze spesso in competizione tra loro[189]. In particolare, si ebbero quelle esercitate direttamente dall’Imperatore del Sacro Romano Impero e dal vescovo di Como, il quale tra il 1004 ed il 1006, ricevette dall’imperatore Enrico II la metà del viscontato di Valtellina. A questi si sovrapposero le ambizioni del vescovo di Coira, nonché quelle pertinenti ai loro rispettivi vassalli locali: le signorie dei capitanei vassalli del vescovo di Como, i capitanei di Ardenno vassalli milanesi, l’avvocazia dei Venosta di Amazia vassalli del vescovo di Coira, ed il consortile dei vicedomini ad Ologno[190]. Tra le famiglie capitaneali vassalle del vescovo di Como, numerose in Valtellina furono quelle di origine comasca piuttosto che locale. Nell’arco dei secoli infatti, sia il vescovo che il Comune di Como videro nella subinfeudazione dei loro domini valtellinesi a cittadini comaschi un via per l’affermazione dei loro poteri e per l’estensione delle loro giurisdizioni[191]. Simile genesi ebbe la famiglia Quadrio di Ponte in Valtellina, nobile ed antichissima famiglia ghibellina originaria di Como e detentrice in Valtellina di privilegi imperiali[192]. Nel 1254 Prinzivallo di Quadrio fu il primo podestà di Ponte con giurisdizione sulla città e sulle terre circonvicine[193]. Stefano Quadrio, figlio di Gaudenzio, già podestà di Piacenza nel 1424, divenuto comandante delle milizie della Valtellina, nonché capo della fazione ghibellina in Valtellina[194], il 19 novembre 1432 soccorse gli eserciti del duca di Milano riportando una schiacciante vittoria contro i veneziani nella battaglia di Delebio[195]. Il ramo de Carugo di Valtellina sviluppò nell’arco di circa due secoli uno stretto legame di parentela con la famiglia Quadrio. Dalle fonti superstiti siamo a conoscenza di almeno dieci matrimoni contratti tra esponenti delle rispettive famiglie[196].
Con l’avvento dei Visconti in Valtellina vennero introdotte delle riforme amministrative per le quali i podestà locali vennero soppressi e sostituiti con un unico podestà di nomina ducale (anche detto giudice generale) con sede in Tresivio e direttamente dipendente dalla corte viscontea; il territorio venne suddiviso in tre terzieri, un terziere superiore dipendente da Tirano, un terziere di mezzo dipendente da Tresivio, ed un terziere inferiore con capoluogo Morbegno[197].
Nella prima metà del Quattrocento, Ser Dominus Gerolamo de Carugo, figlio dell’ufficiale ducale nonché consigliere e cancelliere Giovanni de Carugo, anche detto Giovannino o “Zanino”[198], si spostò da Milano in Valtellina, dando così origine ad un importante ramo oriundo.
Gerolamo de Carugo non fu però il primo membro della famiglia a risiedere in Valtellina. Attorno al 1370 tra i nobili che furono chiamati alle armi dal signore di Sondrio Tebaldo de Capitanei, figura anche “Tomaeus filius Magistri Bertrami de Carugo”[199]. Fu questa una rivolta guelfa contro i ghibellini Visconti, probabilmente istigata dal vescovo di Como Stefano Gatti od Enrico II di Sessa[200].
Ser Dominus Gerolamo de Carugo ebbe due figli: Ser Giacomo e Cristoforo. Cristoforo abitò a Sazzo, iniziò ad operare nelle vesti di pronotaio nel 1422, divenendo infine notaio nel 1424. Di maggior successo fu il percorso del primogenito Ser Giacomo, il quale operò come notaio tra il 1419 ed il 1437, venne eletto Decano nel 1436, ed ebbe in sposa Domina Masina Quadrio, esponente dei Quadrio di Ponte in Valtellina. In qualità di Decano, Ser Giacomo de Carugo fu capo del comune e rappresentante presso il consiglio di giurisdizione. Tutti i notai, in particolare allorquando questi detenessero rappresentanza politica, come nel caso di Ser Giacomo, venivano assegnati in base alla loro fazione d’appartenenza, della quale spesso ne furono i rappresentanti[201]. Ser Giacomo de Carugo fu particolarmente legato al capo della fazione ghibellina Stefano Quadrio, del quale fu procuratore anche nella trattative relative al rifornimento delle milizie ghibelline. Nel 1428 Ser Giacomo de Carugo fece pervenire a Stefano Quadrio “un arsenale costituito da bombarde, balestre, polvere per bombarde, verretoni, etc.”[202].
Oltre che per il suo coinvolgimento nella sfera politica e nell’attività notarile, le fonti registrano Ser Giacomo de Carugo tra i grandi investitori fondiari in Val d’Ambria, sulla quale focalizzò “un’intensa politica di acquisizione”[203] di terre agricole, pascoli e vigneti. Nel 1433 acquisì da Falconi d’Ambria una domus in muratura ed una in legno alle quali pertennero terreni, vigneti, frutteti, e boschi nel territorio di Tresivio Monte. A questa seguirono sei ulteriori acquisti, frequentemente reinvestiti a livello ai precedenti proprietari, i quali s’impegnarono a pagare a ser Giacomo de Carugo canoni in vino e formaggio[204]. Infine, in territorio di Tresivio Piano Ser Giacomo de Carugo ebbe un careaium in locazione dalla mensa vescovile[205].
Ser Giacomo de Carugo morì relativamente giovane intorno al 1440, lasciando sua moglie Masina Quadrio curatrice e tutrice dei loro cinque figli: Ser Pietro, Ser Antonio, Ser Geremino, Cristoforo e Giovanni. Ser Pietro de Carugo nacque intorno alla fine del 1430, divenne pronotaio e sposò Malgarita Venosta, figlia di Ser Marco Venosta, membro dell’antica e potente famiglia Venosta, infeudati di Mazzo, Bormio e Poschiavo da parte del vescovo di Coira[206]. Ser Pietro ebbe tre figli Dominus Gerolamo detto “Germino”, Dominus Giovanni Giacomo, e Modesto de Carugo. Dominus Gerolamo de Carugo nacque nel 1477 ed operò come pronotaio a partire dal 1503, divenendo notaio nel 1517. Operò in tale veste in una causa ecclesiastica tenutasi tra il 7 ottobre 1531 ed il 1534, discussa innanzi a Giovanni Giorgio de Paravicino vicario del vescovo di Como, tra il Comune di Postalesio e Bartolomeo da Salicibus, arciprete di Berbenno, in merito alla nomina di Giovanni Giacomo de Bonvicinis, fu Abbondio, di Fusine, a curato di Postalesio, a cui il suddetto arciprete opponeva il suo placet[207].
Sposò in seconde nozze Laura Quadrio, figlia di Ser Tristante Quadrio de Belora, e dalla loro unione proseguì il ramo dei de Carugo che attorno alla metà del Cinquecento diede il proprio nome ad una contrada del comune di Ponte, la quale per lungo tempo venne chiamata “contrada Carugo”, oggi nota col nome di Carolo. Presso la contrada Carugo sorge l’ “oratorium Sancti Joannis Baptistae Carughi”, meglio nota oggi come Chiesa di San Rocco, probabilmente sorta come cappella privata della famiglia de Carugo, i cui discendenti nel Novecento ne fecero dono alla parrocchia di Sazzo[208].
“Oratorium Sancti Joannis Baptistae Carughi”, meglio nota oggi come Chiesa di San Rocco, probabilmente sorta come cappella privata della famiglia de Carugo, i cui discendenti nel Novecento ne fecero dono alla parrocchia di Sazzo. Contrada Carugo (Carolo frazione del comune di Ponte in Valtellina - SO).
Immagine ottenuta tramite Google Maps, accesso il 3 dicembre 2024.
Cristoforo de Carugo nacque intorno al 1442, fu pronotaio a Buffetto intorno al 1458, ed operò come notaio dal 1460 al 1474. Nominò erede la sua unica figlia, Domina Giacomina de Carugo, la quale sposò Dominus Andrea Quadrio di Ponte, con il quale ebbe due figli.
Ser Antonio de Carugo, pronotaio nel 1442, notaio tra il 1450 ed il 1491, nel 1473 venne nominato Console di Giustizia nel segno dell’aquila. Ebbe tre figli: Ser Dominus Bartolomeo, Dominus Germino ed Antonio.
Ser Dominus Bartolomeo de Carugo, il quale fu pronotaio intorno al 1477 ed attivo come notaio tra il 1480 ed il 1532, sposò Domina Giacomina Quadrio, figlia di Serafino Quadrio. Da questa ebbe sei figli, di cui tre maschi: Spectabilis Dominus Giovanni Antonio de Carugo, Dominus Giovanni Giacomo, ed Antonio; e tre femmine: Domina Antonia de Carugo, Domina Elisabetta, e Lucia.
Domina Antonia ed Elisabetta sposarono entrambe membri della famiglia Quadrio: rispettivamente Ser Giovanni Quadrio Peranda, e Ser Maurizio Quadrio de Maria.
Questo ramo oriundo della famiglia de Carugo, in termini di prestigio ed influenza politica e sociale, ebbe la sua massima espressione nella figura di Spectabilis Dominus Giovanni Antonio de Carugo, il quale non solo perseguì la carriera notarile, ma venne eletto Console di Giustizia nel segno dell’orso, nonché Cancelliere “di valle”, la più alta carica tra gli organi di autogoverno con giurisdizione su tutta la Valtellina, così come delineato in maggior dettaglio nel prossimo capitolo.
Ufficiali Ducali
Marcheto de Carugo fu “officiale delle acque” ossia “Camparo” o meglio custode del Naviglio di Milano dal 26 febbraio 1392 al 19 febbraio 1403. Ripresa la carica prima del 1434, morì il primo febbraio 1435[209]. Nell’ambito del proprio ruolo deteneva il potere e l’autorità di denunciare e multare chiunque si fosse reso colpevole di danneggiamenti o di ostacolare il regolare flusso delle acque ed in tal caso di far rimuovere ogni impedimento[210].
Francesco de Carugo, publicus preconus ossia banditore del Comune di Como, figlio di Giovanni de Carugo, abitante a Como parrocchia di S. Provino, nella prima metà del quindicesimo secolo fu tra i più importanti e ricchi appaltatori della città di Como. Nell’ambito della propria attività si aggiudicò come garante o appaltatore i maggiori progetti della città. A titolo esemplificativo nel decennio tra il 1426 ed il 1436 Francesco de Carugo si aggiudicò i lavori di costruzione e ricostruzione di Porta Torre (15 ottobre 1426), del Baradello di Como (3 dicembre 1427), della Torre e del ponte della Cittadella prospiciente il palazzo vescovile (14 gennaio 1428), della Torre Rotonda (12 luglio 1428), della Torre di Olonio (2 settembre 1430), del Castello di Chiavenna (16 gennaio 1432), di Porta Nuova (16 ottobre 1433), di Porta Sala (23 agosto 1435), delle guardete di Porta Nuova, di Sant’Ambrogio, di Sant’Eusebio, del porto e della Torre dei Prestinai di Como (7 novembre 1435), della darsena della cittadella di Como (22 novembre 1435), e del ponte di Lecco (20 luglio 1436) [211].
Nel periodo tra il 1431 ed il 1438, Bernabò Carcano, nobile e letterato milanese d’indubbia influenza nella vita culturale e politica della città, mantenne fitta corrispondenza con “influenti funzionari locali, famosi eruditi, teologi e giureconsulti”[212], tra i quali, in una lettera del 1° febbraio 1432, compare Ambrosino de Carugo[213].
Giovanni de Carugo, anche detto Giovannino o “Zanino”, fino al 1434 servì sia presso l’Ufficio Ducale, che in qualità di consigliere e cancelliere [214], visse nei pressi di Porta Ticinese parrocchia di San Michele ad Cluxam, e fu iscritto alla matricola dei mercanti di lana sottile in consortile coi propri fratelli[215].
A partire almeno dell’anno 1452, Martinus (Martino) de Carugo ebbe importanti incarichi nell’ambito dei lavori di ricostruzione ed ampliamento del Castello di Porta Giovia (ossia dell’attuale Castello Sforzesco di Milano), indetti da Francesco Sforza nel 1450, anno della sua nomina a duca di Milano. In particolare, Martino de Carugo fu “deli cuppi et prede […] fatore, texaurero et solicitatore a vendere” cioè produttore, tesoriere e sollecitatore alla vendita per mattoni e coppi (tegole) per la costruzione e decorazione della torre mediana detta Torre del Filarete[216]. L’Archivio di Stato di Milano conserva due lettere coeve, una datata 25 luglio 1452, scritta da Martino stesso e destinata al commissario Marcaleone da Nogarolo; la seconda datata 13 giugno 1453, scritta dall’ufficiale delle mostre Stefano del Pozzo e destinata a Francesco Sforza. Entrambe le lettere riguardano denunce e lamentele circa la lentezza dei lavori e presunte malefatte, con l’espressa eccezione di Martino de Carugo, il quale secondo Stefano del Pozzo dimostra invece una condotta integerrima[217].
Veduta della torre centrale del Castello Sforzesco di Milano, detta Torre del Filarete, Milano, 1452.
Di Jakub Hałun - Opera propria,
CC BY-SA 4.0,
From Wikimedia Commons Date 2011 July 25
Negli anni che seguirono, Martino de Carugo sembrerebbe aver ricevuto nuovi incarichi con alcuni enti ospedalieri milanesi, tra i quali la Magna Domus Hospitalis (Ospedale Maggiore di Milano) anch’essa fondata su iniziativa di Francesco Sforza nel 1456. Nel 1469 si registra Martino de Carugo “offitiali in sancto Gregorio”[218]. Il 18 agosto 1472 i deputati del Capitolo dell’Ospedale Maggiore di Milano incaricano Martino da Carugo di fare le consignationes dei beni e delle possessioni dell'ospedale[219]. Con tale termine s’intendevano delle dichiarazioni di pertinenza giurate per mezzo delle quali poter inventariare i patrimoni fondiari[220]. Il 12 marzo 1473 lo stesso Capitolo chiese a Martino di far demolire “la chiusa costruita da Cabrino Sansoni sul fiume Lambro perché si trova sui beni dell'ospedale Maggiore e provoca a questi gravi danni”[221], infine il 3 aprile 1478 Martino venne incaricato di “procurare il legname necessario alla ristrutturazione dei mulini di Fonteggio e di S. Ambrogio”[222].
Giovanni Antonio de Carugo, figlio del fu Benedetto[223], venne nominato Commissario di Sanità il 18 gennaio 1513. Il 16 dicembre 1514 la carica venne elevata a Commissario straordinario a vita[224].
Consiglieri presso il Consiglio dei Novecento
Il Consiglio dei Novecento Nobili trova la propria origine nel più antico Consiglio di Credenza, storicamente presieduto dai tre ordini cittadini dei Capitanei, Valvassores e Cives, verso la fine del XII secolo cominciò ad essere denominato “Consilium Comunis”. Con l’avvento della Signoria, nonostante alcune delle prerogative del Consiglio vennero accentrate nella figura del Signore e del Duca, l’istituzione rimase il principale organo di ratifica e legittimazione[225]. A partire dal 1340, i membri del Consiglio che fino ad allora furono detti “Consiliarii” e “Credentiarii”, cominciarono ad essere chiamati “Decurioni”[226]. Secondo i propri statuti, i candidati al Consiglio dovevano essere scelti tra i migliori, più ricchi e più attivi cittadini sottoposti alla giurisdizione del comune di Milano[227].
Negli atti di nomina dei consiglieri per l’anno 1388, riportati da Paolo Morigia nella sua opera “Historia dell’Antichità di Milano” si ritrovano tre membri della famiglia de Carugo:
“Sotto il governo di Giovanni Galeazzo Visconti, il Vicario, con i dodici di Provvisione, e i Giudici della comunità di Milano, elessero gli infrascritti Cittadini Milanesi, e vollero che fossero chiamati Consiglio de’ Novecento Nobili della comunità, ovvero Repubblica di Milano, e ciò fu l’anno 1388 il dì 22 luglio, e ne elessero tanto numero per porta e parrocchia”[228]: per la Parrocchia di San Lorenzo Maggior di Dentro Laurentio (Lorenzo) de Carugo, per la Parrocchia di Santa Maria Secreta Giovannolo de Carugo, per la Parrocchia di San Michele la Chiusa Martinus (Martino) de Carugo.
Nella notte del 13 agosto del 1447, in seguito alla scomparsa del duca di Milano Filippo Maria Visconti, alcuni esponenti dell’antica nobiltà milanese, tra i quali Antonio Trivulzio, Teodoro Bossi, Giorgio di Lampugnano, ed Innocenzo Cotta, convocarono presso la corte ducale il Consiglio Generale ed istituirono il nuovo governo della Repubblica Ambrosiana. L’ordinamento della Repubblica Ambrosiana, ispirata sul modello delle autonomie e dell’organizzazione dell’antico comune aristocratico, fu l’espressione delle volontà delle élite politiche ed economiche della società cittadina del tempo, la quale includeva gli alti funzionari di governo, gli ufficiali del comune, i giureconsulti, i membri dei collegi dei notai e dei fisici, gli abati delle più importanti istituzioni ecclesiastiche, i banchieri, ed i mercanti. Il 17 agosto 1447 in occasione della prima seduta del rinnovato Consiglio dei Novecento, in rappresentanza della parte corrispondente alla Parrocchia di Sant’Eufemia figura il mercante di lana sottile Iacobus (Giacomo) de Carugo[229], figlio del nobile Martino de Carugo, padre degli importanti mercanti milanesi Donato ed Arasmo de Carugo. Nella stessa assemblea in rappresentanza della parte di Porta Vercellina figura Christoforus (Cristoforo) de Carugo[230] figlio di Ambrogio de Carugo. Da un documento conservato presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana sappiamo altresì che l’8 febbraio 1444 Cristoforo de Carugo, assieme al parente Zanono de Carugo figlio di Luigi, si obbligò nei confronti del mercante-banchiere milanese Stefanino Taverna figlio di Marco Taverna[231].
Il 30 settembre 1470 Arasmo de Carugo, figlio di Domini Giacomo de Carugo, e Giorgio de Carugo, figlio di Domini Ambrogio de Carugo, furono decurioni presso il Consiglio dei Novecento in rappresentanza di Porta Romana[232].
L’11 aprile del 1474 Donato de Carugo e Giorgio de Carugo furono decurioni presso il Consiglio dei Novecento in rappresentanza di Porta Romana[233]. Fu in questa occasione che i consiglieri delinearono i termini della riforma monetaria per la quale il duca concordò, a seguito della sua accettazione, di rinunciare al signoraggio, d’appaltare l’attività della zecca a privati, nonché d’introdurre una nuova moneta argentea di pregio, il cosiddetto “testone”, dal peso eccezionale di 9,8 gr con una lega di 964 millesimi, nel tentativo di prevalere sulle coniazioni argentee di emissione fiorentina e veneziana[234].
Per quanto concerne l’influenza politica e sociale del decurione Donato de Carugo, non solo presso la corte ducale, ma anche nell’ambito del Capitolo della Cattedrale, si ricorda a titolo esemplificativo una lettera del 15 novembre 1452 di Biagio Assereto Visconti, feudatario di Serravalle, indirizzata al duca di Milano Francesco Sforza e a sua moglie la duchessa Bianca Maria Visconti, nella quale si sostiene che gli ufficiali del vescovo stessero tramando contro la famiglia ducale: “Excellentia Vostra intenda como li officiali del vesco sono bene disposti contra lo stato ducale”, tra questi in particolare Donato de Carugo viene soprannominato in tono critico “ruffiano del Vescovo” ed accusato di mettere discordia per tutto il vescovato spargendo voci infondate: “et Donato da Carugo, citadino di Milano, rufiano del vesco, è andato per tuto el vescovato ad inhibire la intelligentia”. Biagio Assereto Visconti invita infine la famiglia ducale a considerare tali azioni sovversive quali veri e propri atti di tradimento: “Dio o lo diavolo voglia che la Excellentia Vostra intenda una fiata li tradimenti di qua. M ’arecomando a la Excellentia Vostra. Ex Serravallis, die XV novembris 1452. Illustrissime dominationis prefate fidelis miles Blasius”[235].
Per un’esamina più esaustiva della partecipazione della famiglia de Carugo al Consiglio dei Novecento ed al Consiglio Generale di Milano, si rimanda al Fondo Dicasteri conservato presso la Biblioteca Trivulziana di Milano.
Frontespizio di un’edizione veneziana del 1592 dell’opera storiografica di Paolo Morigia Historia dell’Antichità di Milano.
Asta Libri, Autografi e Stampe - Associazione Nazionale - Case d'Asta italiane
Frontespizio all’edizione del 1750 dell’opera di Filippo Argelati “De monetis Italiae variorum illustrium Virorum dissertationes”, conservata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Deputati alla Fabbrica del Duomo di Milano
L’ente preposto alla progettazione e costruzione del Duomo di Milano, denominato “Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano” venne istituita nel 1387 da Gian Galeazzo Visconti. In base al proprio regolamento del 16 ottobre 1387, il Consiglio dei Deputati della Fabbrica si compone di cento membri sia ecclesiastici che laici. In particolare, i membri laici appartenevano all’aristocrazia cittadina (famiglie patrizie milanesi), venivano eletti in base alla propria porta muraria di residenza, ed includevano anche il Vicario e i Dodici Deputati di Provvisione[236].
Negli Annali della Fabbrica del Duomo di Milano si riscontrano i seguenti membri della famiglia de Carugo[237]:
· Lorenzino de Carugo, venne nominato Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano per Porta Ticinese il primo febbraio del 1388;
· Guglielmolo de Carugo fu Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano sia nel 1391, in quanto uno dei Dodici Signori di Provvisione, che nel 1395;
· Lorenzo de Carugo, venne nominato Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano per l’anno 1390. Il 12 gennaio 1395 venne nuovamente eletto per Porta Tosa;
· Cristoforo de Carugo fu Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano a partire dall’anno 1395;
· Ambrogio de Carugo venne nominato Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano per Porta Comasina il 12 gennaio 1395;
· Vincenzo de Carugo e Martino de Carugo furono entrambi nominati Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano per Porta Ticinese il 9 febbraio del 1401. In particolare Vincenzo sostituì suo fratello Lorenzo;
· Marcheto de Carugo fu Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano per gli anni 1401, 1402, 1405, 1412;
· Geremia de Carugo fu Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano nel 1421;
· Giovanni de Carugo fu Deputato della Fabbrica del Duomo di Milano nel 1438 e nel 1460;
La facciata de Duomo di Milano e la scaenographia di Marco Vitruvio Pollione.
Vitruvio - De Architectura, tradotto dal latino in italiano, con commento e illustrazioni di Cesare di Lorenzo Cesariano - Como 1521.
The Metropolitan Museum of Art - The Met Collection - Public Domain Images.
Rettori e Dottori
Dai rotoli dei professori custoditi presso gli archivi dell’università di Pavia, sappiamo che Magister Doctor Agostino de Carugo fu professore ad lecturam Logice presso la medesima università, nei seguenti anni accademici e con i seguenti stipendi: quaranta fiorini per l’anno accademico 1441-42[238], cinquantacinque fiorini sia per l’anno accademico 1442-43[239], che per l’anno accademico 1445-46[240], ottanta fiorini invece per l’anno accademico 1447-48[241]; nell’anno accademico 1443-44 fu professore ad lecturam Philosophia extraordinaria[242]; infine, nell’anno accademico 1446-47 Magister Agostino de Carugo fu invece professore ad lecturam Prognosticorum con uno stipendio di 80 fiorini[243].
Il 17 settembre 1447, la caduta di Pavia sotto la signoria di Francesco Sforza, indusse la Repubblica Ambrosiana ad istituire la propria Universitas Studiorum con sede nel Broletto. A tale scopo sei patrizi milanesi, i.e. Domini Franchinus e Guarnerius de Castilliono, Nicolaus de Arcimboldis, Antonius de Bernadigio, Antonius de Sexto, e Johannes de Littis, vennero incaricati di individuarne ed assumerne i rispettivi dottori[244]. La direzione delle lezioni di Philosophia Naturalis del neocostituito ateneo fu assegnata ad Agostino de Carugo il 27 aprile 1448 con uno stipendio di 100 fiorini[245]. La scelta di spostarsi a Milano non dovette essere influenzata solamente dal generoso trattamento accordatogli, ma anche dal fatto ch’egli sembrerebbe aver tenuto lezioni in Milano già nel gennaio del 1446, nonché dal fatto che dal 28 luglio 1445, Agostino de Carugo risulta iscritto in qualità di Rectore Magister Doctor, nella “Matricula Dominorum Physicorum Civum Mediolani Collegiatorum”, ossia nella lista del Magnifico Collegio dei Nobili Medici di Milano, soggetto ad immunità imperiali[246].
In linea di principio la politica ducale tese a promuovere la permanenza stabile dei professori presso l’ateneo di Pavia, limitandone ed in alcuni casi impedendone la loro mobilità. La maggior parte dei professori ebbe una retribuzione generosa che in taluni casi permise loro anche l’accumulo di notevoli fortune, per lo più investite in abitazioni entro le mura cittadine ed in vaste tenute terriere[247].
Agostino de Carugo presunto professore di Cristoforo Colombo
Qualora Cristoforo Colombo in giovinezza avesse realmente studiato presso l’Università di Pavia, fu dagli storici questione lungamente dibattuta. A supporto di tale assunto si annoverano storici autorevoli tra i quali, per citarne solo alcuni, Cesare Correnti, Cesare Cantù, Washington Irving, William Prescott, William Desborough Cooley[248], Roselly de Lorgues[249], Manuel Colmeiro, e Alessandro Humbold[250]. Nell’ambito di siffatta interpretazione, ed analizzando le liste dei professori conservate presso gli archivi dell’Università di Pavia inerenti al periodo tra il 1460 ed il 1480, si ritenne probabile che nel maggio del 1463 Cristoforo Colombo fosse tra gli studenti di filosofia straordinaria del professore Agostino de Carugo[251].
Gli sviluppi storiografici più recenti sembrerebbero invece concordare sul fatto che Cristoforo Colombo non frequentò studi universitari[252], ma piuttosto le scuole che i membri della corporazione dell’Arte della Lana adibirono per l’educazione dei propri figli a Genova, nei pressi del vicolo di San Giacomo delle Fucine (detto anche “Pavia”)[253]. Alternativamente, sia Cristoforo che suo fratello Bartolomeo potrebbero aver compiuto degli studi presso il monastero di San Giovanni Battista in Paverano[254]. Infine, non è da escludersi che Fernando Colombo, affermando nella sua opera “Vida del Almirante Don Cristobal Colon” che suo padre Cristoforo studiò all’Università di Pavia[255], stesse semplicemente cercando di nobilitarne le più semplici origini.
Pronotai, Notai e Notai Imperiali
Masiolus de Carugo, civis mediolanensis figlio dell’ambasciatore della corte viscontea Druetto de Carugo, appare in un atto del 7 aprile 1352 quale publicus imperiali auctoritate notarius, ossia notaio imperiale[256].
Il pronotaio milanese Giovanni de Carugo, figlio di Vincenzio, compare in due atti notarili redatti a Milano rispettivamente il primo febbraio ed il 15 novembre del 1410. In entrambi gli atti si registrano dei pagamenti effettuati in favore dei procuratori dell’Ordine dei Frati Predicatori presso la basilica di Sant’Eustorgio. Nel documento risalente al primo febbraio, il procuratore fra’ Beltramolo de Seregnio riceve una somma da Petrollo de Comite[257]; il 15 novembre il prete Conradino de Medda effettua un pagamento in favore del procuratore fra’ Pietro de Roxate[258].
Il 17 aprile 1431 Giovanni de Carugo agì nuovamente nelle vesti di pronotaio per conto dell’Ordine dei Frati Predicatori della basilica di Sant’Eustorgio in un atto di vendita di alcuni loro terreni a Giovanni de Citadinis[259]. Il 17 agosto 1451, Antonia de Littis, figlia di Ambrogio de Littis ed appartenente alla famiglia patrizia milanese dei Litta, moglie di Ambrogio de Carugo, anch’esso figlio di Vincenzio e fratello minore di Giovanni, accetta l’eredità lasciatele da Fatiolo de Littis[260]. Il rispettivo atto notarile venne redatto presso il monastero dell’Ordine degli Umiliati di San Pietro Martire, sito presso la Basilica di Sant’Eufemia in Milano[261].
L'11 marzo del 1450 l'Assemblea Generale convocata nel palazzo dell'Arengo approvò il passaggio dei poteri al nuovo duca di Milano Francesco Sforza, riconoscendo la linea di successione ai figli maschi legittimi. A testimoniare l’evento storico furono chiamati ad affiancare i protonotari, nove nobili tra i quali figura anche il notaio Giovanni de Carugo figlio di Domini Paolo de Carugo: “Nobilis Johannes de Carugo fil. Domini Pauli Portae Novae Parochiae Sancti Stephani ad nuxigiam Notarius”[262]. Questo ulteriore ramo nobile dei de Carugo risiedeva pertanto nell’ambito della parrocchia di Santo Stefano in Nosiggia, la quale, demolita nel 1787, si trovava nell’area corrispondente all'odierna piazza Belgioioso. In un atto del 30 gennaio 1454, il notaio Giovanni de Carugo beneficia di un lascito disposto da Elisabetta de Morexinis (Moresini), vedova di Ambrogio de Peregallo, in quanto curatore e tutore dei loro figli. Elisabetta Moresini fu la figlia del facoltoso mercante milanese Giovanni Moresini[263].
Giovanni de Carugo, figlio di Guglielmo de Carugo membro dei Dodici Signori del Tribunale di Provvisione, attorno alla metà del Quattrocento si spostò “in loco Castellino Plebis Incini” ossia a Caslino d’Erba, in provincia di Como, ove operò in qualità di notaio[264].
Giovanni Luigi de Carugo figlio di Michele figura quale pronotaio nella disposizione testamentaria di Donato de Corrigiis redatta a Milano il 24 dicembre 1503[265].
Il 27 marzo 1509 il figlio di Francesco de Marliano investe di alcuni terreni Giovanni Maria de Pirovano, assistito dal pronotaio Giovanni Pietro de Carugo[266].
Ulteriori esponenti nobili e notabili
Attorno al 1250, Gereminus de Carugo scrisse alcuni versi in latino sulla sguardia posteriore di uno dei suoi manoscritti miniati, il “De mundi aetatibus (De aedificatione urbis Troiae, Gesta destroyis urbis Troiae…)” di Iohannes Codagnellus, risalente al 1235 circa. A futura memoria, Gereminus concluse il proprio componimento precisando che “Gereminus de Carugo scripsit hos versus”. Il manoscritto è di preziosa fattura in pergamena con rilegature in pelle di vitello maculata, include iniziali decorate, pitture a guazzo prevalentemente sul blu, verde e arancione, e decorazioni influenzate dallo stile gotico settentrionale. Nel XIV secolo ne prese possesso la Certosa di Garegnano fondata dall’Arcivescovo e Signore di Milano Giovanni Visconti, la quale aggiunse il proprio marchio ex libris. Ad oggi lo stesso manoscritto è custodito presso la Biblioteca Nazionale di Francia[267].
Pietro de Carugo, figlio di Bertramo detto “Merlo”, appare in un documento redatto il 30 agosto 1333 a Inverigo, nel quale effettua dei pagamenti d’affitto in favore di Rayniero De Ansano[268].
Guasparolo de Carugo compare in un atto notarile redatto a Como il 3 ottobre 1338, relativo ad una causa tra il Comune di Ponna ed il Monastero di San Benedetto d’Isola, in merito al pagamento delle decime[269].
Per due anni consecutivi, il 9 agosto 1355 e 1356, Giorgio de Carugo, figlio del fu Bulgaro, effettua un pagamento in favore del preposto della Basilica di San Lorenzo Maggiore Francesco di Sancto Zenone. Giorgio de Carugo sembrerebbe agire nelle vesti di fideiussore in quanto la transazione avvenne per conto di Bettino de Moro[270].
Il 22 aprile 1398 Giovanni de Carugo dona a beneficio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano un’abitazione in Cantù[271].
Il 28 ottobre 1404 Antoniola de Magistris, vedova di Guglielmo de Carugo, di Monza, presso il Notaio Gerardo de Crepa, dispone a favore del fratello Zanone, con un lascito agli umiliati del terz’ordine di Monza di un campo in Lissone, località “in Baradia”[272].
Filippo de Carugo, fu Antonino, di Monza, il 2 luglio 1460, riceve pagamento dal proprio fattore Pagano Aliprandus, per il fitto di una vigna in Monza, località Traversagnia[273].
Giuseppe de Carugo il 30 novembre 1491 dona s.10 a beneficio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano[274].
Armellina de Carugo, vivente sul principio del 1500, fu la moglie di Nicolò Parravicini, capostipite della nobile famiglia Parravicina stanziatasi in Erba in provincia di Como[275]. Armellina fu probabilmente una parente di Giovanni de Carugo, figlio di Guglielmo de Carugo membro dei Dodici Signori del Tribunale di Provvisione, il quale attorno alla metà del Quattrocento si spostò “in loco Castellino Plebis Incini” ossia a Caslino d’Erba, in provincia di Como, ove operò in qualità di notaio[276].
Mercanti
Domini Beltramolo de Carugo, figlio di d. Bolgarino de Carugo, residente a Milano nei pressi di Porta Ticinese, parrocchia di San Michele ad Cluxam, fu iscritto nella Matricola dei Mercanti di Lana[277]. Da un atto di Milano del 31 marzo 1401 sappiamo che Giorgio de Carugo e suo fratello Giovanni, figli del fu Beltramolo de Carugo, furono anch’essi entrambi mercanti di lana. L’atto in questione riporta il pagamento dell’importante somma di 317 Lire imperiali per della lana della Borgogna[278]. Questi “fratelli de Carugo” figli di Beltramolo, dei quali le fonti superstiti ricordano, oltre i già menzionati Giorgio e Giovanni, anche un Michele, Marchetto, ed un Girolamo, il 15 gennaio 1399 affittarono da Giacomo Fagnani tre fucine adibite alla fabbricazione di chiodi presso la parrocchia di San Pietro in Campolodigiano[279]. Laurenzius de Carugo, figlio del sopramenzionato Giorgio, fu iscritto nella matricola dei mercanti di lana sottile di Milano ed ebbe residenza in Porta Ticinese nei pressi della parrocchia di San Lorenzo Maioris Intus[280]. Suo zio Giovanni de Carugo, anche detto Giovannino o “Zanino”, fino al 1434 servì sia presso l’Ufficio Ducale, che in qualità di consigliere e cancelliere[281], visse nei pressi di Porta Ticinese parrocchia di San Michele ad Cluxam, e fu iscritto alla matricola dei mercanti di lana sottile in consortile coi propri fratelli[282].
Domini Giacomo de Carugo e suo fratello Francesco, figli del nobile Aloysio (Aloisio o Luigi) de Carugo, furono mercanti di lana sottile, iscritti nella medesima matricola nell’anno 1513[283]. Giacomo de Carugo ebbe anche successo nel commercio di armature da guerra (vedi paragrafo seguente).
Il primo novembre 1422 domini Aloisio de Carugo venne eletto Consigliere della Scuola di San Giovanni sul Muro, frutto dell’unione delle antiche “Scole Senum et Iuvenum Sancti Iohannis Supra Murum”. Queste furono particolari articolazioni dell’associazione confraternale nata nella prima metà del Trecento nell’ambito della comunità dei vicini della parrocchia milanese di San Giovanni sul Muro[284]. Aloisio de Carugo compare anche nei verbali di una precedente riunione datata 5 agosto 1421, nella quale si sottolinea la necessità di “restaurare” la confraternita da uno stato di trascuratezza[285]. In qualità di Consigliere, Aloisio fu responsabile della gestione delle rendite della scuola, la quale disponeva di un cospicuo patrimonio fondiario ed immobiliare inclusivo di sei campi e quattro vigne a Vimodrone, d’ulteriori beni fondiari a Legnano e nei dintorni della Cascina Passarana, nonché di undici case entro le mura cittadine di Milano[286]. La confraternita si poneva obbiettivi sia di difesa del singolo membro, che della sua casata e ceto di appartenenza, sia da un punto di vista materiale che valoriale, insegnando ai membri più giovani le norme, i valori e i comportamenti ai quale si sarebbero dovuti attenere. Particolare premura venne data alla tutela di quei membri cosiddetti “poveri vergognosi”, ossia appartenenti a famiglie storicamente di ceto elevato ma allo stesso tempo impossibilitate a mantenere un confacente stile di vita[287]. La confraternita, che per i propri membri fu strumento di affermazione e prestigio[288], dovette essere vista con riguardo anche dalla famiglia ducale. La duchessa Bianca Maria Visconti infatti, nel 1464 esenzionò la confraternita dal pagamento del dazio, concessione poi riconfermata nel 1496 anche da Ludovico Maria Sforza[289].
Ulteriore figlio di Aloisio, Giorgio de Carugo, assieme a sua moglie Donna Soprana da Calco nel 1488 diedero in affitto un caseggiato, situato nella parrocchia di Sant’Eufemia, a Cristoforo d’Oggiono, padre del pittore Marco d’Oggiono allievo di Leonardo da Vinci[290]. Il padre di Donna Soprana, Antonio da Calco, nel 1492 fu Segretario della missione diplomatica a Parigi indetta da Ludovico Sforza al fine di trattare la discesa in Italia del re di Francia Carlo VIII di Valois[291]. Non avendo figli con testamento 25 ottobre 1489 istituirono erede l'Ospedale Maggiore di Milano[292].
Tra gli esponenti della famiglia de Carugo dediti all’attività mercantile e vicini al mondo artistico milanese, oltre che Giorgio de Carugo, si registra anche il produttore di tessuti serici Agostino de Carugo, presso il quale il pittore Gerolamo Zavattari nel 1482 compì un apprendistato fornendo disegni per tessitori. Gerolamo Zavattari fu il nipote del pittore Francesco Zavattari, il quale diresse la decorazione della cappella di Teodolinda del Duomo di Monza[293].
Tommaso de Carugo, fratello maggiore di Donato ed Arasmo, tutti figli di Giacomo de Carugo, figlio quest’ultimo di Martino de Carugo, fu anch’esso mercante di lana sottile iscritto nella rispettiva matricola intorno all’anno 1440[294]. Giacomo ed Arasmo furono anche attivi nella produzione e commercio di aghi. Milano in quel periodo deteneva pressoché il monopolio della produzione di aghi a livello regionale, stabilendo rigidi statuti detti degli “agucchiaroli”, emanati allo scopo d’imporre livelli qualitativi obbligatori e di combattere la contraffazione[295]. Le fonti superstiti ricordano almeno due importanti transazioni di produzione e commercio in aghi facenti capo a Giacomo de Carugo: una del 23 aprile 1457, nella quale coinvolse anche suo figlio Arasmo, ed avente come controparte Princivalle de Mandello[296]; la seconda del 1458, nella quale Arasmo de Carugo compra il diritto di servirsi del marchio di fabbrica facente capo ad Ambrogio Pagani detto “de Raffinis”, il quale marchiava i propri aghi col “signum signandi agugias, quod est unus Agnus cum bandirola una cum cruce”[297].
Nel 1462 Giacomo de Carugo servì come deputato nel Capitolo dell’Ospedale Maggiore di Milano[298]. Dalle fonti superstiti, delle quali citiamo solo alcuni esempi, emerge una partecipazione focalizzata nell’ambito della gestione patrimoniale e finanziaria: il 7 gennaio 1462, Giacomo de Carugo assieme a Giovanni da Bellusco vendono “i beni pervenuti all’ospedale in seguito all’indulgenza”[299], il 14 gennaio “esaminano la proposta di Gervasio Scarliono, il quale chiede che il fitto livellario di 10 once di legna da lui pagato all'ospedale di S. Vincenzo venga convertito in un fitto in denaro pari a L. 30 annue, oppure che gli venga venduto per L. 750 imperiali”[300], il giorno seguente venne conclusa una permuta, verificato e valutato un fondo e assicurato il pagamento di un debito[301], il 24 gennaio si decise di sottomettere tutti i futuri pagamenti effettuati dal tesoriere al mandato sottoscritto dal priore e da almeno due deputati, e di procedere contro tutti i debitori dell'ospedale[302].
Armature milanesi per gli eserciti di Francia
In seguito alla cattura di Ludovico il Moro nell’aprile del 1500, gli Sforza persero il controllo del Ducato di Milano, che divenne dominio francese. Si realizzarono così le ambizioni del re di Francia Luigi XII, il quale ebbe lungamente mirato alla conquista di quel ducato, e che sin dalla propria giovinezza già si titolava duca di Milano iure ereditario, rifacendosi ai diritti ereditati dalla nonna paterna Valentina Visconti. Nei territori di pertinenza del Ducato, il controllo francese fu coadiuvato dalle nobili famiglie dei Caccia, dei Tornielli, e dei Trivulzio. In particolare, Gian Giacomo Trivulzio, il quale fu al seguito dei francesi anche sotto Carlo VIII, predecessore di Luigi XII, nel 1499 venne da quest’ultimo nominato Maresciallo di Francia.
Tra i documenti conservati presso l’Archivio Nazionale francese a Parigi, inerenti alla corrispondenza degli ambasciatori di Francia presso la confederazione svizzera, si ha un’attestazione datata 12 febbraio 1515, firmata da Gian Giacomo Trivulzio in favore del mercante milanese Giacomo de Carugo. In essa si confermano le spedizioni di sessanta casse di armature che Giacomo de Carugo fece pervenire nel periodo tra il 1512 ed il 1515, tramite il Canton Friburgo, a Gian Giacomo Trivulzio, a sostegno delle guerre del re di Francia Luigi XII in Italia[303]. Delle numerose transazioni commerciali perseguite dai de Carugo milanesi di cui si hanno ancora notizie nelle fonti storiche, la sopradescritta fornitura di armature belliche in favore del re di Francia è forse tra le più esemplificative delle altissime capacità non solo commerciali e logistiche dei de Carugo, ma soprattutto diplomatiche. Nel periodo tra il 1512 ed il 1515 infatti, i francesi persero temporaneamente il controllo del Ducato di Milano, il quale fu sottoposto a Massimiliano Sforza dagli svizzeri della Lega Santa, guidati da Matteo Schiner.
I fratelli Donato ed Arasmo de Carugo
Donato ed Arasmo de Carugo, figli di domini Giacomo de Carugo, nipoti di Martino de Carugo[304], cittadini milanesi residenti in Porta Romana, parrocchia di Santa Eufemia intus, nobili e decurioni, furono tra i più importanti mercanti della Milano sforzesca. In particolare, fu in mercanti quali Giacomo ed Arasmo de Carugo che secondo la professoressa di Storia economica medioevale Maria Paola Zanoboni, cominciò a profilarsi nella Storia del capitalismo lombardo la figura del “mercante imprenditore”[305]. Essi non si specializzarono in singoli prodotti e si interponevano tra gli artigiani ed il mercato sovrintendendo alla produzione, assumendo personale, rivedendo il prodotto, mantenendo la contabilità, prestando capitali e stabilendo una rete commerciale “regionale” ossia, in termini attuali, internazionale. Quest’ultimo aspetto imponeva al mercante imprenditore anche le ulteriori sfide e responsabilità dovute al passaggio delle merci attraverso diverse giurisdizioni, ossia il pagamento di tasse e dazi, nonché il cambio monetario.
Esempio di armatura di fattura milanese: veduta frontale dell’armatura di Roberto Sanseverino opera dell’armaiolo milanese Antonio Missaglia.
Emporium, rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e varieta, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Vol. 15-16, Bergamo, 1902.
Oltre che per il loro successo nell’attività mercantile, i fratelli Donato ed Arasmo de Carugo si ricordano anche per il loro coinvolgimento nella sfera politica, ecclesiastica e benefica cittadina. Arasmo compare quale sindaco per la parrocchia di Porta Romana in un atto del 30 settembre 1470[306]. Il 13 ottobre 1488, il duca di Milano Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti permette un cambio di beni tra Arasmo de Carugo e due enti ecclesiastici di Milano: i rettori di S. Eufemia, e i preti della Società dei Dodici Apostoli e della Beata Maria[307]. Nel 1498 è nominato nel registro dei benefattori dell’Ospedale Maggiore intitolando l’ente di un legato di L.160[308]. Nell’ambito della propria pianificazione successoria, tale fu l’estensione del proprio lascito, che il 14 maggio 1490 Arasmo de Carugo dovette ricevere direttamente dal duca di Milano Giovanni Galeazzo Maria Sforza Visconti, il permesso di testare con deroghe agli Statuti di Milano[309]. Sua figlia Donna Margherita de Carugo, andò in sposa al banchiere Rinaldo D’Adda, dei marchesi e feudatari di Pandino[310].
Donato de Carugo fu decurione del Consiglio dei Novecento Nobili per Porta Romana in un atto dell’11 aprile 1474[311]. Per volere di Leonardo Visconti, protonotario apostolico, abate e commendatore perpetuo del Monastero di San Celso in Milano, il 4 settembre 1490 Donato de Carugo fu tra i “venerabilium, spectabilium nobiliumque virorum dominorum” ossia tra i venerabili, spettabili e nobili uomini, ai quali venne affidata la guida della neocostituita Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria Assunta presso San Celso in Milano[312].
Monastero di San Celso in Milano, veduta del complesso in un’incisione del 1704, estratta dall’opera di Giovanni Cristostomo Zanchi, De Origine Orobiorum, sive Cenomanorum ad Petrum Bembum.
Vetrata V01 del Duomo di Milano, episodi della Vita di San Giovanni Evangelista, opera dei frati Gesuati di San Girolamo e di Cristoforo de Mottis, commissionata dal Paratico dei Notai e intitolata al Santo Patrono della Corporazione, Milano, 1475-1478[313].
From Wikimedia Commons Date 27 June 2016 Source Own work by Author Darafsh.
Nei quindici anni che intercorsero tra il 1479 ed il 1493, Arasmo de Carugo fu il massimo fornitore di vetri pregiati per la Fabbrica del Duomo di Milano. Specializzato nell’importazione di vetri di Lione, ne vendette alla Fabbrica quasi 400 kg, in termini comparativi oltre due volte il volume d’affari del secondo fornitore dell’epoca[314]. Il due di giugno 1480 gli Annali della Fabbrica del Duomo di Milano registrano l’apporto come dato in soluto di otto vetrate, ossia 42 ligatie, da parte di Arasmo de Carugo, alle quali si aggiunsero L. 186 in riconoscimento delle spese affrontate per l’importazione delle vetrate da Lione fino a Milano[315].
Oltre che per le vetrate del Duomo di Milano i vetri pregiati importati da Arasmo de Carugo furono usati anche per la creazione del rosone frontale del Duomo di Como. Il tesoriere Francesco Lucini annota infatti, in uno dei giornali della fabbrica della cattedrale per l’anno 1487, la “expensa facta pro fabrica in fatiendo invitriatam rote ecclexie” di Lire 316 da pagarsi a “domini Arasmo de Carugo in Mediolano”[316].
Il 19 marzo del 1492 Arasmo e Donato de Carugo conclusero assieme un contratto di fornitura di vetri pregiati per un valore di L 158.18 con il convento di S. Francesco in Lugano, all’epoca sottoposto all’episcopato della città di Como, per la realizzazione di nuove vetrate. Dal codice Trivulziano n. 1818, fol. 334, un rogito del notaio Boniforte Gira, leggiamo infatti che il “Venerabilis d. frater Jo. de Bussero fil. q.dm d. Johannini, Guardianus dominorum fratrum monasterij S. Francisci lacus Lugani, episcopatus Comi, et habit. in dicto monastero debet domino Arasmo et Donato fratribus de Carugo, Porta Romana, parr. s. Eufemie, L. 158.18 occasione tante quantitatis vetri pro faciendo vetriatas dati, venditi”[317].
All’epoca il commercio d’importazione di vetro colorato in Lombardia era per la maggior parte nelle mani dei commercianti tedeschi, dei quali le fonti ricordano in particolare Uncrardus de Alemania ed i rappresentanti della Società di Revesburg, Hoberthus de Rotemberg, Redulfus de Sancto Petro Teutonico, Nicolaus de Basla; mentre i mercanti milanesi come Arasmo e Donato de Carugo ed Antonio da Villa, o quelli comaschi come Pietro da Rancate, furono l’eccezione[318].
La capacità dei fratelli Donato ed Arasmo de Carugo di ottenere commesse di siffatta importanza ed eccezionalità si deve intuitivamente anche alla propria influenza politica e sociale, non solo presso la corte ducale, ma anche nell’ambito del Capitolo della Cattedrale. A titolo esemplificativo, Biagio Assereto Visconti, feudatario di Serravalle, in una sua lettera del 15 novembre 1452 indirizzata al duca di Milano Francesco Sforza e a sua moglie la duchessa Bianca Maria Visconti, soprannomina in tono critico il cittadino milanese Donato de Carugo “ruffiano del Vescovo”[319].
Con patente di concessione ducale del 6 aprile 1484, i “fratelli Carugo” comprarono uno “spazio” lungo le sponde del naviglio interno nei pressi delle mura di Porta Romana, ove poter edificare una “sosta” adibita a deposito e carico scarico delle merci da loro trattate. Oltre che per motivazioni di carattere meramente logistico, le famiglie illustri videro in tali concessioni anche l’opportunità di abbellire la propria abitazione privata, mediante la costruzione di porte, giardini e torrette[320].
La relazione commerciale con Bernard von Nürnberg e l’Albergo dei Tre Re
Nell’ambito della propria attività commerciale, Donato ed Arasmo de Carugo instaurarono importanti relazioni con alcuni mercanti tedeschi. Le fonti ricordano in particolare una serie di contratti e transazioni tra Donato de Carugo, che agisce anche a nome di suo fratello Arasmo, ed il mercante tedesco Bernard von Nürnberg (Bernardo da Norimberga), il quale ebbe una residenza a Milano in Porta Romana nei pressi della parrocchia di San Giovanni Itolano, fu figlio di Anton von Nürnberg, ed operava oltre che a Milano anche a Brescia Verona e Vicenza. L’estesa parentela dei de Carugo, presente già da diversi secoli oltre che a Milano anche nella città di Como, e ramificatasi poi nei Grigioni, in Valtellina e nei territori spettanti alla Repubblica di Venezia, la loro esperienza multigenerazionale nell’ambito del commercio estero, nonché le brillanti carriere politiche di moltissimi dei suoi membri, e quindi la loro vicinanza con alcune delle massime autorità locali dell’epoca, furono intuitivamente fattori alquanto attrattivi per quei mercanti stranieri che cercassero una controparte locale colla quale operare nel Ducato di Milano.
Tra le svariate transazioni commerciali intercorse tra i fratelli de Carugo e Bernardo da Norimberga ricordiamo innanzitutto un contratto redatto il 10 ottobre 1477 a Milano dal Notaio Antonio de Birago ed inerente allo scambio di cucchiai e tessuti pregiati, quali pellicce, cotoni e lini lavorati e drappeggiati, per l’importante somma complessiva di lire imperiali 1150[321]. Il 17 marzo 1479 lo stesso notaio registra un’ulteriore transazione delle medesime controparti ma avente in oggetto lo scambio d’articoli d’argento, quali sonagli per sparvieri, cucchiai e pinze, per un valore di 709 lire, 12 soldi e 6 denari imperiali[322]. Siffatti scambi devono nel tempo aver generato un credito a favore di Donato de Carugo che Bernardo da Norimberga onorerà a Milano, il 9 novembre 1478, mediante la vendita a Donato de Carugo, come data in soluto, di un sedime sito a Milano in Porta Romana, parrocchia di San Giovanni Itolano, “vedelicet in curia nuncupata curia domini Bernabovis”, inclusivo di molteplici edifici, camere, solai, sei botteghe su strada, cantina sottoterra, cortile, orto e altre pertinenze, confinante da un lato con la strada, dall’altro con i beni che tiene Bartolomeo da Grumello, dall’altro lato con i beni di Vincenzo Vimercati, e da ultimo con i beni di Ludovico Maria Sforza, nonché il diretto dominio di un sedime contiguo di una pertica, una tavola, 6 piedi e 6 once di terra “zardini nuncupati zardini domini Bernabovis” locati a Bartolomeo da Grumello per il fitto annuo di 18 lire, 13 soldi e 6 denari[323]. A questa straordinaria transazione se ne aggiunge una di poco precedente, datata 6 novembre 1478, nella quale le sorelle Laura e Lucia Bossi vendono per 435 lire imperiali, 6 soldi e 8 denari a Donato de Carugo, figlio del fu Giacomo, abitante a Milano in Porta Romana, parrocchia di Sant’Eufemia intus, il diretto dominio e il diritto di riscossione di un fitto per i terreni su cui Bernardo da Norimberga ebbe costruito degli edifici[324].
I sopracitati edifici acquisiti da Donato de Carugo nel 1478, e fatti realizzare a partire del 1470 da Bernardo da Norimberga, ospitarono uno dei più rinomati alberghi della città: l’Albergo dei Tre Re. Esso sorgeva nei pressi di quella che fu la porzione di ingresso, verso la chiesa di San Giovanni Itolano, di un originario edificio voluto da Luchino Visconti attorno al 1345. Quest’ultimo si collocherà poi nell’ambito di quel “sistema” di palazzi autonomi voluti da Bernabò Visconti durante il Trecento, al quale le fonti sopramenzionate si riferiscono in termini di “curia domini Bernabovis”, ossia corte del Signore di Milano Bernabò Visconti[325].
L’insegna dei “Tre Re” è tra le più antiche insegne d’albergo che si conosca e si riferisce ai tre santi Re Magi della Sacra Scrittura, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, che la leggenda voleva fossero sepolti nella chiesa di Sant’Eustorgio di Milano, e le cui spoglie l’imperatore Federico Barbarossa fece poi trasportare a Colonia[326]. L’Albergo dei Tre Re, che secondo alcune fonti potrebbe esser stato parte effettiva della Corte Viscontea[327], usava ospitare le ambascerie della Corte Ducale: nel 1492 ospitò gli ambasciatori veneti Giorgio Contarini e Paolo Pisani, reduci da una visita all’imperatore Federico di Germania. Del loro soggiorno si conserva una cronaca nella quale descrivono l’albergo come un “un grande e comodo albergo, gli appartamenti degli ambasciatori ornati di tappeti; letti sfarzosi e oggetti d’arte, […] servitori con candele di cera bianca, […] onorati dal suono dei trombettieri e dei pifferi ducali, nonché del rullo dei tamburi della marchesa di Mantova allora in soggiorno a Milano”[328]. Nel 1512 alloggiò presso lo stesso albergo il barone Rinaldo Daele signore di Villeneuve, maggiordomo del re di Francia, in viaggio verso l’imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano I d'Asburgo[329]; nel 1604 vi alloggiarono i notabili Grigioni venuti a Milano per prestare giuramento di fedeltà al re Filippo II di Spagna[330]. Gli ospiti di origine svizzera sembrerebbero essersi succeduti con straordinaria frequenza, non solo in termini di singoli individui, ma anche d’intere compagnie; dal 9 dicembre del 1621 al 12 febbraio 1622 per esempio, alloggiarono contemporaneamente all’albergo dei Tre Re 54 ospiti svizzeri con 44 cavalli al seguito[331].
Fu anche grazie all’ottima reputazione che l’Albergo dei Tre Re seppe guadagnarsi con gli ospiti di origine svizzera e tedesca, ch’esso divenne sede preferenziale di smistamento e recapito postale della corrispondenza e dei contratti economici tra Milano e i paesi d’oltralpe[332]. L’albergo mantenne tale funzione fino al 1730, ossia fintanto che la Camera dei Mercanti di Milano seppe mantenere i propri privilegi postali, in aperto contrasto col servizio postale fornito dalla famiglia Tasso, in particolare dal conte Simone de Tassis[333], il quale nel novembre del 1536 ottenne il riconoscimento a Maestro Generale delle Poste del Ducato di Milano da parte dell’imperatore Carlo V d’Asburgo[334].
Donato de Carugo non gestì l’albergo direttamente ma lo diede in gestione a terzi. Il 9 novembre del 1478, quindi contestualmente all’acquisto dell’albergo, Donato de Carugo lo riaffittò infatti allo stesso Bernardo da Norimberga per un canone annuo di 173 lire imperiali e 4 denari[335]. Quest’ultimo il 27 luglio 1480 investirà a sua volta la gestione dell’albergo a Bernardino Airoldi da Robbiate per un fitto annuo di 400 lire imperiali[336]. Il 22 febbraio 1481, a Bernardino Airoldi da Robbiate subentrò Giovanni Venzago della Fontana, il quale dovette rilevare tutti i debiti contratti da Bernardo da Norimberga sulle piazze di Milano, Brescia, Verona, e Vicenza, e continuare a pagare un fitto annuo di 171 lire imperiali, 13 soldi e 4 denari a favore di Donato ed Arasmo de Carugo[337]. L’anno successivo allorquando Bernardo da Norimberga ritirò almeno parzialmente i propri interessi sull’albergo dei Tre Re cedendone una parte ai fratelli Aloisio e Francesco de Giocatorio, la transazione dovette ricevere il consenso di Donato de Carugo[338]. Dalle fonti superstiti non sembrerebbe possibile determinare con precisione il momento nel quale i de Carugo uscirono definitivamente dall’asse proprietario dell’Albergo dei Tre Re. Ciò avvenne al più tardi nei primi decenni del XVI secolo, in quanto già nell’agosto del 1565 lo stesso albergo appare tra le proprietà incluse nelle disposizioni testamentarie di Giovan Andrea Annoni[339]; i cui discendenti rimasero proprietari dell’albergo dei Tre Re fino a quasi tutto il XVIII secolo[340]. Nel 1803 vi soggiornò il re di Sardegna Carlo Emanuele IV di Savoia[341], e nell’agosto del 1819 il pittore inglese William Turner, che dalla finestra della propria camera dipinse la veduta di Milano con le chiese di San Lorenzo, il campanile di San Giovanni in Conca e la chiesa di Sant’Alessandro[342]. Infine, l’albergo cominciò a decadere intorno al 1820[343].
Vedi l’opera presso la Tate Images:
Milan: The Skyline at Dawn, with the Campanile of San Giovanni in Conca,
Joseph Mallord William Turner (1775-1851), 1819.
From Como and Venice Sketchbook, Alexander Joseph Finberg, CLXXXI.
L’Epoca di Dominazione Spagnola 1535 – 1713
Il tradizionale giudizio della storiografia italiana sul Seicento Lombardo trova nel capolavoro letterario manzoniano una delle sue rappresentazioni più emblematiche[344], nella quale si delinea sostanzialmente un periodo storico di malgoverno, di grave declino economico, d’oppressione fiscale, e di regressione dei costumi. Nel 1633, a proposito della città di Milano, l’ambasciatore veneto al serenissimo cardinale Ferdinando d’Asburgo, Bertuccio Valier, scrisse di “difficilissimi tempi”: “Gli animi de' sudditi milanesi sono resi ormai incapaci ed insofferenti della dura tirannica vessazione di tanti anni sotto il peso dell'armi ed alloggio degli eserciti. […] Quei sconsolatissimi cittadini, nella continua ed amorevole gara di uffizi e visite ricevute nella mia casa, mi han confidato che i mediocri non hanno di che vivere, perché i soldati il tutto estinguono; che i facoltosi rimangono a gran giunta con il terzo delle entrate loro; che i poveri se ne morono di fame e disagio; che Milano, già città capitale di 300’000 abitanti, non conta apena 80’000; ch'il lusso e le pompe sono trasformate in miserie”[345].
Non meno rilevanti in questo senso furono gli effetti delle repressioni controriformistiche in Lombardia, nell’ambito delle quali lo storico ed economista Marco Formentini attribuì seri eccessi all’operato dei cardinali Carlo e Federico Borromeo e dell’ordine religioso della Compagnia di Gesù, in particolare: il popolo ed i patrizi milanesi “ci vennero presentati come caduti, sin dalla metà del secolo XVI, nel più basso grado d'ignoranza e d'immoralità; laddove se allora furono distrutte molte savie istituzioni, ciò si dovette principalmente ai gesuiti capitanati dai due Borromeo. Furono questi che, inceppando ogni libertà di pensiero, e sconvolgendo ogni ordine di cose, ridussero il Ducato di Milano a quella decadenza, a cui, per la brevità del tempo e più per la tenacità dei cittadini milanesi, non aveva potuto essere trascinato neppure dal dispotismo dei Governatori Spagnuoli”[346].
La maggior parte della documentazione ufficiale del tempo descrive le condizioni economiche dello Stato di Milano come “estremamente delicate” o addirittura “disperate”[347]. Il settore tessile laniero subì un evidente declino, registrando una caduta della percentuale di capifamiglia addetta dal 42,5% nel 1560 al 22,3% nel 1610[348]. Nell’arco della prima metà del XVII secolo il numero di mercanti di lana attivi in città si ridusse da circa novanta a quattordici, quello dei telai da 567 a soli sei[349]. La lavorazione del fustagno e della tela gradualmente abbandonò la città per spostarsi nel contado[350]. Nel 1606 circa mille, ossia un terzo dei telai auroserici della città, cessò di operare[351]. Negli anni che seguirono il numero di telai attivi entro la città precipitò ulteriormente finché, a partire dal 1635, ne rimasero solo circa seicento[352]. Nemmeno la produzione e l’esportazione d’armi ed armature venne risparmiata: nonostante la relativa ripresa registrata durante il periodo della Guerra dei Trent’anni, a Milano tale industria si estinse pressoché del tutto entro la fine del XVII secolo[353].
Come evidenziò lo storico Domenico Sella, tra le manifatture e attività mercantili che chiusero le proprie attività entro le mura cittadine, numerose furono quelle che riaprirono nel limitrofo contado, attratte da minori vincoli corporativi e dalle minori pretese salariali dei lavoratori rurali[354]. Sennonché una parte dei mercanti e dei nobili milanesi decise di disinvestire dal settore manifatturiero e mercantile per concentrarsi invece in impieghi meno remuneranti ma più sicuri, in particolare la proprietà terriera e le relative attività agrarie. Il movimento fu di siffatta grandezza da indurre gli storici ad inquadrarlo nell’ambito di una cosiddetta “rifeudalizzazione” o, nel caso specifico, di un presunto “tradimento della borghesia”[355]. Ad incentivare l’abbandono delle attività imprenditoriali da parte delle élite cittadine fu anche l’imposizione del modello culturale spagnolo, il quale impediva ai nobili milanesi l’accesso alla manifattura ed al commercio, favorendone invece, mediante benefici e sgravi fiscali, il riposizionamento nella proprietà terriera e nelle attività agrarie[356].
Le famiglie de Carugo milanesi furono anch’esse così gravemente colpite dalle soverchianti difficoltà e dalle diverse crisi che afflissero questo periodo storico, che alcuni storici ne ipotizzarono addirittura la loro contestuale estinzione. Nel 1871, Cesare Cantù nella sua opera “Milano Storia del Popolo e pel Popolo”, annovera i de Carugo milanesi tra le famiglie non più sussistenti[357]; in tal guisa si espresse anche la professoressa Agostina Colombo nel 2010, evidenziando la progressiva rarefazione delle famiglie de Carugo milanesi nelle fonti storiche[358]. La congiuntura politica ed economica dovette essere particolarmente penalizzante i rami milanesi dediti all’attività mercantile: non solo i settori ad essi storicamente pertinenti, ossia la manifattura tessile e quella delle armature, entrarono in una seria e protratta crisi, ma le forniture di armature che il mercante milanese Giacomo de Carugo fece pervenire al maresciallo di Francia Gian Giacomo Trivulzio tra il 1512 ed il 1515, tradiscono quelle tendenze francofile comuni a Milano tra la nobiltà ed il clero, ma soprattutto nel ceto mercantile[359]. Con l’affermarsi del dominio spagnolo, le famiglie che sostennero le ambizioni francesi in Italia, vennero per lungo tempo viste con sospetto dalla Corona spagnola, e per questo ad esse venne spesso precluso l’inserimento negli apparati di governo[360]. Non sorprende pertanto che nella prima metà del Cinquecento, alcuni membri di siffatte famiglie, come quella dei Trivulzio o dei Birago, dovettero lasciare Milano per trovare rifugio presso la corte di Francia[361].
Declino dei de Carugo Milanesi
Il Fondo Riva Finolo (1208 – 1812), in particolare l’Archivio Genealogico di Giovanni Sitoni di Scozia, conservato presso l’Archivio di stato di Milano, include uno stralcio genealogico parziale di quel ramo dei de Carugo milanesi che, rispetto agli altri, riuscì a mantenere fino alla seconda metà del Seicento i maggiori possedimenti nei pressi del territorio ancestrale di Carugo[362]. Da una polizza d’estimo conservata presso il Fondo Famiglie della Biblioteca Trivulziana di Milano, risulta che al 26 aprile 1558, Giovanni Angelo de Carugo deteneva nel territorio di Carugo un podere di circa 450 pertiche (circa 30 ettari)[363]. Alcuni atti notarili conservati presso l’Archivio di Stato di Milano, completano lo stesso albero genealogico, il quale principia così da Ottone de Carugo (detto anche “Ottorino”), vissuto nella seconda metà del Quattrocento, da cui Giovanni Agostino, da cui un altro Ottone[364] che ebbe due figli maschi, “Hieronimo” (Gerolamo) e Agostino, e due femmine, Violante e Angela[365]. Da Gerolamo un Arcangelo[366], mentre da Agostino i fratelli “Magnifici” Giovanni Antonio e Giovanni Angelo[367]. Il “Magnifico” Giovanni Angelo Carugo, vivente nel 1584, ebbe un figlio, Carlo Antonio, il quale si sposò con una Lampugnani, di cui non si fa il nome di battesimo. Essi ebbero quattro figli, tutti viventi nel 1736, di cui due figlie femmine entrambe ammogliate: Marianna sposatasi con Antonio Maria Casanova, e Angela Catterina con Filippo Martini de Besana; e due figli maschi: Basilio e Gerolamo, con i quali però, essendo questi divenuti entrambi frati agostiniani scalzi, il ramo probabilmente si estinse[368].
Per quanto concerne i vasti possedimenti di questo ramo della famiglia de Carugo, il sopracitato Fondo Famiglie della Biblioteca Trivulziana di Milano include tre suppliche, datate rispettivamente 6 febbraio 1688, 19 luglio 1689, e 21 marzo 1696, rogate per conto di Carlo Antonio de Carugo, ed indirizzate a diversi tribunali, le quali tradiscono un clima d’indebite pressioni, “ingiuste molestie”, nonché addirittura sequestri da parte dei “Commissari de Perticati” a danno di vari possedimenti terrieri facenti capo a Carlo Antonio de Carugo[369]. Nello stesso periodo, in particolare tra il 1682 ed il 1688, la contessa Borromeo Arese perseguì una intensa politica d’acquisto sul medesimo territorio a scapito dei conti Marliani, i quali vendettero fondi per un totale di lire 36,450[370]. L’interesse dei conti Borromeo per il territorio di Carugo è riconducibile alla realizzazione della cosiddetta Roggia Borromeo, il canale irriguo artificiale per mezzo del quale le sorgenti di detto territorio alimentarono i giardini di Palazzo Arese Borromeo presso Cesano Maderno. I possedimenti di Carlo Antonio de Carugo includevano anche il “laghetto di Carugo”, alveo d’origine naturale affiorante nei pressi dell’antica torre di famiglia (i.e. Torre di Carugo). Il cavo del laghetto venne venduto il 25 giugno 1689 a donna Granella Clerici Giussani, figlia del marchese Carlo Clerici, nonché moglie di Giovanni Giussani, figlio di Ottone ed erede di Giovanni Battista Giussani, protofisico generale di Milano tra il 1644 ed il 1655, citato nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. L’intera proprietà nei pressi del laghetto di Carugo, tappa fondamentale sul tracciato della Roggia Borromeo, venne infine venduta da Carlo Antonio Carugo al conte Carlo Borromeo Arese il 16 gennaio 1728[371].
Ufficiali Ducali
Nipote di Benedetto de Carugo, quindi figlio del Giovanni Antonio de Carugo che nel 1514 fu nominato Commissario di Sanità straordinario a vita[372], Pietro Paolo de Carugo, milanese, nato intorno al 1520 e morto nel 1594, sposatosi in seconde nozze con Cleopatra Cremona, fu Ragioniere Generale del Vicariato della Città di Milano, quindi responsabile della contabilità di tutte le entrate e le spese del Dominio, nonché Ufficiale nel Magistrato straordinario all’Ufficio delle Biade[373]. Attorno al 1575 entrò in una compagnia d’affari con Francesco Lucini, esponente della nobile ed antica famiglia comasca dei de Lucini[374]. Il primo aprile 1594 dispose testamento a favore dell’unico figlio Giovanni Battista de Carugo e dei suoi discendenti, con sostituzione a favore dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano allorquando la propria linea dovesse estinguersi. Per ragioni non ancora del tutto chiare, la disposizione diede luogo ad una causa risolta il 5 ottobre 1596 mediante una sentenza aggiudicante circa i tre quarti della vasta eredità all’Ospedale, al quale pervennero una casa in San Babila, alcuni stabili a Lugagnano ed oltre lire duemila[375].
A dare inizio allo scontro giuridico fu lo stesso Ospedale, il quale impugnò la procedura testamentaria così come l’ebbe definita il testatore Pietro Paolo de Carugo, riuscendo infine ad impadronirsi della maggior parte dell’eredità, a danno del figlio Giovanni Battista. La proattività dell’istituto va forse collocata nell’ambito della grave lite decennale ch’esso ebbe con il Collegio dei Nobili, la quale minacciava l’esistenza stessa dell’Ospedale[376]. Il diverbio, che ebbe inizio nel luglio del 1596, venne risolto soltanto nel 1606 e coinvolse le massime autorità dell’epoca: Papa Paolo V ammonì l’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo di non interferire pena la scomunica, il Governatore di Milano Pedro Enríquez de Acevedo conte di Fuentes ed il Consejo de Estado, su ordine del re di Spagna Filippo III, elessero nuovi protettori dell’Ospedale[377].
Il legato di Pietro Paolo de Carugo, il primo incisivo nella storia dell’Ospedale Fatebenefratelli, permise l’istituzione della Quadreria dei Benefattori, la cui collezione ebbe inizio con un ritratto di Pietro Paolo all’età di quindici anni[378]. Al proprio ritratto si aggiunge la pala della chiesa di S. Maria d’Aracoeli, “Madonna col Bambino e S. Giovanni di Dio”, sec. XVI, ora custodita presso il Rettorato dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, ove Don Carlo d’Aragona, Duca di Terranova, è attorniato da alcuni benefattori, tra i quali probabilmente figura nuovamente Pietro Paolo de Carugo[379].
Ritratto di Pietro Paolo de Carugo all’età di 15 anni, sec. XVI, custodito presso la Quadreria dei Benefattori dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano[380].
L’Ascesa dei Rami Oriundi
Contestualmente al declino dei rami de Carugo milanesi, si ebbe l’affermazione dei suoi rami oriundi, in particolare quelli che si spostarono nel contado milanese, in Valtellina ed in Veneto.
La nascita dei de Carugo di Manera, Rovellasca e Misinto
Da un’analisi delle rubriche del notaio milanese Paolo Balsami, figlio di Giuliano, e di due suoi atti notarili datati 24 marzo 1513, sappiamo che il mercante e decurione milanese Donato de Carugo ebbe almeno due figlie, Paola ed Elisabetta[381]. Infine, un atto notarile risalente al 19 aprile 1560, redatto dal notaio Alessandro Carcano, figlio di Battista, suggerisce che Donato de Carugo potrebbe aver avuto anche almeno un figlio, Tommaso de Carugo[382]. Dagli atti sopracitati emerge altresì che questo ramo dei de Carugo milanesi ebbe interessi patrimoniali di una certa rilevanza a Cascina Olona, territorio di Settimo Milanese, pieve di Cesano, e a Manera, Cascina separata tra la pieve di Fino, episcopato di Como, e la pieve di Appiano, ducato di Milano.
Il primo dei sopramenzionati atti specifica che “La Speciale Signora Paola de Carugo figlia del fu Speciale Signore Donato e moglie dell’infrascritto Signor Pietro Antonio Cutica, figlio del fu Signor Bertola, residente a Porta Ticinese Parrocchia di San Tommaso in Cruce de Sigeriis, vende alla Speciale Signora Elisabetta de Carugo figlia del fu Speciale Signore Donato e sposata in seconde nozze al Signor Giovanni Battista Stampi, residente a Milano, Porta Ticinese, Parrocchia di Sant’Ambrogio in Solariolo, l’utile dominio e il naturale possesso di un sedime sito nelle Cascine di Olona, nel territorio di Settimo nella pieve di Cesano”.
Si tratta di un possedimento condiviso dalle sorelle de Carugo inclusivo oltre che di 68 pertiche e ventitré tavole, anche “lo stabile dominio e il possesso naturale di una pezza di terra a prato e campo sita a Cascina Olona” […], la possibilità di usare i fontanili presenti all’interno di questo prato. […] Inoltre l’utile dominio di un campo e prato detto “la strada”. […] Inoltre dei sedimi che si trovano nelle dette Cascine con orto, pozzo, giardino. Inoltre un campo”. Infine in aggiunta ai predetti possedimenti, Paola de Carugo vendette alla sorella Elisabetta anche il connesso diritto signorile di “richiedere il dazio per il prezzo di 3845 lire e 8 soldi”. Il tutto avvenne “con il consenso del fittabile, Don Giacomo Crivelli figlio del Magnifico Signor Antonio”. Oltre che un membro della famiglia Crivelli, il quale affittava parte dei possedimenti, si citano anche i possidenti limitrofi tra i quali compaiono “Marco Antonio e Alessandro, fratelli Crippa, [il] Magnifico Signor Girolamo Crippa, [il] Signor Antonio Meraviglia, Ambrogio Gallarati, [e] Francesco Salterio”, tutti esponenti di antiche e nobili famiglie lombarde.
Il secondo atto, siglato subito dopo il primo, riguarda invece più direttamente il marito di Paola de Carugo, “il Signor Pietro Antonio Cutica, figlio del fu Signor Bertola” il quale contestualmente acquista dal “Signor Battista Gallarati, del fu Andrea, il dominio diretto su un fitto livellario fatto al detto signor Battista per 4 lire l’anno da pagare in ogni giorno di San Michele di ogni anno, per una cifra di 4000 lire imperiali, che paga usando i soldi appena ottenuti dalla moglie con l’atto siglato precedentemente. Nello stesso giorno, la Speciale Signora Elisabetta de Carugo […] vende a Battista Gallarati, figlio del Signor Andrea, la metà di una pezza di terra che attualmente detiene a titolo di fitto livellario per 8000 lire. Inoltre lo stesso investe la Signora Elisabetta de Carugo dei beni che sono stati venduti nell’atto precedente per 40 lire l’anno, con la possibilità di redimere i beni per i successivi 4 anni”. Sostanzialmente Paola de Carugo vende alla propria sorella Elisabetta parte della propria quota dei possedimenti famigliari, al fine di finanziare il marito nell’acquisto di un nuovo podere. Contestualmente Elisabetta de Carugo smobilizza parte dei propri possedimenti, in un atto di finanziamento a quattro anni.
Se nel 1513 le sorelle Paola ed Elisabetta de Carugo parrebbero gestire i propri possedimenti nel contado risiedendo ancora a Milano, giunti al 1560, il loro fratello Tommaso sembrerebbe invece aver già lasciato la città e risiedere a Manera, così come specificato nel sopracitato atto del notaio Alessandro Carcano, figlio di Battista: “Venerdì 19 aprile 1560 durante la terza indizione, Tommaso de Carugate figlio del fu Donato residente nel luogo della Manera, Cascina separata tra la pieve di Fino, episcopato di Como, e la pieve di Appiano, ducato di Milano, promette con pegno a Francesco Alberti soprannominato il Zenario figlio del fu Giovannino, residente a Turate, pieve di Appiano, di dargli 40 lire imperiali entro il primo di settembre a causa di una certa quantità di segale, miglio […] venduta dal detto Alberti a credenza al detto de Carugate”[383].
Arma della famiglia de Bianchi di Milano.
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Arma della famiglia de Cattanei de Bregnano.
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Antica arma della famiglia de Marinonibus..
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Due ulteriori atti dello stesso notaio Alessandro Carcano, figlio del fu Battista, datati rispettivamente 13 aprile 1592 e 12 luglio 1593[384], rivelano che Tommaso de Carugo si sposò con la nobile “Speciale Signora Angela de Blanchis” (de Bianchi), ed ebbe da essa un figlio, Bernardino. Rimasta vedova, Angela de Blanchis, si risposò con il Signor Paolo de Zobiis (Giobbio), anche dal quale rimase vedova, risposandosi infine con il Signor Sigismondo de Ferrarijs (Ferrari). Tutti i figli dai primi due matrimoni, ossia Bernardino de Carughate (de Carugati), Paolo, Tommaso e Donato de Zobiis, erano stati investiti dalla madre comune di un sedime in affitto sito nel territorio di Rovellasca, che ad un certo punto non avevano più pagato alla stessa madre. Il 13 aprile 1592, per saldare il loro debito vendettero alcuni dei detti beni, con la possibilità di ricomprare quanto venduto entro cinque anni. Nell’ambito della medesima trattativa, Francesco Bernardino de Ferrarijs, figlio che Angela de Blanchis ebbe dal terzo marito Sigismondo de Ferrarijs, residente a Milano, Porta Nuova, Parrocchia di San Fedele, agì in qualità di procuratore speciale di sua madre.
Il 12 luglio 1593 Bernardino de Carughate figlio del fu Tommaso, residente a Rovellasca, riacquistò il proprio possedimento, detto “al campo della costa”, il quale confinava con le proprietà di Francesco Cattaneo, e di “Petrino de Carughate della Manera”, forse fratello o cugino del padre Tommaso.
Giovanni Pietro de Carugo, figlio di Bernardino, nacque a Rovellasca intorno al 1540. Si sposò prima con Maddalena, dalla quale ebbe due figli, Giovanni Antonio e Pietro Martire de Carugo, dopodiché, rimasto vedovo, il 21 febbraio 1574 si risposò a Rovellasca con Catalina de Colombino, figlia di Giordano (il cognome della famiglia in questo atto venne attestato come “di Caruga”, riavvicinandosi così alla forma originaria)[385].
Giovanni Antonio de Carugo nacque a Rovellasca nel 1569[386]. Nella stessa città il 10 febbraio 1591 sposò Margherita Cattaneo, figlia di Antonio[387]. Fu questo il primo di diversi matrimoni tra i discendenti in linea patrilineare di questo ramo dei de Carugo ed esponenti della nobile famiglia Cattaneo[388]. Quest’ultima appartiene all’antica stirpe dei Capitanei (Cattanei) di Bregnano, esistente sin dal 1200’ con un notaio Guglielmo del fu Bernardo. Oltre che a Rovellasca, è documentato che si portarono anche nella limitrofa Cermenate, in Sondrio, in Menaggio, ed ebbero una certa importanza anche in tutto il Lario occidentale, in Musso, Pianello e Blevio.
Giovanni Antonio de Carugo fu un possidente terriero di media rilevanza, al quale le fonti superstiti attribuiscono 85 pertiche quadrate milanesi, di cui 24 pertiche nel comune di Bregnano, 3 in quello di Rovello, e le rimanenti a Rovellasca, nonché una residenza in proprietà con corte, pergola e chiostro[389]. Giovanni Antonio de Carugo e Margherita Cattaneo ebbero un figlio, Giovanni Pietro de Carugo, nato a Rovellasca attorno al 1595. Quest’ultimo fu uno dei tre capifamiglia della stessa stirpe che il 17 luglio 1628 furono chiamati a giurare fedeltà al nuovo feudatario, il conte Luigi Arconati figlio di Galeazzo[390]. Giovanni Pietro e sua moglie Elena ebbero due figli: Giovanni Battista de Carugo, nato a Rovellasca il primo giugno 1621, e Margherita nata nella stessa città il 19 marzo 1625[391].
Giovanni Battista de Carugo sposò Elisabetta Marinoni, discendente della nobile ed antichissima famiglia dei Marinoni della limitrofa Lurago Marinone, città al quale diedero il nome, ed avente il proprio capostipite nel “Giulio Marinoni uomo nobilissimo” menzionato in una iscrizione del 1216 posta nell'antica parrocchia di San Giorgio[392]. Giovanni Battista ed Elisabetta ebbero cinque figli, tutti nati a Rovellasca: Marta, nata il 21 dicembre 1646, Elisabetta Catterina, nata il 30 settembre 1647, Elisabetta Margherita, nata il 20 luglio 1650, Antonio Maria de Carugo, nato il 22 settembre 1651, infine Maddalena, nata il 27 settembre 1653[393].
La graduale estensione di quella che agli albori del Settecento divenne una prosperosa discendenza, si riflesse nell’attribuzione ai rispettivi capifamiglia di soprannomi distintivi dei diversi nuclei famigliari de Carugo – Carugati. Di questi il più antico fu “Ometto”, il quale s’impose altresì come nome di quella parte di Rovellasca ove si concentrava la maggiore parte dei possedimenti famigliari. Questi si distribuivano lungo la “Contrada dell’Ometto”, territorio compreso tra le attuali via Felice Cavallotti, e quella che sul finire dell’Ottocento si distinse quale residenza della contessa Bianca Gabardi (Villa Bianca Gabardi)[394].
Antonio Maria de Carugo ebbe un figlio, Vittore, nato a Rovellasca nel 1682 e sposatosi con Caterina Cattaneo a Misinto l’8 novembre 1701[395]. Il 20 agosto 1701 Antonio Maria accrebbe la propria attività, aggiungendo alla gestione dei propri possedimenti, i fondi in Lazzate ricevuti in locazione dai deputati del Pio luogo di soccorso delle fanciulle di Como, meglio noto come “Conservatorio delle zitelle”[396].
L’Ascesa del Ramo Valtellinese: i de Carugo Cancellieri Generali di Tutta la Valtellina
Nel 1512, concomitantemente al momento del crollo del governo francese sul ducato di Milano, le milizie della Repubblica delle Tre Leghe (attuale Cantone svizzero dei Grigioni) capitanate da Conradin von Planta occuparono militarmente la Valtellina, i contadi di Bormio e Chiavenna, e le tre pievi dell'Alto Lario, all’epoca tutti domini milanesi. Qualora i rapporti instaurati all'indomani dell'occupazione tra i Grigioni, la Valtellina e i contadi fossero basati su di un rapporto paritario piuttosto che di sudditanza fu oggetto di controversie, tuttora irrisolte, fin dal XVII secolo[397].
In linea generale, i Visconti, gli Sforza, e poi i Grigioni, non intaccarono gli organi di autogoverno della Valtellina, i quali rimasero espressione delle sue autonomie locali ed organizzazioni sovracomunali. I singoli comuni avevano per capo un Decano o un Console. L’insieme dei Decani o Consoli facenti parte della stessa giurisdizione, detta Terziere, si riuniva in un consiglio presieduto da un Cancelliere, al quale si aggiungevano solitamente quattro Consoli di Giustizia, nonché agenti e servitori. A detto Consiglio di Terziere spettava la nomina dei Consoli di Giustizia, l'approvazione delle nomine dei notai, la ripartizione delle spese tra i comuni, la nomina di un proprio Cancelliere e propri agenti al Consiglio di Valle. Infine, a presiedere il Consiglio di Valle, massimo organo di autogoverno della Valtellina ove si riunivano gli agenti o consoli nominati dai Consigli di Terziere, vi era un Cancelliere detto “di Valle”. Gli statuti rogati dal Cancelliere di Valle erano soggetti all'approvazione dei Signori delle Tre Leghe, i quali erano poi tenuti ad amministrare la giustizia nel rispetto di detti statuti[398].
Spectabilis Dominus Giovanni Antonio de Carugo figlio di Ser Dominus Bartolomeo de Carugo e Giacomina Quadrio, figlia di Serafino Quadrio, fu Cancelliere di Valle, ossia Cancelliere di tutta la Valtellina almeno a partire dell’anno 1513. Il tredici aprile dello stesso anno, Giovanni Antonio de Carugo “Cancelliere generale di tutta la Valtellina” appare tra i rogatari dei documenti di alleanza con la Lega Retica dei Grigioni, in particolare “de' mille Fiorini pagati in virtù del capitolo quinto di tale alleanza, e le lettere circolari per le quali la Valtellina era eccitata a spedire i suoi Consiglieri a sedere nella Dieta; come pure gli atti autentici, onde consta, che i Valtellinesi soscrivevano Confederati de' Grigioni”[399].
Giovanni Antonio de Carugo fu Cancelliere di Valle per oltre quarant’anni, fino al 22 dicembre 1456, data della sua morte[400]. Per un giudizio storiografico sul lungo cancellierato di Giovanni Antonio de Carugo, si riporta quanto espresso dalla professoressa presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, Marta Luigina Mangini, nella sua ricerca sulle delibere consiliari relative alla prima fase di governo delle Tre Leghe in Valtellina: “quella di Gian (Giovanni) Antonio Carugo è sicuramente una figura chiave nel processo di elaborazione e trasmissione dei pubblici atti di Valtellina, non foss’altro che per il prolungato incarico ricoperto in anni cruciali per la definizione dei rapporti interni ed esterni alle università federali della Valtellina”[401], ove, in questo contesto, con il termine “università” s’intende l’ “universitas Trium Ligarum Alamanie”[402] ossia lo stato dei Grigioni.
Dall’esteso cancellierato di Giovanni Antonio derivò un’ugualmente estesa produzione documentaria, alla quale si aggiungono gli atti relativi a negozi stipulati tra privati. La conservazione denota tuttora un carattere dispersivo e policentrico[403]. Oltre all’Archivio di Stato di Milano, anche il fondo Notarile (1001) presso l’Archivio di Stato di Sondrio conserva numerosi atti attribuiti al Cancelliere Giovanni Antonio, tra cui due registri con atti dal 1530 al 1556. Si illustrano in questa sede, a titolo esemplificativo, solo alcuni tra gli atti editi:
· 20 settembre 1527: “Giovanni Antonio de Carugo, è cancelliere per gli ordini del capitano e governatore generale della Valtellina Jörg Beeli von Belfort e Johann Guler”[404];
· 13 dicembre 1531: “Un Censo più regolare fu attuato per voto del Consiglio generale di Valle, a rogito 13 dicembre 1531 del cancelliere Giovanni Antonio Carugo, il Censimento in Valtellina venne rinnovato e migliorato”[405];
· 30 ottobre 1533: le tensioni tra le consorterie di Valleve e i comuni di Fusine e Colorina sul controllo degli alpeggi trovarono una soluzione il 30 ottobre 1533 nel cosiddetto “Arbitramento Carugo”, il quale fu l’atto di spartizione territoriale firmato dal notaio Giovanni Antonio Carugo, secondo il quale i monti Campo, Dordona e Vitalengo (Val Madre) sarebbero stati assegnati al comune di Fusine, mentre quelli di Bernasca al comune di Colorina[406].
· 15 aprile 1549: “Anno del Signore 1549. a quindici giorni del mese d’Aprile li presenti Statuti furono pubblicati nel Consiglio generale di tutta Valtellina nell’entrata, ed accettazione dell’Ufficio del Mag. Signor Giovanni de Marmorcra [Johann von Marmels], Capitano e Governatore di essa Valle, de la qual pubblicazione ne fu rogato Messer Giovanni Antonio Carugo Cancellano della detta Valle”[407];
Per quanto concerne il proprio patrimonio privato, il cancelliere Giovanni Antonio de Carugo ebbe interessi nella siderurgia. In un atto notarile risalente al 1542, viene citata una fucina di sua proprietà operante nel territorio di Piateda[408].
L’Ascesa del Ramo Veneto
Il ramo veneto della famiglia de Carugo è annoverato nel Libro d’Argento della Cittadinanza Originaria veneziana, regolata sin dal 1305[409]. Secondo il pensiero di Donato Giannotti, i cittadini veneziani originari discendevano da famiglie di antico lignaggio le cui casate in occasione della Serrata del Maggior Consiglio si trovarono escluse dall’accesso alle cariche di governo[410]. In base alla legge del 3 luglio 1569, allorquando gli Avogadori iniziarono a compilare il registro dei cittadini originari, detto Libro d’Argento, i requisiti minimi per l’appartenenza a tale ceto includevano una prova di discendenza legittima da almeno tre generazioni di cittadini veneziani, i quali non dovevano essere o essere stati dediti ad alcuna “arte meccanica” (manuale), ma piuttosto ad occupazioni che recassero un carattere di “onorevolezza”, ossia che fossero apprezzate dalla società e permettessero di “viver da gentilhuomo”. La mercatura era accettata unicamente se “grossa”, cioè di ampia portata finanziaria. A questi requisiti si aggiungevano la capacità contributiva alle spese del comune e l’estraneità ai cosiddetti “libri di Raspa”, ove si registravano i procedimenti giudiziari[411].
Alla classe dei cittadini originari, unitamente alla tutela giuridica, si attribuivano molteplici privilegi tra i quali la piena libertà di partecipare alle grandi avventure commerciali e bancarie al fianco dei patrizi[412], la libertà di unirsi in matrimonio con le famiglie patrizie[413], la pratica di professioni in altre circostanze riservate ai soli patrizi come l’avvocatura ed il notariato, e l’accesso ai massimi incarichi amministrativi e diplomatici. Quest’ultime in particolare divennero gradualmente appannaggio esclusivo dei cittadini originari, facendo di questi un’élite sociale di funzionari-cittadini. Le leggi emanate nel 1410 e nel 1438 dal Consiglio dei Dieci attribuirono ai cittadini originari l’accesso esclusivo alle cariche di comando delle Scuole Grandi[414]. In base alla legge emanata nel 1419, i cancellieri ducali e i notai che avrebbero dovuto accompagnare i rappresentanti dello Stato durante le missioni diplomatiche sarebbero dovuti appartenere all’élite dei cittadini originari. Nel 1478 il Consiglio dei Dieci stabilì che l’ingresso alla Cancelleria Ducale fosse privilegio esclusivo dei cittadini originari[415]. A capo della Cancelleria Ducale vi era il Cancelliere Grande, massima carica amministrativa, seconda sola a quella del Doge e dei suoi consiglieri. Nel figura del Cancelliere Grande, di fatto, si ebbe il vertice della classe dei cittadini originari[416]. Spesso sorteggiati come grand commis dei servizi parlamentari, di quelli giudiziari, dei grandi governatorati nonché degli alti comandi navali e delle cariche ecclesiastiche, si annoverano cittadini originari tra i primi consiglieri presso le ambasciate, come rappresentanti diplomatici e funzionari rispettivamente presso le più illustri corti e magistrature[417].
Giudici alla Ragione e Dazi
Nel 1587 l’eccellentissimo dottor Pietro Carugo, figlio di Pietro, cittadino padovano della contrada di S. Bartolomeo[418], è Giudice alla Ragione e Dazi per la città di Bergamo durante il periodo di dominio veneziano[419]. L’elezione avveniva per voto del consiglio dei Dieci di Venezia, uno dei massimi organi di governo della Repubblica di Venezia. La carica poteva essere assunta esclusivamente dai dottori delle città suddite (ad esclusione di quella in cui venivano destinati), che avessero conseguito la laurea dottorale presso lo Studio di Padova[420]. Il giudice Pietro Carugo compare in un atto nel quale si dispone su degli insoluti assieme ai Vicari Pretori Alessandro Lisca e Domenico Azzalino, ed ai Consoli di Giustizia Lattanzio Marchesio e Galeazzo Vertova.[421] Fu amico confidente di Nicolò Trevisan, rinomato professore di medicina nonché Priore del Sacro Collegio artista dell’Università di Padova. Il 12 aprile 1607 Pietro Carugo comprò da Nicolò Trevisan terreni nella vicaria di Mirano per 200 ducati[422]. Alla morte di Nicolò, Pietro Carugo agì nella veste di esecutore testamentario, e ricevette in legato un anello d’oro[423].
Il cittadino originario veneziano messer Francesco Carugo, Iuris Utriusque Doctor, cioè giurisperito dottore in diritto civile e canonico, figlio di Vincenzo Carugo, nel 1574, 1576 e 1578 fu membro dell’organo direttivo della Scuola Grande di Santa Maria della Carità, detto “Zonta”. Nel 1573 fu candidato in qualità di difensore delle proprietà della scuola, nel 1575 in qualità di vicario, nel 1577 e nel 1579 come sindico. Infine, nel 1577, 1578 e 1581 Francesco Carugo si candidò per la posizione di guardian grande[424].
Il 5 novembre 1580, Polissena, seconda moglie di messer Francesco Carugo, elargì uno stipendio al capitolo della Chiesa di Santa Maria Formosa per la realizzazione di una mansionaria dedicata alla Pietà[425]. Allorquando Polissena fece testamento, il suo sarcofago fu già completato e posizionato frontalmente rispetto all’altare[426]; quest’ultimo invece venne ultimato successivamente alla sua morte. A memoria dei suoi committenti, Francesco Carugo appare nelle vesti di S. Francesco d’Assisi, Polissena in quelle della Beata Vergine Maria, e le iscrizioni ne ricordano l’affetto reciproco e le loro intenzioni[427]:
“Polyxena tibi Carugus cultor amoris hunc tumulum atq(ue) aras ad tua vota facit sunt area memoranda tuae pietatis imago et tumolo duplices contegis umbra viros”, ossia ‘‘Oh Polissena, per te Carugo, cultore dell’amore, secondo i tuoi voti eresse questa tomba e questo altare, immagine memorabile della vostra pietà; nel sepolcro proteggi due uomini con la tua ombra”[428].
Messer Francesco Carugo, nell’ambito della propria attività legale, risulta aver supportato in più istanze, in qualità di arbitro, di rappresentante e di testimone, Orazio Vecellio, figlio del noto pittore, conte palatino, Tiziano Vecellio[429]. In considerazione della vicinanza tra Tiziano e messer Francesco Carugo, alcuni storici considerano verosimile l’ipotesi che la Pietà raffigurante i Carugo non sia opera di Jacopo Palma ma piuttosto dello stesso Tiziano[430].
Ulteriori esponenti nobili e notabili
Per dirimere le contese nate tra gli eredi del comense Dominus Cristoforo de Carugo, nel 1537 si dovette coinvolgere il rinomato giurista senese Mariano Socini il giovane, ossia lo stesso giurista che alcuni anni prima venne consultato dal re d’Inghilterra e d’Irlanda Enrico VIII e che in tale istanza argomentò che il sovrano fosse libero di sposare Anna Bolena, essendo invalida la dispensa papale mediante la quale egli sposò Caterina d’Aragona[431].
Jacopo Palma il Giovane (1548-1628). Pietà ca.1581-90, Santa Maria Formosa, Venezia. Il committente messer Francesco Carugo appare nelle vesti di S. Francesco d’Assisi.
copyright © Artfritz.ch
Nel caso afferente alla vasta eredità del dominus Cristoforo de Carugo, il testatore istituì sua figlia Giacomina de Carugo erede universale. Morta prematuramente domina Giacomina ed alcuni dei suoi figli, il noto giurista venne chiamato a chiarire se l’eredità dovesse essere spartita con le pronipoti Giacoma e Margherita de Carugo, ovvero assegnata in pieno all’unico nipote maschio superstite Giovanni Maria de Carugo[432].
Il 15 febbraio 1577 Giovanni Ambrogio Carugo, figlio di Francesco, dispone nel proprio testamento che il giuspatronato di sua ragione in Cantù, ossia la propria cappella di famiglia, debba spettare al monastero di San Francesco di Milano in caso di estinzione della propria famiglia[433].
Illustrazione rappresentativa d’un ufficiale del reggimento di fanteria K.u.k.“Infanterie-Regiment “Jacob Robert von Nugent-Westmeath” Nr. 56 per l’anno 1778.
Acquarello del 1910 pertinente alla collezione Vinkhuijzen.
“Officiers v. Infanterie Regt. Nugent. 1778", General Research Division, The New York Public Library Digital Collections, accessed October 20, 2024
Nel settembre 1706, Eugenio di Savoia, alla testa delle truppe imperiali, prese controllo della città di Milano. La guarnigione ispano-francese, che continuò a resistere per diversi mesi, circoscritta ed assediata all’interno del castello di Porta Giovia, si arrese infine il 14 marzo 1707. I trattati di Utrech del 1713 e di Rastadt del 1714 ufficializzarono il dominio imperiale sul Ducato di Milano.
Terminavano così circa due secoli di dominio spagnolo, nell’arco dei quali lo Stato di Milano divenne tra le più importanti piazze d’armi della monarchia, nonché il territorio italiano maggiormente militarizzato[434]. Nello stesso periodo, i sudditi milanesi concorsero allo sforzo bellico della monarchia spagnola mediante un’ampia e diretta partecipazione alle campagne militari, nelle quali assursero ai più alti gradi di comando militare e politico[435].
L’avvento della monarchia austriaca in Lombardia coincise con l’introduzione di un sistema di riforme, emblematiche della politica dell’assolutismo illuminato, per mezzo delle quali vennero effettuati cambiamenti radicali del modello organizzativo ereditato dalla Spagna. Particolare attenzione venne posta nel catasto, nella finanza pubblica, nella semplificazione amministrativa, ma soprattutto nella modernizzazione delle strutture militari[436].
Nel XVIII secolo, la competizione tra le grandi potenze europee impose ai rispettivi sudditi spese militari senza precedenti. Non solo durante i conflitti, ma anche in tempo di pace, allorquando vennero prioritizzati importanti investimenti d’ammodernamento[437]. Per rispondere a tali necessità, anche in Lombardia molte delle riforme furono incentrate sulla doppia componente fiscale-militare[438]. Vennero progressivamente accentrate le strutture fiscali ed amministrative lombarde con le rispettive austriache; allo stesso modo le strutture militari lombarde vennero integrate con l’esercito austriaco. Si ricordano in tal senso le riforme di semplificazione amministrativa come quella delineata dal comandante militare della Lombardia Austriaca Ludwig Andreas Khevenhüller, la soppressione dell’appalto generale del “rimplazzo” per aggiudicare le commesse direttamente ai singoli appaltatori, l’abolizione dei governatori delle piazzeforti lombarde (eccezion fatta per le piazzeforti di Milano, Mantova e Pizzighettone), il rafforzamento del Consiglio Aulico di Guerra negli affari italiani, il subordinamento al commissariato generale di guerra di Vienna dell’intera amministrazione finanziaria militare della Lombardia, l’introduzione di un nuovo sistema censuario condotto non più da signori laici ed ecclesiastici, ma dagli ufficiali dello Stato e dell’esercito, e l’istituzione di distretti di reclutamento su base parrocchiale.
L’insieme di questi provvedimenti da un lato perseguiva obiettivi d’efficientamento dell’ingente spesa militare, dall’altro quello di massimizzazione delle entrate fiscali mediante la riorganizzazione della base imponibile e del sistema di esazione. Allo stesso tempo però, non in via intenzionale ma collaterale[439], tali innovazioni scardinarono il tradizionale sistema con cui il patriziato interponeva la sua mediazione, smantellarono istituzioni ove tradizionalmente trovavano posto esponenti del patriziato lombardo e privarono i consigli decurionali della maggior parte dei loro poteri di direzione e controllo sull’amministrazione locale. In altre parole, sconvolgevano la tradizionale struttura cetuale della società[440].
L’influenza della nobiltà lombarda nei confronti del potere sovrano andò gradualmente riducendosi. Il patriziato dovette rinunciare al controllo esclusivo sulle magistrature ed amministrazioni centrali e territoriali, nonché al proprio tradizionale dominio sulle sfere culturali ed ecclesiastiche. Dovette coesistere con una nuova burocrazia eterogenea per origini geografiche, sociali e valoriali, talvolta estranea alle antiche tradizioni lombarde ed influenzata dalla cultura illuminista[441]. L’intenzione della corona asburgica non fu quello di penalizzare la nobiltà lombarda, piuttosto quello di allinearla con i canoni vigenti presso la monarchia austriaca, ove la nobiltà era maggiormente legata alla corte ed al sovrano, ed ove la sua facoltà d’affiancare il monarca nelle funzioni cerimoniali e di governo dipendeva anche dall’acquisizione di una nobiltà di dignità regia. Tra le più evidenti traduzioni pratiche del nuovo contesto così come sopradescritto, vi è l’istituzione risalente al 1769 del Tribunale Araldico, tramite il quale la distinzione e la composizione del ceto patrizio veniva subordinata al riconoscimento da parte di un tribunale sovrano, contrariamente alla tradizione degli Stati dell’Italia settentrionale che ne legava l’origine alla partecipazione dei propri esponenti alle cariche di governo[442].
A queste si aggiunsero ulteriori sfide, sia per la nobiltà lombarda che per quella austriaca. Tradizionalmente né l’una né l’altra trovavano la propria distinzione nell’ufficialità militare ma piuttosto negli impieghi nell’amministrazione civile. Le importanti trasformazioni nell’organizzazione militare asburgica, avviate a partire dagli anni 1748-49, mirarono anche a ribaltare tale consuetudine incoraggiando la nobiltà ad impegnarsi nell’esercito. Per ordine dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, dopo un periodo di trent’anni di distinto e meritevole servizio, gli ufficiali dell’esercito sarebbero stati nobilitati e ritenuti degni di essere ricevuti a corte. Le loro precedenze nei cerimoniali furono stabilite sulla base di nuove corrispondenze tra i gradi militari e le cariche di corte. In occasione di cerimonie solenni gli ufficiali si sarebbero distinti grazie alla loro uniforme militare. Una simile equipollenza tra nobiltà e ufficialità militare traspare altresì dalle condizioni di ammissione alla neocostituita accademia militare per la formazione dei gradi superiori del corpo degli ufficiali di Wiener Neustadt, Theresianische Militärakademie, secondo le quali sarebbero stati ammessi duecento aspiranti, di cui cento nobili e cento tra i figli degli ufficiali meritevoli, i quali congiuntamente avrebbero costituito il “corpo dei nobili cadetti”. Nel 1757 venne fondato l’Ordine militare di Maria Teresa, che sotto l’imperatore Francesco Giuseppe avrebbe incluso la concessione di titoli nobiliari ai suoi insigniti. Infine nel 1766 venne adottato il modello prussiano di reclutamento. Non sorprende pertanto che già nel 1790 i 2/3 del corpo ufficiali fossero di nobiltà recente[443].
Nell’arco di alcuni decenni il concetto di nobiltà andò ad identificarsi sempre più con quello di carriera militare, sicché molti tra i patrizi milanesi videro nel loro servizio militare nell’esercito imperiale una strategia per l’accrescimento della propria influenza a corte, a beneficio delle proprie famiglie e dei propri discendenti. Da questa sarebbero anche derivate assegnazioni d’uffici capaci di consolidare il potere e l’influenza delle proprie famiglie nei rispettivi territori d’origine[444].
Come delineato dalle seguenti testimonianze, le quali rappresentano quanto rinvenuto anche solo da un’esamina molto parziale delle fonti, numerosi esponenti della famiglia de Carugo servirono nell’esercito imperiale. Per molti di essi la carriera militari e la loro appartenenza anche ai più alti gradi dell’esercito rappresentò l’occasione per una nuova ascesa sociale e nobilitazione.
Frontespizio illustrato del secondo volume edito a Vienna nel 1863; studi genealogici ed araldici sulla nobiltà tedesca fiorente e defunta ad opera dell’araldista e genealogista di Monaco di Baviera Otto Titan von Hefner.
Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland herausgegeben von einigen deutschen Edelleuten, enthaltend zuverlässige und urkundliche Nachrichten über 9898 Adels-Geschlechter, 2 | Digitalisierung: Bayerische Staatsbibliothek | Datenpartner: Bayerische Staatsbibliothek |
Tenente colonnello “Oberstleutnant” Cajetan (Gaetano) de Carugo
Il 5 gennaio 1716, il comandante dell’Imperial e Regio reggimento di fanteria Nr. 59 “Erzherzog Rainer”, il conte del Sacro Romano Impero (“Reichsgraf”) Anton Egidius von Tollet, morì a Hermannstadt dopo una lunga malattia. Su richiesta del presidente del Consiglio di guerra di Corte (“Hofkriegsraths”), il tenente principe Eugenio di Savoia, il reggimento fu riassegnato con lettera di nomina datata 4 febbraio 1716 al colonnello Ottokar conte von Starhemberg[445]. Nell’ottobre del 1721 venne ordinato il ridimensionamento di alcuni reggimenti in Italia e nel novembre dello stesso anno il capitano (“Hauptmann”) Carugo venne ricollocato dal reggimento di fanteria “Bayreuth” a quello intitolato “von Württemberg”[446]. Il 15 novembre 1723, il Generalfeldwachtmeister Ottokar conte von Starhemberg fu promosso a tenente feldmaresciallo ed il 2 dicembre, il comandante del reggimento di fanteria Nr. 59 “Erzherzog Rainer” (al quale evidentemente il capitano Carugo venne trasferito tra il 1721 ed il 1723), tenente colonnello Georg Ludwig von Wangenheimb, ottenne il grado di colonnello. Di conseguenza, il maggiore Adrian Rudolf von Schenckinck venne promosso a tenente colonnello, e il capitano di maggiore anzianità Cajetan de Carugo ottenne il grado di maggiore (“Oberstwachtmeister”)[447]. Il maggiore Cajetan de Carugo mantenne un rapporto epistolare diretto con il principe Eugenio di Savoia, con il quale soleva identificarsi mediante il proprio nome in lingua italiana, i.e. “Gaetano”, piuttosto che per mezzo dell’equivalente di lingua tedesca “Cajetan”[448]. La prestigiosa società araldico-genealogica viennese Adler, in uno studio pubblicato nel 1885, identifica il maggiore Gaetano Carugo nel maggio del 1728 di stanza a Trapani con responsabilità dell’economia e della guarnigione del reggimento di fanteria intitolato al barone von Bettendorff. Nello stesso studio vennero rinvenute anche informazioni biografiche ed araldiche sugli ufficiali del reggimento: il maggiore Gaetano de Carugo sembrerebbe fregiarsi di uno stemma araldico inclusivo di grifone rivoltato a sinistra, sul cui capo galleggia una corona[449].
Nell’agosto dello stesso anno, il maggiore Cajetan de Carugo venne posto a comando provvisorio dell’unità di cinquanta uomini posta ad occupazione della città di Licata (Sicilia), facente parte della guarnigione di Palermo, non rinunciando però al mantenimento della propria compagnia nel reggimento (il Regno di Sicilia divenne parte dei domini dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo nel 1720 con la firma del Trattato dell’Aja)[450]. Nel 1731 essendo stato promosso comandante effettivo, e non più provvisorio dell’unità di Licata, la sua posizione di maggiore del reggimento venne assegnata al capitano Lambert de Messin[451].
Resistette valorosamente all’invasione Spagnola dall’estate del 1734 fino al 1735, allorquando venne catturato e fatto prigioniero di guerra. Rilasciato nel 1736, fece ritorno a Vienna ove venne promosso al grado di tenente colonnello (“Oberstleutnant”) e riassegnato al proprio reggimento, del quale assunse il comando (“Regiments-Kommando”) a partire dal 1737, in sostituzione del colonnello von Freytag[452]. Morì il 21 aprile dello stesso anno nella città di Kronstadt (odierna Brașov, Romania)[453].
Tenente colonnello “Oberstleutnant” Johann Peter de Carugo
Con lettera d’incarico datata 9 dicembre 1760, il tenente colonnello Benedikt Eustach von Wider fu nominato colonnello e comandante del reggimento Gaisrugg, il 1° maggiore Richard de Pierce a tenente colonnello, il 2° maggiore conte Hohenfeld a primo, ed il capitano di maggiore anzianità Johann Peter de Carugo a secondo maggiore del reggimento. Nel 1761 il maggiore Johann Peter de Carugo prese il comando del battaglione di circa cinquecento uomini distaccato a Vienna[454].
Per tramite della risoluzione imperiale (“Kaiserlicher Entschließung”) datata 13 marzo 1765 Johann Peter de Carugo venne promosso al grado di tenente colonnello. L’otto luglio dell’anno successivo venne trasferito col medesimo grado al Reggimento di fanteria Nr. 47 “Bayreuth”[455]. Morì il 17 maggio 1769 col medesimo grado[456].
Tenente colonnello “Oberstleutnant” Heinrich Carugo
Heinrich Carugo nacque a Mantova il 22 settembre 1748, figlio di un maggiore dell’Imperiale e Regio esercito (il 22 marzo 1753 Maria Teresa d’Austria stabilì tramite regio decreto che la principale piazza d’armi dei possedimenti italiani sarebbe stata la città di Mantova[457]), entrò nell’Accademia militare Teresiana di Wiener-Neustadt (“Theresianische Militärakademie”) il 27 giugno 1763, divenne aspirante ufficiale (“Fähnrich”) nell’esercito del ducato di Brauschweig-Wolfenbüttel (Inf nr10) il 25 giugno 1769. Il 15 agosto 1772, venne promosso al grado di luogotenente, ed infine l’11 marzo 1777 a quello di tenente colonnello. Prese parte alla campagna del 1788 contro i turchi. Morí il 2 ottobre 1789 a Budweis (České Budějovice, Repubblica Ceca)[458].
Tenente “Leutnant” Emanuel von Carugo
Emanuel von Carugo nacque a Krumau (Český Krumlov, Repubblica Ceca) il 20 settembre 1750, figlio di un tenente colonnello, entrò nell’Accademia militare Teresiana di Wiener-Neustadt (“Theresianische Militärakademie”) il 23 giugno 1765. Il primo ottobre 1770 venne promosso al grado di aspirante ufficiale (“Fähnrich”) nell’Imperial e Regio reggimento di fanteria Nr. 59 “Erzherzog Rainer” nel periodo in cui Franz von Daun und Thiano fu Inhaber. Emanuel von Carugo morì a Pest il 25 marzo 1791 col grado di tenente[459].
L’illustre (“praenobili”) Pietro Paolo de (von) Carugo servì col ruolo di “Supremo Vigiliarum Praefecto” nell’Esercito dell’Imperatore del Sacro Romano Impero, agli ordini del generale austriaco, feldmaresciallo, conte del Sacro Romano Impero, Leopold Joseph Maria von Daun[460]. Il 31 maggio 1762 Erula Giuseppa de (von) Carugo, figlia di Pietro Paolo e di sua moglie Elisabetta, sposa a Vienna, presso la chiesa di San Michele, Johannes Nepomuk von Wipplar und Uschitz, figlio di Christoph von Wipplar und Uschitz[461], la cui famiglia, originaria della Slesia, ed insignita del titolo baronale nel 1730[462], fu titolare dei diritti fondiari del Principato di Troppau, corrispondente all’odierna città di Opava in Repubblica Ceca, nonché delle signorie (“Herrschaft”) di Wigstadtl, Glockersdorf, Oberdorf e Niederdorf[463]. Johannes Nepomuk von Wipplar era luogotenente nello stesso reggimento ove serviva Pietro Paolo de Carugo[464]. Nel febbraio 1761 Pietro Paolo e sua moglie Elisabetta ebbero una seconda figlia, Caterina Francesca, la quale venne battezzata il 24 dello stesso mese a Vienna nella stessa chiesa di San Michele, ed ebbe come padrino Franz de Paula Graf von Daun[465], cugino del feldmaresciallo von Daun[466].
Karoline von Carugo visse presso la regia ed imperiale corte di Vienna fintantoché servì quale istitutrice dell’arciduchessa Maria Clementina d’Asburgo-Lorena[467]. Figlia di un tenente colonnello dell’imperiale e regio esercito, ebbe una sorella, Luise von Carugo. Sposò l’esattore per la città di Praga Ignaz Thaddäus “Edler” von Habermann, nobilitato nel gennaio del 1794[468]. Dalla loro unione nacquero quattro figli: Franz, segretario di corte presso la Hofkammer; Heinrich, primo tenente dei “cacciatori imperiali” Kaiserjäger; Josef Edler, primo tenente del corpo d’artiglieria; e Therese. Al pari di sua moglie Karoline, anche Ignaz Thaddäus trascorse la propria vecchiaia a corte, al palazzo di Hofburg, ove morì il 14 marzo 1825[469].
L’ampia variabilità geografica dei luoghi di nascita, di matrimonio o di morte nelle vite di esponenti come Cajetan (Gaetano) de Carugo, che nell’arco della sua carriera fu di stanza a Vienna come in Sicilia, ma morì a Brașov in Romania; o del tenente colonnello Heinrich Carugo, il quale nacque a Mantova e morì a České Budějovice in Repubblica Ceca; o ancora come nel caso del tenente Emanuel von Carugo nato a Český Krumlov in Repubblica Ceca e morto a Budapest in Ungheria, riflettono l’evoluzione settecentesca del concetto di esercito, il quale non si sostanziava più in un sistema fondamentalmente statico di truppe di guarnigione a protezione di piazzeforti e bastioni, tipici delle guerre d’assedio, ma in un sistema dinamico adatto alla guerra campale, la quale richiedeva un esercito in costante movimento, supportato da un sistema di alloggi e caserme. La mobilità degli eserciti divenne di primaria importanza. Le truppe dovevano essere messe in grado d’attraversare frequentemente i confini spostandosi rapidamente da un territorio all’altro, sia in tempi di guerra che di pace. La mobilità si caratterizzò fondamentalmente di due tipologie di spostamenti: la prima era circoscritta nell’ambito dei confini e prevedeva la movimentazione semestrale delle truppe presidiali tra le diverse piazzeforti; la seconda categoria di spostamenti prevedeva lo spostamento delle truppe lombarde al di fuori dei confini, sia verso i Regni meridionali e la Toscana, ma in particolar modo verso i Domini ereditari d’Austria, Boemia ed Ungheria, attraverso i Grigioni o il Tirolo. Una volta raggiunta la città di Hall, le truppe venivano imbarcate verso Linz se dirette in Boemia, o verso Krems se dirette in Moravia[470].
Nella sua concezione settecentesca l’esercito si distinse non solo per la sua mobilità, ma anche per la sua sociabilità. Le mogli e i figli non solo degli ufficiali, ma anche dei soldati semplici, seguivano gli spostamenti degli eserciti e risiedevano nelle caserme o in specifici alloggi presso le città circonvicine. In particolare gli ufficiali, distinti dalle propri uniformi e concentrati nell’ambito cittadino, furono spesso introdotti nei salotti, nei teatri e nei circoli culturali proprio dalle loro mogli[471]. Dalle fonti documentali emergono testimonianze di matrimoni tra soldati italiani con donne tedesche, boeme, slave, e di donne italiane che sposarono soldati anch’essi di varia provenienza, tradendo una forte vicinanza tra l’esercito e la società civile del luogo ove era stanziato il reggimento. Come da consuetudine, nei matrimoni tra nobili i testimoni venivano scelti tra persone dello stesso rango[472].
Le variazioni onomastiche riscontrate negli esponenti delle famiglie de Carugo vicine all’autorità imperiale, sono sì da attribuirsi al carattere multiculturale dell’impero austro ungarico ed alla forte mobilità dei suoi eserciti, ma anche ad alcuni fattori più specifici quali, ad esempio, la volontà piuttosto comune tra i cadetti dell’accademia militare Theresianische Militärakademie, di cambiare il proprio nome di battesimo o l’ortografia del proprio cognome al termine del proprio percorso d’istruzione ed addestramento[473], ed il fatto che a partire dal 1784 tutti i cappellani militari furono obbligati a redigere i propri registri unicamente in lingua tedesca, la quale fu altresì la lingua ufficiale dell’esercito.
Rami Comitali
Nel secolo XVIII si fregiarono del titolo comitale almeno due esponenti di rami distinti: August Graf Carugo, cioè il conte Augusto Carugo, il quale servì col grado di sottotenente (“Unterlieutenant”) nel tredicesimo reggimento di fanteria “Guidobald Grafen von Starhemberg” per circa un anno dal 1759 al 1760[474]; e la contessa Barbara Carugo, vedova del conte Giuseppe Suardi, la quale dimorò dal 1720 al 1737 presso il Convento di Santa Maria del Gesù, sito nell’omonima via di Milano, al quale elargì somme “davvero considerevoli”[475].
Dall’Ottocento ai giorni nostri
Esponenti Nobili e Notabili
L’Imperatore d’Austria Francesco I, il primo di giugno 1816, sanzionò l’emissione di due patenti imperiali: le cosiddette “Finanzpatent” e “Bankpatent”, le quali congiuntamente permisero all’allora Finanzministers (Ministro delle Finanze) Johann Philipp Graf von Stadion di fondare a Vienna la Banca Nazionale Austriaca, inizialmente denominata “Privilegirten Oesterreichischen National-Bank” e costituita in forma di società per azioni[476]. Peter von Carugo fu tra i primi azionisti del neocostituito istituto bancario, già annoverati nell’azionariato sia per l’anno 1818 che 1819, tra i quali spiccano membri illustri dell’aristocrazia ed alta borghesia europea quali, per citarne solo alcuni, il duca Ferdinand Friedrich August von Württemberg, e gli eredi di Mayer Amschel Rothschild tramite la banca di famiglia M. A. Rothschild & Söhne[477].
Illustrazione della sede della Privilegirten Oesterreichischen National-Bank vista dalla Herrengasse, Vienna, 1823.
Calcografia su lastra di rame estratta da Gurk, E., Gurk, J. Ignaz., Gerngross (Firm), Österreichische Nationalbibliothek. (192). Wien's vorzüglichste Gebäude und Monumente =: Les principaux batiments et monuments de Vienne. Vienne: Chez Tranquillo Mollo.
Elenco alfabetico dei nomi di tutti gli azionisti della “Privilegiata Banca Nazionale Austriaca”, al 31 dicembre 1818, conservato presso la Biblioteca di Stato Bavarese di Monaco di Baviera.
Licenza
Il 27 agosto 1856 muore a Vienna, all’età di ottantanove anni l’ereditiera Lüdovika von Carugo, nata a Theusing nel 1767 circa. Suo padre fu tenente colonnello nell’Imperiale e Regio Esercito (Kaiserliche und Königliche Armee, abbreviato in K.u.K. Armee) dell’Impero Austro-Ungarico. Venne sepolta presso la Cattedrale di Santo Stefano, cattedrale metropolitana di Vienna[478].
La rivista genealogica tedesca “Familiengeschichtliche Blätter”, organo appartenente all’Archivio Genealogico Tedesco, nella sua edizione del gennaio 1905, registra una famiglia von Carugo nella regione della Slesia[479].
Da “de Carugo” a “von Karuck”
Alcuni discendenti del sopradescritto ramo dei de Carugo originari di Rovellasca, durante il periodo di dominazione austriaca conobbero cambiamenti onomastici più sostanziali. Il cognome non mutò come avvenne nello stesso periodo in più casi nella sua sola preposizione, i.e. “von Carugo”, ma assunse la forma ulteriormente germanizzata di “von Karuck”[480]. Sebbene sul finire dell’Ottocento il cognome nella sua espressione originaria fosse già stato sostanzialmente recuperato, quello attinente al periodo di dominazione austriaca riemerse tentativamente per volontà di una discendente, Rosa Angela Carugo (von Karuck), nata a Misinto nel 1881[481]. Trasferitasi in gioventù a Milano[482], la documentazione anagrafica ad essa afferente tradisce la confusione che le sue aspirazioni causarono di volta in volta nel parroco e nell’ufficiale di stato civile. In occasione del suo matrimonio (1913), il registro parrocchiale ne tralasciò completamente il nome[483]. Nel certificato di battesimo del suo unico figlio, Luigi Valli, nato nel 1917, essa venne erroneamente registrata come Rosa “Caruso”[484]. Giunti al 1942, in occasione dell’attribuzione a suo figlio della Croce di Guerra al Valor Militare, il cognome di Rosa sarà abbozzato in “Caruco”[485]. A memoria delle sue volontà, il figlio Luigi Valli ed il nipote Alberto Valli Fassi von Karuck Soheve, denominarono una delle proprie società “Karuck Italia”, la quale assieme alle altre compagnie appartenute alla famiglia, nel 1985 costituiva uno dei massimi gruppi italiani di brokeraggio riassicurativo per premi raccolti. Dello stesso gruppo famigliare si ricorda altresì la “Valli Ass.ni Sas”, la quale fu tra le più importanti società di brokeraggio a livello nazionale e tra le dieci società che nel 1969 fondarono l’AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni[486], riservata alle società più importanti per portafoglio o clienti amministrati[487]. Infine, sempre afferente alla stessa famiglia fu la società Valli Heath Fielding S.p.A., la quale nel 1989 intermediò premi per oltre 20 miliardi di lire[488] (circa 24.5 milioni di euro attuali[489]) e fu partecipata al 43% dalla storica compagnia inglese C.E. Heath Plc[490], fondata nel 1877 dal celebre sottoscrittore dei Lloyd’s di Londra Cuthbert Heath[491]. Nel settembre del 1990, il gruppo competitore Gpa S.p.A., controllato da Umberto Occhipinti e Letizia Moratti, acquisì l’85% della Valli Health Fielding costituendo così la Gpa-Valli[492], la quale ancor oggi, sebbene con una diversa denominazione, rimane la società leader del brokeraggio assicurativo italiano[493].
Il segretario del Partito Liberale Italiano, Renato Altissimo, si appresta a tagliare una torta decorata secondo i motivi del partito al termine di un comizio tenutosi presso la residenza milanese dei Valli Fassi von Karuck Soheve. Alla destra di Altissimo, Sandra Olga Hiziak, moglie di Alberto Valli Fassi von Karuck Soheve. Milano, luglio 1989.
Collezione Privata - tutti i diritti di legge riservati
Nell’arco di circa un secolo, la riaffermazione in ambito milanese dei discendenti di Rosa von Karuck, coincise con il ritorno della famiglia ai vertici della società italiana. In tal guisa si espresse, tra gli altri, il quotidiano La Repubblica il 20 aprile 1990, in occasione della mostra fotografica tenutasi in piazza Duomo a Milano, ove vennero esposti dei ritratti di alcuni membri della famiglia Valli Fassi von Karuck Soheve, immortalati dalla fotografa Beatrice Serpieri, la quale: “di antica famiglia aristocratica e industriale, nota per aver immortalato mamme e bambini, tutti con cognomi famosi, nel suo archivio c’è gran parte dell’Italia che conta: dai Pirelli agli Innocenti ai Ruffo di Scaletta, dai Mondadori ai Valli Fassi [von Karuck Soheve] per finire con gli Alemagna”[494].
(a)
(b)
Anna Prati, ritrattista romana stabilitasi a Milano, nel secondo dopoguerra si dedicò principalmente al ritratto su commissione[495]. Ritratti di (a) Luigi Valli (von Karuck Soheve) e (b) Alberto Valli Fassi von Karuck Soheve, Milano, 1985.
Collezione Privata - tutti i diritti di legge riservati
Alberto Valli Fassi von Karuck Soheve, oltre che nell’attività imprenditoriale, si distinse anche in quella letteraria. Con l’editore Aurelio Canevari pubblicò a Milano “Parole d’autunno” nel 1967 e “Le immagini” nel 1968. A queste prime opere giovanili seguirono “Testi e Poesie”, alla quale sia il critico letterario Giuseppe Marchetti che il professore ordinario di filosofia del diritto e di filosofia politica Giulio Maria Chiodi dedicarono saggi introduttivi[496], e “La terra deserta”, entrambi pubblicati dall’editore Luigi Battei a Parma rispettivamente nel 1975 e nel 1979. Nel 1988 con l’editore Crocetti di Milano pubblicò “Gli orologi di mezzanotte: frammenti e altri segni, 1980-1986”, presentato a Milano dal poeta Maurizio Cucchi l’8 novembre 1988[497]. Infine nel 2014, dello stesso autore la casa editrice Rosellina Archinto pubblica a Milano “Alle nostre deboli tracce”, opera che nello stesso anno verrà giudicata “tra le più significative apparse sulla scena poetica italiana negli ultimi trent’anni”[498].
Copia degli inviti personali rilasciati dal libraio e scrittore Cesarino Branduani in occasione della presentazione del volume “Testi e Poesie” di Alberto Valli Fassi [von Karuck Soheve]; Milano, 1975.
Collezione Privata - tutti i diritti di legge riservati
Il conte Gaddo della Gherardesca intento a leggere alcuni versi de “Gli Orologi di Mezzanotte” di Alberto Valli Fassi von Karuck Soheve (ritratto di profilo, alla sua destra), in occasione della presentazione tenutasi presso la Libreria Messaggerie Paravia, Milano, 1988.
Collezione Privata - tutti i diritti di legge riservati
Dello stesso ramo Carugo originario di Rovellasca (CO) si ricorda anche il Cavalier Antonio Carugo, nato nel 1869 da Giovanni Luigi Carugo ed Angela Moltrasio, e sposatosi nel 1894 con Celeste Teresa Giobbio[499]. Fu mercante e sindaco dapprima di Misinto con Lazzate e poi di Rovellasca. Morì il 19 marzo 1920[500] donando alla città la propria dimora, Villa Carugo, la quale fu adibita a palazzo comunale. Si conserva presso lo stesso, in accordo con le proprie volontà, un suo busto in bronzo. A lui fu intitolata una via della città: i.e. via Antonio Carugo[501].
-
[1] Luigi Veladini, Antiquario della Diocesi di Milano, Milano, 1790, p.177
[2] Codice in Biblioteca Ambrosiana sign. A num. 112 inf., https://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:25560
Milano Storia del Popolo e Pel Popolo, Cesare Cantù, Tipografia e Libreria Giacomo Agnelli, Milano, 1871, p.30-31.
[3] Fortunato Sprecher von Bernegg, Chronicvm Rhaetiae Historia Inalpinae Confoederata Rhaetiae, Typis Johan Jacobi Genathii, Basileae, 1622, p.24-25.
[4] L’Archivio di Stato di Venezia Indice Generale, Storico, Descrittivo ed Analitico, Andrea da Mosto, Biblioteca d’Arte Editrice, Tomo I, Roma, 1937, p.74
[5] Dizionario di Toponomastica Lombarda, Dante Olivieri, La Famiglia Meneghina, Milano 1931, p.147
[6] Historiae Patriae Monumenta Codex Diplomaticus Longobardiae, Vol. XIII, Regio Typographeo, Torino, 1873, p.1505
[7] Prof. Agostina Colombo, Carugo Attraverso i Secoli: Il Toponimo, in “Carughese”, Amministrazione Comunale di Carugo, Carugo, Aprile 2010.
[8] Le Vicende della Brianza e dei Paesi Circonvicini, Ignazio Cantù, Presso Santo Brevetta, Vol. I, Milano, 1836, p.23
[9] Le Antiche Famiglie della Brianza, dell’Alto Milanese, del Lecchese, del Basso Comasco con i loro stemmi, Preatoni Carlo, Finocchiaro Emanuela, Milano, 2023.
[10] Codice Diplomatico Sant’Ambrosiano, Angelo Fumagalli, Carlo Amoretti, Milano, 1805, p.522; Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione della Città e della campagna di Milano nei Secoli Bassi, Milano, 1760-65, Tomo II, p.469; Memorie storiche di Monza e sua corte, Antonio Francesco Frisi, Milano, 1794, Tomo II, p.10; Biblioteca della Fondazione Culturale San Fedele, Milano; Memorie della Città e della Campagna di Milano nei Bassi Secoli, Conte Giorgio Giulini, Milano, 1854, Tomo II, p.24.
[11] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.150
[12] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.283.
[13] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.139.
[14] Primi iudices nell’Italia carolingia: vassalli regi e imperiali, Andrea Castagnetti. In Città e territori nell’Italia del Medioevo Studi in onore di Gabriella Rossetti, Giorgio Chittolini, Giovanna Petti Balbi, Giovanni Vitolo, GISEM Liguori Editore, Napoli, 2007.
[15] Ivi.
[16] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.142.
[17] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.143-144.
[18] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.283n
[19] I Placiti del “Regnum Italiae”, a cura di C. Manaresi, in Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Vol. 92, 96-97, Tipografia Del Senato, Roma, 1955-1960, p.400.
[20] I Placiti del “Regnum Italiae”, a cura di C. Manaresi, in Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Vol. 92, 96-97, Tipografia Del Senato, Roma, 1955-1960, p.410.
[21] I Placiti del “Regnum Italiae”, a cura di C. Manaresi, in Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Vol. 92, 96-97, Tipografia Del Senato, Roma, 1955-1960, p.422
[22] I Placiti del “Regnum Italiae”, a cura di C. Manaresi, in Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Vol. 92, 96-97, Tipografia Del Senato, Roma, 1955-1960, p.497.
[23] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.282.
[24] Ettore Falconi, Le Carte cremonesi dei secoli VIII-XII, Vol. 1, Biblioteca statale di Cremona, Cremona, 1979. Et al.
[25] I Diplomi di Ugo e di Lotario di Berengario II e di Adalberto, a cura di Luigi Schiapparelli, in Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano, Vol. 38, Tipografia del Senato, Roma, 1924, p.280.
[26] Il Papa Mancato del Secolo di Ferro, in Monaco Siro, Vita di san Maiolo abate di Cluny, a cura di Giovanni
Spinelli e Dorino Tuniz, Europìa, Novara, 1994, p.34.
[27] Roland Pauler, I conti di Lomello, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: Atti del primo convegno di Pisa 10-11 maggio 1983, Roma, 1988, p.190-193
[28] Hagen Keller, Adelsherrschaft und stâdtische Gesellschaft in Oberitalien (9-12 Jahrhundert), Tubingen, 1979 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 52), p.263-266.
[29] D. A. Bullough, Urban change in early medieval ltaly : the example of Pavia, dans Papers of the British School at Rome, 34, 1966, p.113-114 e 130.
[30] Giulio Porro Lambertenghi, Codex diplomaticus Langobardiae, in Historiae patriae monumenta, Vol.13, n.535 a. 930, E Regio Typographeo, Torino, 1873.
[31] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.288-292.
[32] Prof. Agostina Colombo, Carugo Attraverso i Secoli: Lo Stemma Civico, in “Carughese”, Amministrazione Comunale di Carugo, Carugo, Maggio 2010; Carugo Attraverso i Secoli: I Carugo i Signori della Nostra Terra, in “Carughese”, Amministrazione Comunale di Carugo, Carugo, Luglio 2010. Elena Alfani. - Santi, supplizi e storia nella pittura murale lombarda del XII secolo. La cappella di San Martino a Carugo. Nuova Argos, Roma, 2000, p.28.
[33] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.157-158
[34] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.153.
[35] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.156.
[36] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.150.
[37] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.145.
[38] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.152, 155.
[39] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.157-158.
[40] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.153.
[41] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.156-157.
[42] Giulio Vismara, Scritti di Storia Giuridica: La vita del diritto negli atti privati medievali, A. Giuffrè, Milano, 1987, p.227
[43] Historiae Patriae Monumenta Codex Diplomaticus Longobardiae, Vol. XIII, Regio Typographeo, Torino, 1873, p.1505
[44] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.140.
[45] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.141.
[46] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.145.
[47] Edictum Rothari ,386: 'pari consilio, parique consensum cum primatos iudices, cuntosque felicissimum exercitum nostrum'; Cènita Feliciter L’epopea goto-franco-romaico-longobarda tra VI e VIII secolo d.C., Giorgio Arnosti, Vittorio Veneto, 2017, p.403.
[48] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.141.
[49] Il Locarnese negli ultimi tre secoli del Medioevo, G. Wielich, 1973, p.162 sg.; Blenio e Leventina da Barbarossa a Enrico VII Un contributo alla storia del Ticino nel Medioevo, Karl Meyer, Bellinzona, 1977, p.139; Dizionario storico della Svizzera (DSS) "Gastaldo", Paolo Ostinelli, 2008.
[50] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.165.
[51] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.158-159.
[52] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.165.
[53] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.171.
[54] Bougard François. La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle. Rome : École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291, 1995, p.175.
[55] Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani "Il particolarismo postcarolingio", Catia di Girolamo, tratto da Storia della Civiltà Europea Il Medioevo Secoli V-X, Umberto Eco, EncycloMedia, 2014
[56] Antiquitates Italicae Medii Aevi, Ludovico Antonio Muratori, Vol I, Dissertatio Octava, Stamperia della Società Palatina, Milano, 1738, p.417-418.
[57] Studi Intorno al Municipio di Mantova dall’Origine di questa fino all’anno 1863, Carlo D’Arco, Vol I, Viviano Guastalla Editore, Mantova, 1871, p.25; Enciclopedia Araldico-Cavalleresca Prontuario Nobiliare “Conte Rurale”, Goffredo di Crollalanza, Direzione del Giornale Araldico, Pisa, 1876-1877.
[58] Annali del Friuli ossia Raccolta delle Cose Storiche Appartenenti a questa Regione, Co. Francesco De Manzano, Vol. I, Tipografia Trombetti-Murero Rampinelli Editore, Udine, 1858, P.370; Nuova Enciclopedia Italiana ovvero Dizionario Generale di Scienze Lettere Industrie “ Conte”, Prof. Gerolamo Boccardo, Vol. VI, Sesta Edizione, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1878.
[59] Gabotto F., Lizier A., Leone A., Morandi G. B., Basso G., Le Carte dell'Archivio Capitolare di Novara, Biblioteca della Società storica subalpina. Corpus chartarum Italiae LXXVIII-LXXX, 1913 ss., 3 voll.
[60] The Individual and Society in the Middle Ages, Walter Ullmann, The John Hopkins Press, Baltimore Maryland, 1966, p.71, and Principles of Government and Politics in the Middle Ages, Methuen& Co Ltd, London, 1961, p.161.
[61] Storia di Milano di Bernardino Corio riveduta ed annotata del Prof. Egidio De Magri, Francesco Colombo Libraio Editore, Vol. I, Milano, 1855, p.120 e ss.; G. Dozio, Del contado della Martesana, Milano 1876; E. Riboldi, I contadi rurali del Milanese, secoli IX-XII, in Arch. st. lomb., 1904, p.15 e ss.
[62] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, “contado della Burgaria sec. IX - sec. XIII”, Milano, 2005, accesso il 28 dicembre 2024: https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8010829/ .
[63] Gesta Federici I imperatoris in Lombardia auctore cive Mediolanensi. Annales Mediolanenses Maiores, in MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, XXVII, a cura di O. Holder-Egger, Hannoverae 1892, pp.34
[64] Tale è il criterio distintivo adottato ne: Del Contado della Martesana Dissertazione Postuma, Sac. Dott. Giovanni Dozio, Sac. Giuseppe Prestinoni, Tipografia e Libreria Arcivescovile Ditta Giacomo Agnelli, Milano, 1876, p.26-27.
[65] Memorie Storiche di Monza e Sua Corte, Anton Francesco Frisi, Tomo II, Gaetano Motta, Milano, 1744, p.63.
[66] Memorie spettanti alla Storia al Governo ed alla descrizione della Città e Campagna di Milano ne’ Secoli Bassi, Conte Giorgio Giulini, Francesco Colombo Editore, Vol III, Disp.I e II, 1855, p.630 e ss.
[67] Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Paolo Grillo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, pag 302
[68] Del Contado della Martesana Dissertazione Postuma, Sac. Dott. Giovanni Dozio, Sac. Giuseppe Prestinoni, Tipografia e Libreria Arcivescovile Ditta Giacomo Agnelli, Milano, 1876, p.34; Ludovico Antonio Muratori, Rerum Italicarum scriptores, vol. 6, Mediolani, ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1725, col. 1186-1187.
[69] Storia di Como, Rovelli, Parte II, pp.326 e sgg.
[70] Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani "Martesana", 1934: Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani "La Pace di Costanza", 1931.
[71] Prof. Agostina Colombo, Carugo Attraverso i Secoli: Lo Stemma Civico, in “Carughese”, Amministrazione Comunale di Carugo, Carugo, Maggio 2010; Carugo Attraverso i Secoli: I Carugo i Signori della Nostra Terra, in “Carughese”, Amministrazione Comunale di Carugo, Carugo, Luglio 2010; Elena Alfani. - Santi, supplizi e storia nella pittura murale lombarda del XII secolo. La cappella di San Martino a Carugo. Nuova Argos, Roma, 2000, p.28.
[72] L'abbazia benedettina di Civate note di storia e di arte, Bognetti, Gian Piero, Marcora, Carlo, Amici della Casa del Cieco, 1957, pag 224
[73] “Nulla Civitas, nullus Mediolanensis, nulla Persona pubblica, vel privata, parva, vel magna, aliquod districtum, vel conditiones aliquas, seu fodrum habeat, vel exerceat nisi Nos, et nostri Successores Reges, et Imperatores Romanorum, et Abbas prædicti Monasterii”, in Memorie spettanti alla Storia al Governo ed alla descrizione della Città e Campagna di Milano ne’ Secoli Bassi, Conte Giorgio Giulini, Francesco Colombo Editore, Vol III, Disp.I e II, 1855, p.630 e ss.
[74] Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Paolo Grillo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, pag 248-306
[75] Del Contado della Martesana Dissertazione Postuma, Sac. Dott. Giovanni Dozio, Sac. Giuseppe Prestinoni, Tipografia e Libreria Arcivescovile Ditta Giacomo Agnelli, Milano, 1876, p.25.
[76] Portale del Comune di Carugo “Storia e leggenda del "Cunt de Carùc", 2021
[77] Associazione Museo nel Novecento Carugo.
[78] Paolo Grillo, Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, p.302, 306.
[79] Paolo Grillo, Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, p.284.
[80] Gerolamo Biscaro, Gli Appelli ai Giudici Imperiali dalle Sentenze dei Consoli di Giustizia di Milano sotto Federico I ed Enrico VI, in Archivio Storico Lombardo Giornale della Società Storica Lombarda, Serie Quarta, Vol. IX, anno XXXV, Milano, 1908, pp.215-219, 245; Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Pergamene di Sant’Ambrogio, AD, pergg., cart. 313, n.235 [A]. Regesto del 1738 in Giorgi, Registro, c. 107; del 1739 in Giorgi, Rubrica, c. 28v. https://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sambrogio-mon3-2/carte/sam1186-04-30a/
[81] Gerolamo Biscaro, Gli Appelli ai Giudici Imperiali dalle Sentenze dei Consoli di Giustizia di Milano sotto Federico I ed Enrico VI, in Archivio Storico Lombardo Giornale della Società Storica Lombarda, Serie Quarta, Vol. IX, anno XXXV, Milano, 1908, pp.216; Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Pergamene di Sant’Ambrogio.
[82] Gerolamo Biscaro, Gli Appelli ai Giudici Imperiali dalle Sentenze dei Consoli di Giustizia di Milano sotto Federico I ed Enrico VI, in Archivio Storico Lombardo Giornale della Società Storica Lombarda, Serie Quarta, Vol. IX, anno XXXV, Milano, 1908, p.216
[83] Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Paolo Grillo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, p.248-306
[84] Maria Pia Alberzoni, “Settala Enrico”, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 92, 2018, https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-settala_%28Dizionario-Biografico%29/
[85] Notae Sancti Georgii, p.389 e ss.; Antiquario della Diocesi di Milano, Luigi Veladini, Milano, 1790, p.177; Dizionario Biografico degli Italiani Treccani "Marcellino, Ardigotto", Vol. 69, Paolo Grillo, 2007; Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Paolo Grillo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, p.303, 654, 655; Celestino Mantovani, Notizie storiche sulla chiesa di S. Salvatore e sull’antico castello di Barzanò, D. Salvi, Milano, 1868, p.23.
[86] Milani, Dalla Ritorsione al Controllo. Elaborazione e applicazione del programma anti ghibellino a Bologna alla fine del Duecento, in Quaderni Storici, XXXII, 1997, p.43-74
[87] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol II Parte II: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.766
[88] Pergamena originale conservata presso BAMi, Pergamene, n. 1447 [A], https://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/co/lenno-smaria/carte/acquafredda1176-05-10/
[89] Periodico della Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como, tipografia Provinciale F. Ostinelli di C.A., Volume IV, Como, 1884, p.182.
[90] Storia di Milano di Bernardino Corio riveduta ed annotata del Prof. Egidio De Magri, Francesco Colombo Libraio Editore, Vol. I, Milano, 1855, p.413. Cesare Cantù nella sua opera storiografica “Storia della città e della diocesi di Como esposta in dieci libri” (Vol. I e II, Como, 1829, p.355) vede nelle fonti primarie un Giacomo de Carugo, mentre Bernardino Corio interpreta il nome come Jacopo de Carugo.
[91] Studi di storia medioevale e di diplomatica, Volume 14, Università degli Studi di Milano, Milano, 1993, p.262.
[92] Archivio Storico Lombardo, Vol. V, anno 33, serie 4, Giornale della Società Storica Lombarda, Milano, 1906, p.38. Periodico della Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como, Tipografia Provinciale F. Ostinelli di C.A., Vol XII, Como, 1897, p.235
[93] L'abbazia benedettina di Civate note di storia e di arte, Bognetti, Gian Piero, Marcora, Carlo, Amici della Casa del Cieco, 1957, p.151
[94] Gesta archiepiscoporum Mediolanensum, Arnulphi, a c. Di L. C. Berthmann e W. Wattenbach, in MGH, Scriptores, Tomo VIII, Hannover, 1854, p.24.; Historia, Landulphi da Sancto Paulo, a c. Di L. C. Berthmann e W. Wattenbach, in MGH, Scriptores, Tomo VIII, Hannover, 1854, p.64.; Gli Atti del Comune di Milano fino all’anno MCCXVI, a c. Di C. Manaresi, Milano, 1919, p.17, n.5.
[95] Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Paolo Grillo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, p.238.Cesare Cantù, Milano Storia del Popolo e Pel Popolo, Tipografia e Libreria Giacomo Agnelli, Milano, 1871, p.30-31.
[96] Manipulus Florum, Galvanei de la Fiama, a c. di L. A. Muratori, in RIS, XI, Mediolanum, 1727, col. 678
[97] Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Paolo Grillo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, p.626
[98] Archivio Storico Lombardo Indici della Serie III, Vol I-XX, Milano, 1894-1903, p.209; L'abbazia benedettina di Civate note di storia e di arte, Bognetti, Gian Piero, Marcora, Carlo, Amici della Casa del Cieco, 1957, p.150, 224
[99] Archivio di Stato di Milano, Fondo Pergamene, cart. 316, n.87, febbraio 1241
[100] Enzo Fabiani, Enzo Pifferi e Maria Teresa Balboni, Abbazie di Lombardia, Como, Editrice E.P.I., 1980; Oleg Zastrow, L'arte romanica nel comasco, Lecco, Casa editrice Stefanoni, 1972.
-
[101] Archivio Storico Lombardo, Giornale della Società Storica Lombarda, Serie Terza, Milano, 31 marzo 1898, Pag 91
[102] L'abbazia benedettina di Civate note di storia e di arte, Bognetti, Gian Piero, Marcora, Carlo, Amici della Casa del Cieco, 1957, pag 182
[103] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol II Parte I: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.101
[103a] Gli Atti dell’Arcivescovo e della Curia Arcivescovile di Milano nel Sec. XIII – Ottone Visconti (1262 – 1295), a cura di Maria Franca Baroni, Università degli Studi, Milano, 2000, p.70 e ss.
[103b] Venticelli, M. (2004). Monachesimo femminile. Origini e sviluppo. I Quaderni Del m.æ.S. - Journal of Mediæ Ætatis Sodalicium, 7(1), 57–87. https://doi.org/10.6092/issn.2533-2325/8036; Albuzzi, A. (2001). Il monachesimo femminile nell'Italia medioevale. Spunti di riflessione e prospettive di ricerca in margine alla produzione storiografica degli ultimi trent'anni. In GIANCARLO. ANDENNA (A cura di), Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio. Atti del Convegno internazionale, Brescia – Rodengo, 23-25 marzo 2000, p. 131-189; Archivio Storico Lombardo, Giornale della Società Storica Lombarda, Serie Quarta, Volume XVII - Anno XXXIX, Milano, 1912, p. 321.
[103c] Gli Atti dell’Arcivescovo e della Curia Arcivescovile di Milano nel Sec. XIII – Ottone Visconti (1262 – 1295), a cura di Maria Franca Baroni, Università degli Studi, Milano, 2000, p.70 e ss.
[104] Memorie Storiche di Monza e Sua Corte, Anton Francesco Frisi, Tomo II, Gaetano Motta, Milano, 1744, p.139.
[105] Enciclopedia Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 89, “Sacconi Raniero”, (2017)
[106] Archivio Storico Lombardo, Vol. V, anno 33, serie 4, Giornale della Società Storica Lombarda, Milano, 1906, p.168.
[107] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.17; Museo Archeologico di Milano. Le torri romane e il Monastero Maggiore. https://www.museoarcheologicomilano.it/scopri-il-museo/le-torri-romane-e-il-monastero-maggiore(consultato il 12/01/2026).
[107a] Museo Archeologico di Milano. Le torri romane e il Monastero Maggiore. https://www.museoarcheologicomilano.it/scopri-il-museo/le-torri-romane-e-il-monastero-maggiore(consultato il 12/01/2026).
[108] Cosimo Damiano Fonseca, La signoria del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII - XIII), "Studi e ricerche di storia delle istituzioni civili ed ecclesiastiche del medioevo - I", Genova, Ed. Ist. Grafico San Basile, 1974, pp.31-34; Miscellanea di Storia Italiana, Terza Serie, Tomo VII, Fratelli Bocca Librai di S.M., Torino, 1902, p.238
[109] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, pp.58, 62-64.
[110] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, pp.74, 81.
[111] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.58.
[112] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, pp.56-58.
[113] Archivio di Stato di Milano, Fondo Pergamene, cart.486, n.56, agosto 1216; cart.487, n.157, luglio 1235; cart.488, n.325, dicembre 1251; n.359 marzo 1253.
[114] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.60.
[115] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.237.
[116] Giovanni Seregni, Del luogo di Arosio e dei suoi statuti nei secoli XII-XIII con appendice di documenti inediti, in “Miscellanea di Storia Italiana”, Terza Serie, Tomo VII, Fratelli Bocca Librai di S.M., Torino, 1902, p.240
[117] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.64
[118] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, pp.147-150.
[119] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.221.
[120] Giovanni Seregni, Del luogo di Arosio e dei suoi statuti nei secoli XII-XIII con appendice di documenti inediti, in “Miscellanea di Storia Italiana”, Terza Serie, Tomo VII, Fratelli Bocca Librai di S.M., Torino, 1902, pp.281 e ss.
[121] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.80-81; R. Romeo, Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII, Assisi, 1970, pp. 26-30.
[122] Miscellanea di Storia Italiana, Terza Serie, Tomo VII, Fratelli Bocca Librai di S.M., Torino, 1902, pag 239-240.
[123] Gli Atti del Comune di Milano fino all’anno MCCXVI, a cura di C. Manaresi, Milano, 1919, pp. 207-208, n.CXLI; Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.189.
[123a] Corbetta, Mario – Martegani, Arnaldo, I Visconti capitanei della pieve di Mariano, in Archivio Storico Lombardo. Giornale della Società Storica Lombarda, serie XI, vol. VII, dicembre 1990, pp. 281–310
[124] Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, cart.495, n.74; Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.149
[125] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.237.
[126] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.107, 2004, p.133.
[127] Archivio Storico Lombardo Indici della Serie III, Vol I-XX, Milano, 1894-1903, p.209; L'abbazia benedettina di Civate note di storia e di arte, Bognetti, Gian Piero, Marcora, Carlo, Amici della Casa del Cieco, 1957, p.150, 224; I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documenti nn.58, 59, 60, 61, 62, 2004, pp.109-111.
[128] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.7, 2004, p.88.
[129] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.62.
[130] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p. 63-64; Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, cart.487, n.170.
[131] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.65; Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, cart.487, n.198.
[132] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.58, 2004, p.109.
[133] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.60, 2004, p.110.
[134] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.62, 2004, p.111.
[135] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.105, 2004, p.132.
[136] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documenti nn.106, 107, 2004, p.132-133.
[137] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol. II Parte I: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.126-132
[138] Archivio di Stato di Milano, Fondo Pergamene, cart. 493, n. 808.
[139] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.111, 2004, p.135.
[140] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.124, 2004, p.141.
[141] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.11, 2004, p.89.
[142] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol II Parte I: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.370
[145] I Quaderni della Brianza, Volume 27, pubblicazioni 152-155, documento n.52, 2004, p.106; Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.66; Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, cart.487, n.248.
[146] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.74.
[147] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.79-80; Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, cart.490, n.540.
[148] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.85; Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, cart.492, n.720.
[149] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.81.
[150] Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.232; Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, cart.90, n.554.
[151] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol IV, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.234 e ss
[151a]Regione Lombardia – LombardiaBeniCulturali, Monastero di Sant’Apollinare (1223–1782), scheda istituzionale, sezione «Istituzioni storiche», consultata l’11 gennaio 2026, https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/11500437/.
[151b]Gli Atti dell’Arcivescovo e della Curia Arcivescovile di Milano nel Sec. XIII – Ottone Visconti (1262 – 1295), a cura di Maria Franca Baroni, Università degli Studi, Milano, 2000, p.318 e ss.
[152] Archivio Storico Lombardo, Vol. V, anno 33, serie 4, Giornale della Società Storica Lombarda, Milano, 1906, p.170.
[153] Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società, Economia, Paolo Grillo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, p.306.
[154] Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi, cart.487, n.554; Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII – l’amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Cappelli Editore, Bologna, 1982, p.232.
[155] Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, “Comune di Carugo”, Cristina Doneda, 2005
[156] Lorenzo Caratti, Storia di Novate Milanese: 877-1877, a cura di Amministrazione comunale di Novate Milanese, Novate Milanese, 1982, p.154
[157] Memorie Storiche di Monza e Sua Corte, Anton Francesco Frisi, Tomo II, Gaetano Motta, Milano, 1744, p.142.
[158] Descrizioni della città di Monza e sua basilica dell’ I.R. Palazzo, A. Perpenti, Tipografia Corbetta. Monza, 1842, p.14; The Langobard Revival of Matteo il Magno Visconti, Lord of Milan, Areli Marina, I Tatti Studies in the Italian Renaissance, Vol. 16, No. 1/2 (Fall 2013), The University of Chicago Press on behalf of Villa I Tatti, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, pp.377-414
[159] Vetera Humiliatorum Monumenta, Hieronymo Tiraboschio Soc. Jesu in Braidensi Universitate Rhetoricae Professore, Vol. 1, Mediolani, 1766, p.179-180
[160] Archivio dell'Ente Comunale di Assistenza di Monza, Fondo Pergamene 1174 - 1782, b. 4, n. 113
[161] Giovanni Dozio, Notizie di Vimercate e Sua Pieve raccolte su vecchi documenti, Giacomo Agnelli Tip., Milano, 1853, p.25-26
[162] Dell’Historia Ecclesiastica di Piacenza, Pietro Maria Campi, Stampa Ducale Giovanni Bazachi, Piacenza, 1662
[163] Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, Vol. I, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877
[164]Beatissime pater Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano I “registra supplicationum” di Pio II (1458 – 1464), a cura di Elisabetta Canobbio e Beatrice Del Bo, Unicopli, Milano 2007 [Materia di storia ecclesiastica lombarda (secoli XIV-XVI), 9], p.64, 696.
[165] Archivio di Stato di Milano, pergamene del Fondo Religione, Cart. 457 – fasc. 196 b, Milano, 17 gennaio 1488.
[166] Eleonora Saita (archivista) e Carmela Santoro (archivista di Stato), Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, “Convento di San Domenico in via Levata, domenicane osservanti ( 1306 - 1576 )”, Milano, 2004.
[167] L. Osio, Documenti Diplomatici tratti dagli Archivi milanesi, Vol. I, Milano 1869 , p.136
[168] L. Osio, Documenti Diplomatici tratti dagli Archivi milanesi, II, Milano 1869, p.140
[169] Periodico della Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como, Tipografia Provinciale F. Ostinelli di C.A., Vol XII, Como, 1897, p.109
[170] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.3521 lemale 242, Milano, 1444.
[171] Alessandro Colombo, L’Ingresso di Francesco Sforza in Milano e l’Inizio di un Nuovo Principato, parte terza, in Archivio Storico Lombardo Giornale della Società Storica Lombarda, Serie Quarta, Vol. IV, anno XXXII, Milano, 1905, p.36; Pergamena originale conservata presso l’Archivio Civico Storico di Milano, Registri, Lettere Ducali, 1450-55, fol. 2.
[172] Il Ducato di Milano Studi Storici Documentati, Marco Formentini, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877, p.192.
[173] Isabella Lazzarini, Archivio Gonzaga di Mantova, Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), Vol. I, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1999, p.781.
[174] Viaggio in Terra Santa Fatto e Descritto per Roberto da Sanseverino, Roberto da Sanseverino, Romagnoli dall’Acqua, Bologna, 1888, p.311.
[175] Il Patriziato Milanese, secondo nuovi documenti deposti negli archivi pubblici e privati, Felice Calvi, 1876, p.457, 459
[176] Pergamena originale conservata presso l’Archivio Civico di Milano, Registro delle Lettere Ducali 1395-1409, foglio Nr181 e ss.
[177] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Carteggio Visconteo, Frammenti di atti di notai e istrumenti vari (1282 - 1450), atti rogati da Giovanni de Oliariis. Alfio Rosario Natale, Per la storia dell'Archivio Visconteo Signorile: Notai della Corte Viscontea di Pavia in Archivio Storico Italiano, Vol. 141, No. 4 (518) (1983), pp.572, 575, 583.
[178] Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, Vol. I, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877; Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, Istituzioni Storiche “Tribunale di Provvisione sec. XIII – sec. XVI”, 2005
[179] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, Pergamena 6471 lemale 278, Milano, 1369.
[180] Santo Monti, Compendio dell’origine e dignità della famiglia Mandelli, da un manoscritto inedito di Tazio Mandelli, in “Società Storica per la Provincia e Antica Diocesi di Como”, R. Deputazione di storia patria per la Lombardia Sezione di Como, Vol. XV, Como, 1903, pp.68, 70.
[181] Lodovico Costa, Cronaca di Tortona, Vedova Pomba e Figli, Torino, 1814, p.122.
[182] Storia degli Stati Italiani dalla Caduta dell'Impero Romano fino all'anno 1840, Enrico Leo, Vol. 1, Firenze, 1842, p.617
[183] Summarium Monumentorum Omnium Quae in Tabulario Municipi Vercellensis Continetur, a cura di Sereno Caccianottio, Vercelli, 1868, p.286
[184] Isabella Lazzarini, Archivio Gonzaga di Mantova, Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), Vol. I, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1999, p.241. Caterina Santoro, Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500), Ed. d'Arte Emilio Bestetti, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Milano, 1948.
[184a] Rogledi, Marco. L’ala Ovest del Castello di San Colombano al Lambro. Progetto conservativo e di riuso. Tesi di laurea magistrale in Architettura, Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società, a.a. 2010–2011
[185] Istoria della Città e Ducato di Guastalla, Ireneo Affò, Salvatore Costa e Compagno, Guastalla, 1786
[185a] Salomoni, David. «Torelli». In Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 96. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2019, Versione online: https://www.treccani.it/enciclopedia/torelli_%28Dizionario-Biografico%29/ (consultato il 30 novembre 2025); «Guastalla». In Dizionario di Storia. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2010, Versione online: https://www.treccani.it/enciclopedia/guastalla_%28Dizionario-di-Storia%29/ (consultato il 30 novembre 2025).
[186] Istoria della Città e Ducato di Guastalla, Ireneo Affò, Salvatore Costa e Compagno, Guastalla, 1786; L’Art de Vérifier les Dates des Faits Historiques des Chartes, des Chroniques et autres ancient Monuments, Congrégation de Saint-Maur, Vol XVII, Paris, 1819.
[186a] Regione Lombardia, Comune di Casalmaggiore, sec. XIII–1757, in Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIV–XIX secolo (progetto CIVITA), banca dati “Istituzioni storiche”, Lombardia Beni Culturali, Milano, s.d., https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/4001021/ (consultato il 30 novembre 2025); Regione Lombardia, Direzione Generale Cultura, Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati. Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIV–XIX secolo. Cremona. Progetto CIVITA. Milano: Regione Lombardia, 2000. PDF online: https://www.lombardiabeniculturali.it/docs/istituzioni/Cremona-s.pdf (consultato il 30 novembre 2025).
[187] Archivio di Stato di Milano, Missive di Francesco I Sforza (1450-1466), Registro 4, missiva n.1752
[188] Giuseppe Caraci, Giovanni Dalmasso, Camillo Bassi, Carlo Guido Mor, “Valtellina”, in Enciclopedia Italiana, 1937, https://www.treccani.it/enciclopedia/valtellina_(Enciclopedia-Italiana)/
[189] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, “La Lombardia Grigiona: Valtellina, Bormio, Chiavenna (1512 – 1620; 1639 – 1797)”, visitato il 3 dicembre 2024, https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=03.04#03.04.13
[190] Giuseppe Caraci, Giovanni Dalmasso, Camillo Bassi, Carlo Guido Mor, “Valtellina”, in Enciclopedia Italiana, 1937, https://www.treccani.it/enciclopedia/valtellina_(Enciclopedia-Italiana)/
[191] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, “La Lombardia Grigiona: Valtellina, Bormio, Chiavenna (1512 – 1620; 1639 – 1797)”, visitato il 3 dicembre 2024, https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=03.04#03.04.13
[192] Luciano Sissa, Storia della Valtellina, Tipografia del Dott. Francesco Vallardi, Milano, 1860 p.49; Vittorio Spreti, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana Famiglie Nobili e Titolate Viventi Riconosciute dal R. Governo d’Italia, vol. V, Arnoldo Forni Editore, Milano, 1928-36, p.549
[193] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, “Giusdicenza di Ponte sec. XIII – sec. XV”, visitato il 3 dicembre 2024, https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/10000387/?view=toponimi&hid=0
[194] Massimo Della Misericordia, Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447), in «Società e storia», Vol. XXII, n. 86, Franco Angeli Editore, 1999, p.727.
[195] Luciano Sissa, Storia della Valtellina, Tipografia del Dott. Francesco Vallardi, Milano, 1860 p.81; Vittorio Spreti, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana Famiglie Nobili e Titolate Viventi Riconosciute dal R. Governo d’Italia, vol. V, Arnoldo Forni Editore, Milano, 1928-36, p.549; “Pietro Brunoro Sanvitale”, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 90, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2017, p.521.
[196] Francesco Palazzi-Trivelli, tavole genealogiche della famiglia de Carugo in “Le Genealogie – Famiglie presenti nel Mandamento di Sondrio”, Società Storica Valtellinese, accesso il 3 dicembre 2024: https://www.storicavaltellinese.it/images/risorse/genealogie/carugo.pdf .
[197] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, “Valtellina sec. XIV - 1512”, visitato il 3 dicembre 2024, https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/10000386/ ; Giuseppe Caraci, Giovanni Dalmasso, Camillo Bassi, Carlo Guido Mor, “Valtellina”, in Enciclopedia Italiana, 1937, https://www.treccani.it/enciclopedia/valtellina_(Enciclopedia-Italiana)/
[198] Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Fondi Archivistici Comunali Antichi dal 1385 al 1927, fondo Famiglie, schede relative alla Famiglia Carugo, cart.1422-4123, Milano.
[199] Francesco Saverio Quadrio, Dissertazioni Critico-Storiche Intorno alla Rezia di qua dalle Alpi oggi detta Valtellina, Vol. 1, Forni Editore, Bologna, 1970, p. 293; Giuseppe Romegialli, Storia della Valtellina e delle Contee di Bormio e Chiavenna, Vol. 1, Giovanni Battista della Cagnoletta, Sondrio, 1834, p.207.
[200] Francesco Saverio Quadrio, Dissertazioni Critico-Storiche Intorno alla Rezia di qua dalle Alpi oggi detta Valtellina, Vol. 1, Forni Editore, Bologna, 1970, p. 290; Giuseppe Romegialli, Storia della Valtellina e delle Contee di Bormio e Chiavenna, Vol. 1, Giovanni Battista della Cagnoletta, Sondrio, 1834, p.202.
-
[201] Massimo Della Misericordia, Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447), in «Società e storia», Vol. XXII, n. 86, Franco Angeli Editore, 1999, p.731.
[202] Massimo Della Misericordia, Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447), in «Società e storia», Vol. XXII, n. 86, Franco Angeli Editore, 1999, p.729.
[203] Ilyes Piccardo, La Val d’Ambria verso la polarizzazione sociale. Paesaggio, società ed economia (secoli XIV-XV), in “Le Radici Della Terra Le Miniere Orobiche Valtellinesi Da Risorsa Economica A Patrimonio Culturale Delle Comunità Tra Medioevo Ed Età Contemporanea” a cura di Paolo de Vingo, Le Radici di una Identità, FrancoAngeli Open Access, Milano, 2022, p.217.
[204] Ilyes Piccardo, La Val d’Ambria verso la polarizzazione sociale. Paesaggio, società ed economia (secoli XIV-XV), in “Le Radici Della Terra Le Miniere Orobiche Valtellinesi Da Risorsa Economica A Patrimonio Culturale Delle Comunità Tra Medioevo Ed Età Contemporanea” a cura di Paolo de Vingo, Le Radici di una Identità, FrancoAngeli Open Access, Milano, 2022, p.217-218; pergamene originali conservate presso l’Archivio di Stato di Sondrio, Atti dei notai, b. 143, Ambria, Ulberico fu Pietro di Boffetto, cc. 21 r., 21 v., 1433, gennaio, 10; ivi, cc. 244 v., 245 r., 1457, gennaio, 11; ivi, cc. 246 r., 246 v., 1466, marzo, 3; ivi, cc. 256 r., 256 v., 1470, agosto, 20; ivi, c. 260 v., 1471, otto-bre, 26; ivi, cc. 247 v., 248 r., 1472, agosto, 8; ivi, cc. 252 v., 253 r., 1478, marzo, 27; ivi, c. 254 r., 1478, giugno, 1; ivi, cc. 143 r., 143 v., 1491, novembre, 22.
[205] Massimo Della Misericordia, La disciplina contrattata vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo, Edizioni Unicopli, Milano, 2000, p.207
[206] Luciano Sissa, Storia della Valtellina, Tipografia del Dott. Francesco Vallardi, Milano, 1860 p.48; U. Cavallari, Memorie spettanti alle famiglie Venosta di Valtellina e ai signori di Mazia di Venosta, Sondrio, Società Storica Valtellinese, 1958.
[207] Archivio del Comune di Postalesio, fondo Atti cartacei (1523 - 1800), Fascicolo cart., cc. 31 num. rec.
[208] “San Rocco – Carolo” in Parrocchie di Ponte, visitato il 24 novembre 2024, https://www.parrocchiaponte.it/chiese/san-rocco-carolo .
[209] Gli Offici del Comune di Milano e del Dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515), Caterina Santoro, Antonio Giuffrè, Milano, 1968, p.153.
[210] Gli Offici del Comune di Milano e del Dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515), Caterina Santoro, Antonio Giuffrè, Milano, 1968, p.47.
[211] Liber incantuum laboreriorum et reparationum ciuitatis Cumarum (1426-1436), a cura di Marta Luigina Mangini, Società Ligure di Storia Patria, Genova Palazzo Ducale, 2016.
[212] Fabio Troncarelli, “Carcano Bernabò” in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1976, vol. 19.
[213] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, codice H48 inf., fascicolo 109r, Milano, 1432; Fabio Troncarelli, “Carcano Bernabò” in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1976, vol. 19.
[214] Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Fondi Archivistici Comunali Antichi dal 1385 al 1927, fondo Famiglie, schede relative alla Famiglia Carugo, cart.1422-4123, Milano.
[215] Caterina Santoro, La Matricola dei Mercanti di Lana Sottile di Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1940, pag 21.
[216] Pergamene originali custodite presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Militare, Piazze Forti, Castello di Porta Giovia. Luca Beltrami, Il Castello di Milano sotto il dominio dei Visconti e degli Sforza, Ulrico Hoepli, 1894, Milano, p.130 e ss.
[217] Pergamene originali custodite presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Militare, Piazze Forti, Castello di Porta Giovia. Luca Beltrami, Il Castello di Milano sotto il dominio dei Visconti e degli Sforza, Ulrico Hoepli, 1894, Milano, p.130 e ss
[218] Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, Vol. I-II, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877, p.268
[219] Archivio Storico, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Registro 5, c. 55, Milano, 1472; Materiali per la storia dell’Ospedale Maggiore di Milano: le Ordinazioni capito lari de gli anni 1456 -1498, a cura di Giuliana Albini e Marina Gazzini, Reti Medievali Rivista, Firenze University Press, 2011, p.304.
[220] Antonio Piantanida, Cinque consignationes del 1239 relative a terre di proprietà della chiesa di S. Vittore di Varese, in “Studi Di Storia Medioevale e Di Diplomatica”, Istituto di Storia Medioevale e Moderna dell’Istituto di Paleografia e Diplomatica, Università’ degli Studi di Milano, Milano, 1976, p.71-72.
[221] Archivio Storico, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Registro 5, cc. 69, 70, Milano, 1473; Materiali per la storia dell’Ospedale Maggiore di Milano: le Ordinazioni capito lari de gli anni 1456 -1498, a cura di Giuliana Albini e Marina Gazzini, Reti Medievali Rivista, Firenze University Press, 2011, p.309.
[222] Archivio Storico, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Registro 6, c. 34, Milano, 1478; Materiali per la storia dell’Ospedale Maggiore di Milano: le Ordinazioni capito lari de gli anni 1456 -1498, a cura di Giuliana Albini e Marina Gazzini, Reti Medievali Rivista, Firenze University Press, 2011, p.350.
[223] Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Atti dei Notai Atti (1290 – 1919), Regni Pietro (1395-1438) quondam Ambrosolo, Milano, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/727575
[224] Gli Offici del Comune di Milano e del Dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515), Caterina Santoro, Antonio Giuffrè, Milano, 1968, p.414.
[225] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali “Consiglio dei Novecento sec. XIV – sec. XVI”, 2005.
[226] Memorie Spettanti alla Storia della Città e Campagna di Milano, Conte Giorgio Giulini, Vol. V, Milano, 1856, p.280
[227] Statuta Iurisdictionum Medioilani Saeculo XIV, Lata, Augustae Taurinorum, 1869, Cap.XIV.
[228] Pergamena originale conservata presso l’Archivio Civico di Milano, Registro delle provvisioni 1385-1388, foglio Nr107 e ss. Citazione estratta da Historia dell’Antichità di Milano divisa in quattro libri, R.P.F. Paolo Morigia, Guerra, Venezia, 1592, p.695, 696, 698. Felice Calvi, Il Patriziato Milanese secondo nuovi documenti deposti negli archivi pubblici e privati, IIa edizione, Andrea Mosconi, Milano, 1865, p.371 e ss.
[229] Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, Vol. III, Premiata Tipografia Fratelli Fusi, Pavia, 1903, p.453. Originale presso l’Archivio Comunale di Vigevano, Ant. Stat., ff. 94-7.
[230] Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, Vol. III, Premiata Tipografia Fratelli Fusi, Pavia, 1903, p.460. Originale presso l’Archivio Comunale di Vigevano, Ant. Stat., ff. 94-7.
[231] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.3521 lemale 242, Milano, 1444.
[232] J. Du Mont, Baron de Carels-croon, Corps Universel Diplomatique du Droit Des Gens, Amsterdam, 1726, p.418.
[233] Philippus Argelatus Bononiensis, De Monetis Italiae Variorum Illustrium Virorum Dissertationes, Mediolani, 1750, p.40.
[234] F. M. Vaglienti, “Galeazzo Sforza” in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1998, vol. 51, pp.404-405
[235] Pergamena originale presso l’ Archivio di Stato di Milano, fondo Potenze Estere, Genova, cartella 407, 1452 novembre. Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie II, Vol LXXVI, fasc. II, Genova, 1962, 189-190.
[236] Il tardogotico del duomo di Milano architettura e decorazione intorno all'anno 1400, Paolo Sanvito, LIT Verlag, 2002, p.44.
[237] Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, Vol. I, Vol. II, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877
[238] Manoscritto originale conservato presso l’Archivio del Rettorato dell’Università di Pavia, Parodi, Rotoli, vol. C, fol.113, che trascrive dal « Registrum Civitatis 1441 , fol . 126 », edito in Codice Diplomatico dell’Università di Pavia, a cura di Rodolfo Maiocchi, Vol. II 1401-1440, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia, 1913, p.433
[239] Manoscritto originale conservato presso l’Archivio del Rettorato dell’Università di Pavia, Rotoli Originali; », edito in Codice Diplomatico dell’Università di Pavia, a cura di Rodolfo Maiocchi, Vol. II 1401-1440, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia, 1913, p.470.
[240] Manoscritto custodito presso l’Archivio del Rettorato dell’Università di Pavia, Parodi, Rotoli originali, vol. C, fol.121 che lo trascrisse dall'originale «ex archivo civitatis» ora perduto; edito in Codice Diplomatico dell’Università di Pavia, a cura di Rodolfo Maiocchi, Vol. II 1401-1440, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia, 1913, p.485.
[241] Manoscritto originale conservato presso l’Archivio del Rettorato dell’Università di Pavia, Parodi, Rotoli, vol. C, fol.125 seg; edito in Codice Diplomatico dell’Università di Pavia, a cura di Rodolfo Maiocchi, Vol. II 1401-1440, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia, 1913, p.520.
[242] Manoscritto originale conservato presso la Biblioteca Universitaria , G. Bossi . Ms. Studium, fol. 5 ; Archivio del Rettorato , PARODI, Rotoli, vol. C, fol . 119; edito in Codice Diplomatico dell’Università di Pavia, a cura di Rodolfo Maiocchi, Vol. II 1401-1440, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia, 1913, p.481
[243] Manoscritto custodito presso l’Archivio del Rettorato dell’Università di Pavia, PARODI, Rotoli, vol. C, fol. 123; edito in Codice Diplomatico dell’Università di Pavia, a cura di Rodolfo Maiocchi, Vol. II 1401-1440, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia, 1913, p.496
[244] Cenni Storici sulle Due Università di Pavia e di Milano, Paolo Sangiorgio, Placido Maria Visaj, Milano, 1831, p.104.
[245] Codice Diplomatico dell’Università di Pavia, a cura di Rodolfo Maiocchi, Vol. II 1401-1440, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia, 1913, P.527. Archivio Storico Civico – Biblioteca Trivulziana, Milano, Serie Lettere Ducali periodo Sforzesco, atti nn.9, 11-16; Memorie della Città e Campagna di Milano nei Secoli Bassi, Conte Giorgio Giulini, Nuova Edizione Francesco Colombo, Milano, 1857, Vol. VI, p.403, 438; Delle Antichità Longobardico-Milanesi, Vol. III, Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, Milano, 1743. Storia di Milano di Bernardo Corio, Vol. III, Francesco Colombo Editore, Milano, 1857
[246] Notizie Istoriche Intorno a’ Medici Scrittori Milanesi, Bartolomeo Corte, conte Carlo Pertusati, Stampa Giuseppe Pandolfo Malatesta, Milano, 1718, p.283-290. Cenni Storici sulle Due Università di Pavia e di Milano, Paolo Sangiorgio, Placido Maria Visaj, Milano, 1831, p.107. Memorie della Città e Campagna di Milano nei Secoli Bassi, Conte Giorgio Giulini, Nuova Edizione Francesco Colombo, Milano, 1857, Vol. VI, p.403, 438. Delle Antichità Longobardico-Milanesi, Vol. III, Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, Milano, 1743.
[247] Almum Studium Papiense Storia dell’Università di Pavia, Volume 1 Dalle origini all’età spagnola
Tomo I Origini e fondazione dello Studium generale, a cura di Dario Mantovani, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino, Pavia, 2012, p.385.
[248] William Desborough Cooley, The History of Maritime and Inland Discovery, Volume 1, Longman, Rees, Orme, and Green, Lilly, Wait & Company, London-Boston, 1833, p.286.
[249] Comte Roselly de Lorgues, Christopher Columbus, Société générale de librairie catholique, Troisième Grande Edition, Paris, 1887, p.10.
[250] Carlo Dell’Acqua, Nuove osservazione confermano che Cristoforo Colombo studiò in Pavia, Stabilimento Tipografico Successori Bizzoni, Pavia, 1880, p.18.
[251] Vite de’ più celebri Marini, Prima versione italiana considerevolmente accresciuta di altre vite che mancano all’originale francese, Tomo II, Stamperia Pasquale Tizzano, Napoli, 1823, p.58. Cav. Luigi Bossi, Vita di Cristoforo Colombo, Tipografia di Vincenzo Ferrario, Milano, 1818, p.72.
[252] Marianne Mahn-Lot, Enciclopedia Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 27, “Cristoforo Colombo”, (1982).
[253] Cornelio Desimoni, “Questioni Colombiane” in Raccolta di Documenti e Studi Pubblicati della R. Commissione Colombiana pel Quarto Centenario dalla Scoperta dell’America, Vol. II Parte II, Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 1894, P.29.
[254] Aldo Agosto, “In Quale Pavia Studiò Colombo” in Columbeis II, Università di Genova Facoltà di Lettere, Genova, 1987.
[255] Fernando Colon, Vida del Almirante Don Cristobal Colon, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1947, p.35.
[256] Rerum Italicarum Scriptores Raccolta degli Storici Italiani dal cinquecento al millecinquecento, L.A. Muratori, Nicola Zanichelli, Tomo XV – Parte 1, Bologna, 1921, p.260
[257] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.3959 lemale 247, Milano, 1410.
[258] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.3958 lemale 247, Milano, 1410.
[259] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.3235 lemale 239, Milano, 1431.
[260] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.3613 lemale 243, Milano, 1451.
[261] Ivi, “actum subtus anditum porte mastre Monasterii Dominarum Humiliatarum Sancti Petri Martiris syti in Parrochia Sancte Eufemie intus”.
[262] Il Ducato di Milano Studi Storici Documentati, Marco Formentini, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877, p.192.
[263] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.3646 lemale 243, Milano, 1454. Anna Caso, Per la storia della società milanese: i corredi nuziali nell’ultima età viscontea e nel periodo della Repubblica Ambrosiana (1433-1450), dagli atti del notaio Protaso Sansoni, in Nuova Rivista Storica, Volume 65, Issues 5-6, Società editrice Dante Alighieri, 1981.
[264] Santo Monti, Compendio dell’origine e dignità della famiglia Mandelli, da un manoscritto inedito di Tazio Mandelli, in “Società Storica per la Provincia e Antica Diocesi di Como”, R. Deputazione di storia patria per la Lombardia Sezione di Como, Vol. XV, Como, 1903, pp.68, 70.
[265] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.5684 lemale 270, Milano, 1503.
[266] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.5488 lemale 268, Milano, 1509.
[267] Francois Avril, Marie-Thérèse Gousset, Claudia Rabel, Manuscrits Enluminés d'Origine Italienne, Vol.2 XIIIe Siècle, Bibliothèque Nationale Département des Manuscrits Centre de Recherche sur les Manuscrits Enluminés, Bibliothèque Nationale, Paris, 1984, p.31, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t5371114q/f53.item
[268] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.2582 lemale 231, Inverigo, 1333.
[269] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.2619 lemale 231, Como, 1338.
[270] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, pergamena n.2779 BIS e n.2780 BIS, Milano, 1355-56.
[271] Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, Vol. II, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877, p.262.
[272] Archivio dell'Ente Comunale di Assistenza di Monza, Fondo Pergamene (1174 - 1782), b. 5, n. 163
[273] Archivio dell'Ente Comunale di Assistenza di Monza, Fondo Pergamene (1174 - 1782)b. 7, n. 285, 286
[274] Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, Vol. II, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877, p.277.
[275] Vittorio Spreti, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, Vol.5, Arnoldo Forni Editore, Ristampa dell’edizione di Milano, 1928-1936, pp.158-159.
[276] Santo Monti, Compendio dell’origine e dignità della famiglia Mandelli, da un manoscritto inedito di Tazio Mandelli, in “Società Storica per la Provincia e Antica Diocesi di Como”, R. Deputazione di storia patria per la Lombardia Sezione di Como, Vol. XV, Como, 1903, pp.68, 70.
[277] Caterina Santoro, La Matricola dei Mercanti di Lana Sottile di Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1940, pag 16.
[278] Origini del Capitalismo Lombardo studi e documenti sull’economia milanese del periodo ducale, Gino Barbieri, Giuffrè, Milano, 1961, p.545.
[279] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Atti dei Notai (1290 – 1919), Rubriche dei Notai (sec. XIV – XIX), notaio Pietro Regni q. Ambrosolo, Milano, 1399. Gino Barbieri, Economia e Politica nel Ducato di Milano 1386 – 1535, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano, 1938, p.16.
[280] Caterina Santoro, La Matricola dei Mercanti di Lana Sottile di Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1940, pag 16.
[281] Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Fondi Archivistici Comunali Antichi dal 1385 al 1927, fondo Famiglie, schede relative alla Famiglia Carugo, cart.1422-4123, Milano.
[282] Caterina Santoro, La Matricola dei Mercanti di Lana Sottile di Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1940, pag 21.
[283] Caterina Santoro, La Matricola dei Mercanti di Lana Sottile di Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1940. Pag 92.
[284] Marina Gazzini, Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, in “Itinerari Medioevali”, a cura di Roberto Greci, CLUEB Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, Bologna, 2006, p.235, 236, 241.
[285] Marina Gazzini, Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, in “Itinerari Medioevali”, a cura di Roberto Greci, CLUEB Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, Bologna, 2006, p.235 – 236; L'Età dei Visconti : il dominio di Milano fra XIII e XV secolo, a cura di Luisa Chiappa Mauri, Laura De Angelis Cappabianca, Patrizia Mainoni, La Storia, Milano, 1993, p.312, 315, 317.
[286] Marina Gazzini, Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, in “Itinerari Medioevali”, a cura di Roberto Greci, CLUEB Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, Bologna, 2006, p.239.
[287] Marina Gazzini, Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, in “Itinerari Medioevali”, a cura di Roberto Greci, CLUEB Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, Bologna, 2006, p.240.
[288] Marina Gazzini, Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, in “Itinerari Medioevali”, a cura di Roberto Greci, CLUEB Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, Bologna, 2006, p.208.
[289] Marina Gazzini, Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, in “Itinerari Medioevali”, a cura di Roberto Greci, CLUEB Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, Bologna, 2006, p.240.
[290] Umanesimo e Rinascimento in Brianza studi sul patrimonio culturale, Virginio Longoni, Electa, Milano, 1998, p.128; The Renaissance A History of Civilization in Italy from 1304-1576 A.D., Will Durant and Ariel Durant, Simon and Schuster, 1953, p.228.
[291] Beatrice D'Este, Duchess of Milan, 1475-1497 A Study of the Renaissance, Julia Cartwright Ady, Dent & Sons Ltd, London, 1928, p.120.
[292] Elenco dei Benefattori dell’Ospedale Maggiore di Milano 1456-1886, Tipografia L.F. Cogliati, Milano, 1887, pag 234
[293] Paola Venturelli, Leonardo da Vinci e le arti preziose – Milano tra XV e XVI secolo, Marsilio, 2002, p.53.
[294] Caterina Santoro, La Matricola dei Mercanti di Lana Sottile di Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1940. Pag 16.
[295] Gino Barbieri, Economia e Politica nel Ducato di Milano 1386 – 1535, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano, 1938, p.26, 189.
[296] Gino Barbieri, Economia e Politica nel Ducato di Milano 1386 – 1535, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano, 1938, p.189.
[297] Storia di Milano: L'età sforzesca dal 1450 al 1500, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Vol. VII, Milano, 1956, p.893.
[298] Materiali per la storia dell’Ospedale Maggiore di Milano: le Ordinazioni capito lari de gli anni 1456 -1498, a cura di Giuliana Albini e Marina Gazzini, Reti Medievali Rivista, Firenze University Press, 2011, pp.236, 237.
[299] Archivio Storico, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Registro 3, c.34, Milano, 1462.
[300] Archivio Storico, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Registro 3, c.35, Milano, 1462.
-
[301] Archivio Storico, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Registro 3, cc.35, 36, Milano, 1462.
[302] Archivio Storico, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Registro 3, c. 36, Milano, 1462.
[303] Pergamena originale conservata presso Archives Nationales, Monuments historiques Louis XII, 1498-1515, p.11 or. pap.Edouard Rott, Inventaire Sommaire des Documents Relatifs a l’Histoire de Suisse conservés dans les archives et bibliothèques de Paris, IIIme Partie, Imprimerie S. Collin, Berne, 1888, p.634.
[304] Archivio di Stato di Milano, Fondo notarile, regesta Cristoforo Agrati 1418-1426.
[305] Maria Paola Zanoboni, Artigiani, Imprenditori, Mercanti organizzazione del lavoro e conflitti sociali nella Milano sforzesca 1450-1476, La Nuova Italia, 1996, p.117.
[306] Corps Universel Diplomatique du Droit Des Gens, J. Du Mont, Baron de Carels-croon, Amsterdam, 1726
[307] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, Pergamena 1022 Custodi 32 , Vigevano, 1488.
[308] Elenco Storico Biografico dei Benefattori dell’Ospedale Maggiore di Milano 1456-1886, Milano, Tipografia L.F. Cogliati, 1887
[309] Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, Pergamena 83 TER, Vigevano, 1490; Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, Pergamena 83 BIS, Milano, 1520.
[310] Elenco dei Benefattori dell’Ospedale Maggiore di Milano 1456-1886, Tipografia L.F. Cogliati, Milano, 1887, pag 263
[311] Vedi paragrafo “Consiglieri presso il Consiglio dei Novecento”.
[312] Miscellanea di Storia Patria Edita per Cura della Regia Deputazione di Storia Patria, Tomo XIII, Fratelli Bicocca Librai di S.M., Torino, 1871, Torino, p.132
[313] Marco Rossi, Disegno Storico dell’Arte Lombarda, Trattati e Manuali Vita & Pensiero, Milano, 2005, p.156
[314] Caterina Pirina, “Antonio Da Pandino «magister Vitriatarum».” Arte Lombarda, no. 132 (2) (2001), p.37
[315] Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, Vol. I, Libreria Editrice G. Brigola, Milano, 1877, p.314.
[316] Periodico della Società Storica per la Provincia e Antica Diocesi di Como, Tipografia Provinciale F. Ostinelli di C.A., Vol XI, Como, 1896, p.184 e ss. La pergamena originale è conservata presso l’Archivio Storico della Diocesi di Como, giornale A, 1485-1489, fogli 294 e 295.
[317] Emilio Motta, Bollettino Storico della Svizzera Italiana, Eredi Carlo Colombi, Bellinzona, 1894, p.238.
[318] Francesco Malaguzzi Valeri, La Corte di Lodovico il Moro, Le Arti Industriali La Letteratura La Musica, Vol IV,Ulrico Hoepli, Milano, 1923, p.78
[319] Pergamena originale presso l’ Archivio di Stato di Milano, fondo Potenze Estere, Genova, cartella 407, 1452 novembre. Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie II, Vol LXXVI, fasc. II, Genova, 1962, p.189-190.
[320] Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana, Registri di lettere ducali, 14, f. 201, 22 dicembre 1483 e ibidem, f. 202, patente del 6 aprile 1484, Milano; Permessi di costruire lungo il ‘fosso di Milano’ (1450‐1499), Maria Nadia Covini, in “Flos studiorum Saggi di storia e di diplomatica per Giuliana Albini”, Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano ‐ Bruno Mondadori Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, Vol. III, Pearson Itali, Milano-Torino, 2020, p.367, https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/14000/13385.
[321] Pergamena originale conservata presso la Biblioteca Trivulziana, codice Nr. 1818, Foglio 349, Milano; Geschicte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschlufs von Venedig, Dr. Aloys Schulte, Duncker & Humblot, Leipzig, 1900, p.102.
[322] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Nr 134-180, Regesta Motta. Geschicte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschlufs von Venedig, Dr. Aloys Schulte, Duncker & Humblot, Leipzig, 1900, p.91.
[323] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Nr 1014, notaio Pietro Brenna, docc. 5881-5883, doc. 5885. Le residenze viscontee da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca, a cura di Serena Romano e Marco Rossi, Silvana Editoriale, Milano, 2023, p.357-358.
[324] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Nr 1014, notaio Pietro Brenna, doc. 5884. Le residenze viscontee da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca, a cura di Serena Romano e Marco Rossi, Silvana Editoriale, Milano, 2023, p.357.
[325] Le residenze viscontee da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca, a cura di Serena Romano e Marco Rossi, Silvana Editoriale, Milano, 2023, p.347
[326] Vittorio Adami, Antichi alberghi in un'antica via di Milano, 1922, in: Archivio storico lombardo vol. 49 (1922) p.156
[327] Arturo Graf, Francesco Novati, Rodolfo Renier, Giornale Storico della Letteratura Italiana, Vol IX, Ermanno Loescher, Torino, 1887, p.412. Vittorio Adami, Antichi alberghi in un'antica via di Milano, 1922, in: Archivio storico lombardo vol. 49 (1922) p.154.
[328] Ein venetianischer Reisebericht über Süddeutschland, die Ostschweiz und Oberitalien aus dem Jahre 1492
Simonsfeld, Henry. (1895) - In: Zeitschrift für Kulturgeschichte Ser. 4, vol. 2 (1895) p.278
[329] Vittorio Adami, Antichi alberghi in un'antica via di Milano, 1922, in: Archivio storico lombardo vol. 49 (1922) p.155
[330] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Potenze Estere Svizzera Grigioni, Cart. 143.
[331] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Potenze Estere Svizzera Grigioni, Cart. 143.
[332] Le residenze viscontee da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca, a cura di Serena Romano e Marco Rossi, Silvana Editoriale, Milano, 2023, p.347
[333] Vittorio Adami, Antichi alberghi in un'antica via di Milano, 1922, in: Archivio storico lombardo vol. 49 (1922) p.157-158
[334] Pergamena originale conservata presso il Furst Thürn und Taxis Zentralarchiv, Ratisbona, Posturkunden, 10, 1536. Regesto in Martin Dallmeier, Quellen zur geschichte, cit., teil II, p.11, n.15
[335] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Nr 1014, notaio Pietro Brenna, docc. 5881-5883, doc. 5885
[336] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Nr 3138, notaio Bernardo Bossi.
[337] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Nr 1018, notaio Pietro Brenna, atto n.6822.
[338] Pergamena originale conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Nr 1018, notaio Pietro Brenna, atto n.6995
[339] Inventario conservato presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Nr 14178, 4 settembre 1565, doc. n. 5.
[340] Silvio Leydi, Gli Annoni "conductores mercantiarum de partibus Flandrie in Italia". Una famiglia milanese tra Cinquecento e Seicento, Francesco Brioschi editore, Milano, 2015, p.40 e seguenti.
[341] Vittorio Adami, Antichi alberghi in un'antica via di Milano, 1922, in: Archivio storico lombardo vol. 49 (1922) p.163
[342] Federico Crimi, J.M.W. Turner e il Verbano, 1819: Torino, Milano e il Sempione, in Verbanus, Vol. XXVIII, Alberti Libraio, 2007, p.42.
[343] Vittorio Adami, Antichi alberghi in un'antica via di Milano, 1922, in: Archivio storico lombardo vol. 49 (1922) p.163
[344] Lo Stato di Milano nel XVII secolo Memoriali e Relazioni, a cura di Massimo Carlo Giannini e Gianvittorio Signorotto, in “Politica, Fazioni, Istituzioni nell’ Italia Spagnola dall’ Incoronazione di Carlo V (1530) alla Pace di Westfalia (1648)”, coordinamento di Elena Fasano Guarini, Pubblicazione degli Archivi di Stato Fonti XLVI, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari Direzione Generale per gli Archivi, Roma, 2006, p.XI
[345] Scrittori d’Italia Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, a cura di Arnaldo Segarizzi, Vol. II Milano – Urbino, Giuseppe Laterza & Figli, Bari, 1913, p.85-86.
[346] Marco Formentini, La Dominazione Spagnuola in Lombardia, Giuseppe Ottino Editore, Milano, 1881, p.22-23.
[347] Stefano D’Amico, Spanish Milan a City Within the Empire 1535-1706, Palgrave Macmillan, United States of America, 2012, p.62.
[348] Stefano D'Amico, Le contrade e la città. Sistema produttivo e spazio urbano a Milano fra Cinque e Seicento, Milano 1994, p.79.
[349] Giovanni Vigo, Milano nell’età spagnola: metamorfosi economica di una città, in Storia Economica, Anno I, Vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, p.86-87; Archivio Storico Civico di Milano, Materie, c. 571: "L'Università de Mercanti di Lana, e Drapperi di Milano" (s.d.); Archivio Storico Civico di Milano, Materie, c. 571: doc. 28 gennaio 1643.
[350] Giovanni Vigo, Milano nell’età spagnola: metamorfosi economica di una città, in Storia Economica, Anno I, Vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, p.81.
[351] Giovanni Vigo, Milano nell’età spagnola: metamorfosi economica di una città, in Storia Economica, Anno I, Vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, p.83; Archivio di Stato di Milano, Commercio, p.a., c. 228: "Informatione delli Tessitori di Seta argento, et oro di questa Città per ovviare, che la Seta non sia mandata fuori di questo Stato", 1606; Archivio di Stato di Milano, Commercio, p.a., c. 228: doc. allegato alla consulta del 1° luglio, 1606
[352] Giovanni Vigo, Milano nell’età spagnola: metamorfosi economica di una città, in Storia Economica, Anno I, Vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, p.86; Archivio di Stato di Milano, Commercio, p.a., c. 228: doc. del 26 giugno 1635 allegato alla consulta del 26 ottobre 1640.
[353] Giovanni Vigo, Milano nell’età spagnola: metamorfosi economica di una città, in Storia Economica, Anno I, Vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, p.88; M. Aymard, La fragilità di un'economia avanzata: l'Italia e le trasformazioni dell'economia, in Storia dell'economia italiana, vol. Il, Torino, 1991, p.116; A. Frumento, Imprese lombarde nella storia della siderurgia italiana, Milano 1958, vol. II, p.124; J. Gelli, Gli archibugiari milanesi. Industria, commercio, uso delle armi da fuoco in Lombardia, Milano 1905, p.103.
[354] Domenico Sella, Crisis and Continuity: The Economy of Spanish Lombardy in the Seventeenth Century, Harvard University Press, Cambridge (USA), 1979.
[355] Domenico Sella, L’economia lombarda durante la dominazione spagnola, Il Mulino, Bologna, 1982.
[356] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, Ville Gentilizie nell’Alto Milanese, “L’Evoluzione della Villa Gentilizia nel Tempo, Il Cinquecento”, 9 novembre 2024: https://www.lombardiabeniculturali.it/percorsi/ville-milano/1.2/
[357] Cesare Cantù, Milano Storia del Popolo e pel Popolo, Tipografia e Libreria Ditta Giacomo Agnelli, Milano, 1871, p.30-31.
[358] Prof. Agostina Colombo, Carugo Attraverso i Secoli: I Carugo i Signori della Nostra Terra, Seconda Parte, in “Carughese”, Amministrazione Comunale di Carugo, Carugo, Settembre 2010.
[359] Federico Chabod, Storia Di Milano Nell'epoca Di Carlo V, Giulio Einaudi Editore, Milano, 1971, p.155
[360] Letizia Arcangeli, Gian Giacomo Trivulzio marchese di Vigevano e il governo francese nello stato di Milano (1499-1518), in “Gentiluomini di Lombardia: ricerche sull’aristocrazia padana nel Rinascimento”, Unicopli,
Milano, 2003, pp.3-68.
[361] Federico Chabod, Storia Di Milano Nell'epoca Di Carlo V, Giulio Einaudi Editore, Milano, 1971, p.154
[362] Archivio di Stato di Milano, fondo Riva Finolo (1208 - 1812), Archivio Genealogico di Giovanni Sitoni di Scozia, registro nr.32 (28), https://archiviodistatomilano.cultura.gov.it/fileadmin/risorse/Patrimonio_archivistico/Fondi_e_Inventari/R/Riva_Finolo-AD_35.pdf
[363] Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana, Fondo Famiglie, famiglia Carugati (cart.1421), famiglia Carugo (cart.1422-4123), Milano, 26 aprile 1558.
[364] Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Porri Pietro Antonio (1495-1547) quondam Bernardo, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/724694
[365] Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Pellizzari Giovanni Paolo (1569-1592) quondam Pietro Antonio, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/724694
[366] Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Crippa Giovanni Antonio (1588-1629) quondam Cesare, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/694726
[367] Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Moriggia Giovanni Giacomo (1545-1578) quondam Giovanni Andrea, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/721271
[368] Archivio di Stato di Milano, fondo Riva Finolo (1208 - 1812), Archivio Genealogico di Giovanni Sitoni di Scozia, registro nr.32 (28),
[369] Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana, Fondo Famiglie, famiglia Carugati (cart.1421), famiglia Carugo (cart.1422-4123), Milano, 6 febbraio 1688, 19 luglio 1689, e 21 marzo 1696.
[370] Salvatore Colombo, Daniele Santambrogio, La roggia Borromeo, in “Cesano Maderno Bene Culturale: l'inizio di una storia”, Arte Lombarda, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Nuova serie, No. 138 (2), 2003, p.63; https://www.jstor.org/stable/43106366 .
[371] Salvatore Colombo, Daniele Santambrogio, La roggia Borromeo, in “Cesano Maderno Bene Culturale: l'inizio di una storia”, Arte Lombarda, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Nuova serie, No. 138 (2), 2003, p.64, https://www.jstor.org/stable/43106366 .
[372] Vedi il paragrafo “Ufficiali Ducali” del periodo signorile visconteo e sforzesco.
[373] Pietro Canetta, Elenco dei Benefattori degli Ospedale Fatebenefratelli in Milano, Tipografia A. Lombardi, 1888, Milano, p.11; Andrea Spiriti, Un Bellissimo Pezzo di Fabbrica Il Fatebenefratelli tra Barocco e Neoclassico, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, Milano, 1992, p.139.
[374] Aldo de Maddalena, “Affaires et Gens d’affaires Lombards Sur Les Foires de Bisenzone: L’exemple Des Lucini (1579-1619).” Annales. Histoire, Sciences Sociales 22, no. 5, 1967, p.944
[375] Pietro Canetta, Elenco dei Benefattori degli Ospedale Fatebenefratelli in Milano, Tipografia A. Lombardi, 1888, Milano, p.11
[376] Andrea Spiriti, Un Bellissimo Pezzo di Fabbrica Il Fatebenefratelli tra Barocco e Neoclassico, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, Milano, 1992, p.139.
[377] Andrea Spiriti, Un Bellissimo Pezzo di Fabbrica Il Fatebenefratelli tra Barocco e Neoclassico, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, Milano, 1992, p.15-16.
[378] Andrea Spiriti, Un Bellissimo Pezzo di Fabbrica Il Fatebenefratelli tra Barocco e Neoclassico, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, Milano, 1992, p.19.
[379] Andrea Spiriti, Un Bellissimo Pezzo di Fabbrica Il Fatebenefratelli tra Barocco e Neoclassico, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, Milano, 1992, p.114.
[380] Andrea Spiriti, Un Bellissimo Pezzo di Fabbrica Il Fatebenefratelli tra Barocco e Neoclassico, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, Milano, 1992, p.140.
[381] Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Balsami Paolo (1486-1534) quondam Giuliano, cart. 4415, atti nr. 1101 e 1102, 24 marzo 1513, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/678048.
[382] Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Carcani Alessandro (1555-1603) quondam Battista, cart. 14233, atto nr.119, 19 aprile 1560, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/687930.
[383] Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Carcani Alessandro (1555-1603) quondam Battista, cart. 14233, atto nr.119, 19 aprile 1560, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/687930.
[384] Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Carcani Alessandro (1555-1603) quondam Battista, cart.14264, atto nr.9323, 13 aprile 1592; Archivio di Stato di Milano, Fondo Atti dei Notai Atti 1290 – 1919, Carcani Alessandro (1555-1603) quondam Battista, cart.14264, atto nr.9926 12 luglio 1593, https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/687930 .
[385] Archivio parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Diocesi di Como), Registro dei Matrimoni, atto n.43, Rovellasca (CO), 21 febbraio 1574.
[386] Archivio parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Diocesi di Como), Stato delle Anime, numeri progressivi 85-88, Rovellasca (CO), 12 luglio 1592.
[387] Archivio parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Diocesi di Como), Registro dei Matrimoni, atto n.30, Rovellasca (CO), 10 febbraio 1591.
[388] Si registrano almeno altri quattro matrimoni con esponenti Cattaneo: Parrocchia di Misinto (MB) San Siro, Archivi Parrocchiali, Registri dei Matrimoni, Misinto, atto 8 novembre 1701; Parrocchia di Misinto (MB) San Siro, Archivi Parrocchiali, Registri dei Matrimoni, Misinto (MB), atto 7 febbraio 1733; Archivio parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Diocesi di Como), Registro dei Matrimoni, Liber Matrim. Vol.2, Rovellasca (CO), atto 4 febbraio 1764; Archivio Demografico Comune di Misinto (MB), Registro Stati di Famiglia, Foglio n.132. c.1885.
[389] Archivio di Stato di Como, fondo Comune Antichi Regimi, Estimi, catasti civili e ruoli 1439-1760, cartella nr.185, Censo, Vol.III, Rovellasca, 5 agosto 1592, pp.69, 70, 73, 160; Archivio di Stato di Como, fondo Comune Antichi Regimi, Estimi, catasti civili e ruoli 1439-1760, Rovellasca, 4 giugno 1614, pp.30-32; Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Fondi Archivistici Comunali Antichi dal 1385 al 1927, fondo Famiglie, schede relative alla famiglia Carugati, cart.1421, Milano, 14 maggio 1609, numeri progressivi 23, 38, 26 aprile 1615;
[390] Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Atti dei Notai Atti (1290 – 1919), Argenti Giovanni Battista (1610-1630) quondam Francesco, cartella nr.26298, atto nr.2456, 17 luglio 1628, Milano, https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/676790; Archivio di Stato di Milano, Fondo Notarile, Atti dei Notai Atti (1290 – 1919), Visconti Giovanni Battista (1601-1653) quondam Filippo, cartella nr.24393, 11 aprile 1639, Milano, https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/738725 .
[391] Archivio parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Diocesi di Como), Registro delle Nascite, Liber Baptizat. Vol.2, Rovellasca (CO), atti 1° giugno 1621 e 19 marzo 1625.
[392] Francesco Bombognini, Carlo Redaelli, Antiquario della Diocesi di Milano, Seconda Edizione, Milano, 1828, pp.97-98; Cesare Cantù, Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto, Vol.III, Corona e Caimi Editori, Milano, 1858, p.898; Prof. Salvatore Cav. Muzzi, Vocabolario Geografico-Storico-Statistico dell’Italia nei suoi limiti naturali, Giacomo Monti Editore, Bologna, 1873, p.288.
[393] Archivio parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Diocesi di Como), Registro delle Nascite, Liber Baptizat. Vol.4, Rovellasca (CO), atti 30 settembre 1647, 20 luglio 1650, il 22 settembre 1651, 27 settembre 1653.
[394] Archivio di Stato di Como, Catasto del Regno Lombardo-Veneto, Comune Censuario di Rovellasca – Mandamento III di Como – Provincia di Como, 1857; Archivio di Stato di Como, Catasto Cessato, Estratto della mappa Censuaria del Comune di Misinto del Mandamento di Seveso Provincia di Milano relativo alla zona da aggregarsi al Comune di Rovellasca – Provincia di Como in esito al Regio Decreto 25 dicembre 1881; Archivio parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Diocesi di Como), Status Animarum Rovelasche, 1749 e 1756.
[395] Archivio parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Diocesi di Como), Status Animarum Rovelasche, 1749 e 1756; Parrocchia di Misinto (MB) San Siro, Archivi Parrocchiali, Registri dei Matrimoni, Misinto, atto 8 novembre 1701.
[396] Archivio di Stato di Como, Amministrazione dei beni di Rovellasca spettanti al Conservatorio delle zitelle di Como, notaio Paolo Giuseppe Pattica, b. 58, fasc. 12, 20 agosto 1701.
[397] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, “La Lombardia Grigiona: Valtellina, Bormio, Chiavenna (1512 – 1620; 1639 – 1797)”, visitato il 7 dicembre 2024, https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=03.04#03.04.13 .
[398] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali, “La Lombardia Grigiona: Valtellina, Bormio, Chiavenna (1512 – 1620; 1639 – 1797)”, visitato il 7 dicembre 2024, https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=03.04#03.04.13 .
[399] Alberto De Simoni, Ragionamento Giuridico-Politico sopra la Costituzione della Valtellina e del Contado di Chiavenna, Italia, 1788, p.6; Archivio di Stato di Milano, fondo “Miscellanea Lombarda”, vol. XXI, fasc. 25.
[400] Francesco Palazzi-Trivelli, tavole genealogiche della famiglia de Carugo in “Le Genealogie – Famiglie presenti nel Mandamento di Sondrio”, Società Storica Valtellinese, accesso il 3 dicembre 2024: https://www.storicavaltellinese.it/images/risorse/genealogie/carugo.pdf .
-
[401] Marta Luigina Mangini, «Con promessa e titolo di confederatione» Documenti e forme della memoria della prima fase di governo delle Tre Leghe in Valtellina, in “1512 I Grigioni in ValtellIna, BormIo e Chiavenna – Atti del Convegno storico Tirano e Poschiavo” a cura di Augusta Corbellini e Florian Hitz, Sondrio e Poschiavo, 2012, p.80.
[402] Guido Scaramelli, I Grigioni a fine ’400 nella considerazione delle autorità milanesi e delle popolazioni di Valtellina e Valchiavenna, in “1512 I Grigioni in ValtellIna, BormIo e Chiavenna – Atti del Convegno storico Tirano e Poschiavo” a cura di Augusta Corbellini e Florian Hitz, Sondrio e Poschiavo, 2012, p.19; Pergamena conservata presso l’Archivio di Stato di Milano datata 1491 febbraio 13 n. 158 edita in: Guido Scaramellini, Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna, in “Raccolta di studi storici sulla Valchiavenna, 15”, Chiavenna, 2000 pp. 219–503.
[403] Marta Luigina Mangini, «Con promessa e titolo di confederatione» Documenti e forme della memoria della prima fase di governo delle Tre Leghe in Valtellina, in “1512 I Grigioni in ValtellIna, BormIo e Chiavenna – Atti del Convegno storico Tirano e Poschiavo” a cura di Augusta Corbellini e Florian Hitz, Sondrio e Poschiavo, 2012, p.69.
[404] Archivio del Santuario della Beata Vergine di Tirano, Carteggio dalle Origini al Secolo XIX, b. 2, fasc. 56
[405] Luciano Sissa, Storia della Valtellina, Tipografia del Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1861, p.106.
[406] Paolo de Vingo, Ilaria Sanmartino, Estrazione, preparazione e gestione del ciclo minerario-metallurgico a Fusine e nel suo territorio tra fonti storico-archivistiche e strutture produttive, in “Le Radici Della Terra Le Miniere Orobiche Valtellinesi Da Risorsa Economica A Patrimonio Culturale Delle Comunità Tra Medioevo Ed Età Contemporanea” a cura di Paolo de Vingo, Le Radici di una Identità, FrancoAngeli Open Access, Milano, 2022, p.312-313.
[407] M. Giorgio Traverso e M. Giacomo Cataneo, Li Statuti di Valtellina Riformati nella Città di Coire nell’anno del Signore M.D.XLVIII nel Mese di Genaro per il Mag. Signori Commissari a ciò specialmente eletti nella Pubblica Dieta fatta nella Medesima Città nell’Anno precedente nel mese d’Agosto, Poschiavo, 1668, p.244.
[408] F. Prandi (a cura di), Inventario dei Toponimi Valtellinesi e Valchiavennaschi. Territorio Comunale di Piateda, Società Storica Valtellinese, Sondrio, 2012 p. 96.
[409] L’Archivio di Stato di Venezia Indice Generale, Storico, Descrittivo ed Analitico, Andrea da Mosto, Biblioteca d’Arte Editrice, Tomo I, Roma, 1937, p.74
[410] Alvise Zorzi, La vita quotidiana a Venezia nel secolo di Tiziano, BUR, Milano, 1990, p.144.
[411] Andrea Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in Età Moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Volume XLVII, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed Arti, Venezia, 1993, pp.61 e ss.
[412] Alvise Zorzi, La vita quotidiana a Venezia nel secolo di Tiziano, BUR, Milano, 1990, pp. 145, 223.
[413] Gigi Corazzol, Livelli stipulati a Venezia nel 1591 – studio storico, Giardini Editori, Pisa, 1984, p.28; per un’esamina delle famiglie cittadine ascese al patriziato in seguito alla riapertura del Maggior Consiglio del 1646: Massimo Galtarossa, La Cancelleria ducale a Venezia, in “L’expérience du déclassement social. France-Italie, XVIe-premier XIXe siècle”, Michela Barbot et al., Publications de l’École française de Rome, 2021, pp. 113-131.
[414] Andrea Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in Età Moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Volume XLVII, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed Arti, Venezia, 1993, p.38.
[415] Andrea Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in Età Moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Volume XLVII, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed Arti, Venezia, 1993, pp.39,40.
[416] L’Archivio di Stato di Venezia Indice Generale, Storico, Descrittivo ed Analitico, Andrea da Mosto, Biblioteca d’Arte Editrice, Tomo I, Roma, 1937, p.219
[417] Alvise Zorzi, La vita quotidiana a Venezia nel secolo di Tiziano, BUR, Milano, 1990, p.146.
[418] F. Zen Benetti, Il Testamento di Nicolò Trevisan (1604), in “Quaderni per la Storia dell’Università di Padova”, Vol. 37, Centro per la Storia dell’Università di Padova, Editrice Antenore, Roma-Padova, 2004, p.192.
[419] Aldo De Maddalena, Marco Cattini, Marzio Achille Romani, Storia economica e sociale di Bergamo, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Istituto di studi e ricerche, Vol. II Il Tempo della Serenissima – Il Lungo Cinquecento, Bergamo, 1995, p.143.
[420] Regione Lombardia, LombardiaBeniCulturali “giudice alla ragione e dazi 1428 – 1797”, Fabio Luini, 2005.
[421] Archivio Storico del Comune di Bergamo - Sezione Antico Regime, Comune di Bergamo, Dominio Veneto, Uffici giudiziari, Vicario pretorio, Segnatura definitiva: 1.2.18.2-229
[422] Archivio di Stato di Padova, Archivio Notarile, 1835, f.640rv; F. Zen Benetti, Il Testamento di Nicolò Trevisan (1604), in “Quaderni per la Storia dell’Università di Padova”, Vol. 37, Centro per la Storia dell’Università di Padova, Editrice Antenore, Roma-Padova, 2004, p.192.
[423] F. Zen Benetti, Il Testamento di Nicolò Trevisan (1604), in “Quaderni per la Storia dell’Università di Padova”, Vol. 37, Centro per la Storia dell’Università di Padova, Editrice Antenore, Roma-Padova, 2004, pp.192, 198; Archivio di Stato di Padova, Archivio Notarile, 1835, f.573rv.
[424] Giorgio Tagliaferro, Clientele cittadine, affari privati e produzione di bottega: Tiziano e i Balbi dal Legname, in “Venezia Cinquecento: studi di storia dell’arte e della cultura”, 41, 1, Bulzoni, 2011, pp.137, 158; Archivio di Stato di Venezia, Scuola Grande della Carità, b. 258, cc. 150r (16 aprile 1573), 153r (8 giugno 1573), 167v (21 marzo 1574), 178r 178v (8-9 marzo 1575), 188r (18 marzo 1576), 200v-201v (11 marzo 1577), 203r (29 marzo 1577), 206v (16 novembre 1577), 219r (2 marzo 1578), 219v (3 marzo 1578), 226r (23 marzo 1579), 232r (30 maggio 1579), 237v (20 febbraio 1580), 239v (6 marzo 1580), 250v-251v (26-27 febbraio 1581).
[425] Archivio Storico del Patriarcato, Venezia, Parrocchia di Santa Maria Formosa, Amministrazione, 1.4.2, ‘‘Libro de punti de testamenti e scritture et istromenti de fabrica et capitolo,’’ 11 v–12r. Archivio di Stato di Venezia, fondo Notarile Testamenti, b. 659, n. 733 (Vittore Maffei).
[426] Giuseppe Tassini, Notizie storiche e genealogiche sui cittadini veneziani, Archivio di Stato di Venezia, Raccolte e miscellanee, fondo 4966 Miscellanea codici, serie 001 Storia Veneta, b.11, Vol. VIII C-F, p.560, https://asve.arianna4.cloud/patrimonio/c85333e5-adc3-4806-8626-0d3bcef1b938/miscellanea-codici-storia-veneta-cittadinanze-tassini-vol-viii-c-f-b-11 .
[427] Ruffini, M. (2009). Sixteenth-Century Paduan Annotations to the First Edition of Vasari’s Vite (1550). Renaissance Quarterly, 62(3), p.775.
[428] Corpus delle iscrizioni di Venezia e delle isole della laguna veneta, Emanuele Antonio Cicogna, Ed. Piero Pazzi. Venezia, 2001, p.943-944
[429] Archivio di Stato di Venezia, fondo Notarile. Atti, b. 2576 (P.Contarini), 14r–15r. Archivio di Stato di Venezia, fondo Notarile. Atti, b.3100 (Antonio Callegarini), 412r–413v. Archivio di Stato di Venezia, fondo Notarile. Atti, b. 8238 (Francesco de Micheli), 340r–341r. Archivio di Stato di Venezia, fondo Notarile. Atti, b. 8238 (Francesco de Micheli), 340v. Lionello Puppi, Su Tiziano, Skira, Milano, 2004, p.135, n. 103
[430] Ruffini, Marco. “Sixteenth-Century Paduan Annotations to the First Edition of Vasari’s Vite (1550).” Renaissance Quarterly 62, no. 3 (2009), p.776.
[431] Michael Wyatt, The Italian encounter with Tudor England: A cultural politics of translation, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2005, p.283, nota 166
[432] Consiliorum Sive Malis Responsorum, Mariani Socini Iunioris Iurisconsultissimi, Volumen Secundum, Venetiis, 1580, p.217 e seguenti.
[433] Archivio Archinto di Milano, Parte III - Diritti padronali, Legati pii perpetui, Opere pie e limosine, Titolo VI Benefici e Cappellanie, cart. 1, fasc. 4 – XI
[434] Mario Valentino Rizzo, Competizione politico-militare, geopolitica e mobilitazione delle risorse nell’Europa cinquecentesca. Lo Stato di Milano nell’età di Filippo II, in La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca, a cura di E. Brambilla e G. Muto, Milano, Unicopli, 1997, pp. 371-387; Mario Valentino Rizzo, Milano e le forze del principe. Agenti, relazioni e risorse per la difesa dell’impero di Filippo II , in “Felipe II (1527-1598) – Europa y monarquia catholica”, a cura di Martinez Millian J., tomo I, Universidad de Murcia, 1998, pp.731-766; Davide Maffi, Il Baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630 – 1660), Le Monnier, Firenze, 2007; Paola Anselmini, Conservare Lo Stato - Politica Di Difesa E Pratica Di Governo Nella Lombardia Spagnola Fra XVI e XVII secolo, Unicopli, Milano, 2008; A. Buono, Esercito, istituzioni, territorio. Alloggiamenti militari e “case herme” nello Stato di Milano (secoli XVI – XVII), Firenze, University Press, 2009.
[435] Gianvittorio Signorotto, Milano Spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660), Sansoni, Milano, 1996; Gianvittorio Signorotto, Guerre spagnole, ufficiali lombardi, in “I Farnese. Corti, guerra e nobiltà in antico regime”, a cura di A. Bilotto – P. Del Negro – C. Mozzarelli, Atti del convegno di studi, Piacenza, 1994, Bulzoni, Roma, 1997, pp.367-396; Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni, a cura di Massimo Carlo Giannini – Gianvittorio Signorotto, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma, 2006; C. Donati, The profession of arms and the nobility in Spanish Italy : some considerations, in “Spain in Italy : politics, society, and religion 1500-1700”, a cura di Thomas James Dandelet, John A. Marino Brill, Leiden – Boston, 2007, pp. 299-324
[436] Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, p.18.
[437] Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, pp.13-14.
[438] C. Capra, La Lombardia Austriaca nell’età delle riforme (1706 – 1796), Utet, Torino, 1987; C. Capra, Le finanze degli stati italiani nel secolo XVIII, in “L’Italia alla vigilia della Rivoluzione Francese. Atti del LIV congresso di storia del Risorgimento italiano, Milano, 1988, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1990, pp.139-173.
[439] Per un’esamina delle modalità mediante le quali le autorità austriache tendevano a favorire l’inserimento dei giovani patrizi lombardi come funzionari nelle cariche si veda: C. Capra, La Lombardia Austriaca nell’età delle riforme (1706 – 1796), Utet, Torino, 1987, p.267
[440] Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, pp.19, 25-29, 40-41, 115; C. Capra, La Lombardia Austriaca nell’età delle riforme (1706 – 1796), Utet, Torino, 1987; C. Capra, Le finanze degli stati italiani nel secolo XVIII, in “L’Italia alla vigilia della Rivoluzione Francese. Atti del LIV congresso di storia del Risorgimento italiano, Milano, 1988, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1990, pp.139-173;
[441] F. Venturi, Illuministi italiani. Tomo III. Riformatori lombardi, piemontesi e toscani, Ricciardi, Milano-Napoli, 1958; F. Venturi, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria (1750-64), Einaudi, Torino, 1969.
[442] Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, pp.38-39.
[443] Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, pp.16-17, 41, 47, 54; J. Lukeš: Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder. Nach authentischen Quellen bearb. von J. Hirtenfeld. Wien: Hof-u. Staatsdruckerei, 1890; Henrik Marczali: A katonai Mária Terézia-rend körül. Budapest: M. tud. Akad., 1934.
[444] Allmayer-Beck J.C., Wandlungen im Heerwesen zur Zeit Maria Theresias, in “Maria Theresia – Beiträge zur Geschicte der Heerwesens ihrer Zeit”, Köln, Graz-Wien, 1967, pp.7-24; Allmayer-Beck J.C., Das Heer der Kaiserin, in “Maria Theresia und ihre Zeit”, a cura di W. Koschatzky, Salzburg-Wien, 1979, pp.83-90; Hochedlinger M., Mars Ennobled – The ascent of the Military and the Creation of a Military Nobility in Mid-Eighteenth Century Austria, in “German History”, XVII, n.2, 1999, pp.141-176; Hochedlinger M., The Absburg Monarchy: From “Military-Fiscal State” to “Militarization”, in “The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe – Essays in Honour of P.G.M. Dickson”, a cura di Storrs C., Furnham, Ashgate, 2009, pp. 55-94; Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, p. 48.
[445] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 von Seiner Errichtung 1682 bis 3 Juni 1882, Verlag Und Eigenthum des Offizierskorps des Regiments Zaunrith’sche Buchdruckerei, Salzburg, 1882, p.136-137.
[446] Jaromir Formanek, Geschichte des k.k. Infanterie-regiments nr. 41, Vol. 1, Druck und Verlag der H. Czopp’schen Buchdruckerei, Czernowitz, 1886, p.126-127.
[447] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 von Seiner Errichtung 1682 bis 3 Juni 1882, Verlag Und Eigenthum des Offizierskorps des Regiments Zaunrith’sche Buchdruckerei, Salzburg, 1882, p.166-167.
[448] Carteggio conservato presso l’Archivio di Stato Austriaco: Österreichisches Staatsarchiv, Diplomatie und Außenpolitik vor 1848, Große Korrespondenz (1517-1911), cartella 84a-40 “Gaetano Carugo an Prinz Eugen (1722), Vienna, 1722.
[449] Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler", Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft “Adler”, I Band 1881-1885 (Nr. 1-60), Druck von Carl Gerold’s Sohn, Wien, 1885, p.452-454.
[450] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 von Seiner Errichtung 1682 bis 3 Juni 1882, Verlag Und Eigenthum des Offizierskorps des Regiments Zaunrith’sche Buchdruckerei, Salzburg, 1882, p.168.
[451] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 von Seiner Errichtung 1682 bis 3 Juni 1882, Verlag Und Eigenthum des Offizierskorps des Regiments Zaunrith’sche Buchdruckerei, Salzburg, 1882, p.171.
[452] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 von Seiner Errichtung 1682 bis 3 Juni 1882, Verlag Und Eigenthum des Offizierskorps des Regiments Zaunrith’sche Buchdruckerei, Salzburg, 1882, p.195.
[453] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 von Seiner Errichtung 1682 bis 3 Juni 1882, Verlag Und Eigenthum des Offizierskorps des Regiments Zaunrith’sche Buchdruckerei, Salzburg, 1882, p.196.
[454] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 von Seiner Errichtung 1682 bis 3 Juni 1882, Verlag Und Eigenthum des Offizierskorps des Regiments Zaunrith’sche Buchdruckerei, Salzburg, 1882, p.373.
[455] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 von Seiner Errichtung 1682 bis 3 Juni 1882, Verlag Und Eigenthum des Offizierskorps des Regiments Zaunrith’sche Buchdruckerei, Salzburg, 1882, p.392.
[456] Gustav Ritter Amon von Treuenfest, Geschichte_des_k_k_Infanterie_Regimentes Nr. 47, Druck von Ludwig Mayer Rudolf Brzezowsky, Wien, 1882, p.273-274.
[457] Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, p.114.
[458] Johann Svoboda, Die Zöglinge der Wiener-Neustädter Militär-Akademie von der Gründung des Institutes bis auf unsere Tage, Druck und Commissions-Verlag von F. B. Greitler Albrechtgasse, Wien, 1870 pag 52; Johann Svoboda, Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt und ihre Zöglinge von der Gründung der Anstalt bis auf unsere Tage · Volume 1, Druck der Kaiserlich-Königlichen Hof-Und Staatsdruckerfi, Wien, 1894, p.74; Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt und Ihre Zöglinge von der Gründung der Anstalt Bis Auf Unsere Tage, Johann Svoboda, Dritter Band, Druck und Verlag der Kaiserlich- Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1897.
[459] Johann Svoboda, Die Zöglinge der Wiener-Neustädter Militär-Akademie von der Gründung des Institutes bis auf unsere Tage, Druck und Commissions-Verlag von F. B. Greitler Albrechtgasse, Wien, 1870 pag 61; Johann Svoboda, Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt und ihre Zöglinge von der Gründung der Anstalt bis auf unsere Tage · Volume 1, Druck der Kaiserlich-Königlichen Hof-Und Staatsdruckerfi, Wien, 1894, p.79; Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt und Ihre Zöglinge von der Gründung der Anstalt Bis Auf Unsere Tage, Johann Svoboda, Dritter Band, Druck und Verlag der Kaiserlich- Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1897.
[460] Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien; Vienna, Austria; Katholische Kirchenbücher; Pfarre: St Michael; Signatur: 9004; Laufendenummer: 01-14
[461] Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien; Vienna, Austria; Katholische Kirchenbücher; Pfarre: St Michael; Signatur: 9004; Laufendenummer: 02-07. Roman Freiherr von Procházka, Genealogisches Handbuch erloschener böhmischer Herrenstandsfamilien, Vol.1, Degener, Repubblica Ceca, 1973, p.192.
[462] J.B. Rietstap, Armorial Général, Tome II, G.B. van Goor Zonen, Gouda, 1887, p.1103.
[463] Edmund Wilhelm Braun, Dr., Zeitschrift für Geschichte und Kulturgesechichte Österreichisch-Schlesiens, Verlag des Zeitschrift-Ausschusse des städtischen Museum Troppau, Troppau, 1912, p.273.
[464] Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien; Vienna, Austria; Katholische Kirchenbücher; Pfarre: St Michael; Signatur: 9004; laufendenummer: 02-07
[465] Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien; Vienna, Austria; Katholische Kirchenbücher; Pfarre: St Michael; Signatur: 9004; Laufendenummer: 01-14
[466] Alois Wück, Geschichte des K. K. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59, Verlag d. Officierskorps d. Regiments, Salzburg, 1882, p.394
[467] Almanach de la Cour pour l’an MDCCCIX, de l’Imprimérie Impériale et Royale, Vienna, 1809, p.128.
[468] Otto Titan von Hefner, Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland herausgegeben von einigen deutschen Edelleuten, enthaltend zuverlässige und urkundliche Nachrichten über 9898 Adels-Geschlechter, Vol.2, Regensburg, 1863, p.87.
[469] Dr. Heinrich W. Höfflinger, Jahrbuch der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft “Adler”, Neue Folge – Dreiundzwanzigster Band, Buchdruckerei Carl Gerold’s Sohn in Wien, Wien, 1913, p.46.
[470] Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, pp.143-144, 148,166.
[471] Pröve R., Clio in Uniform? Probleme und Perspektive einer Modernen Militärgeschichte der Frühen Neizeit, Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 1997; Kroener B.H., L’État moderne et la société militaire au XVIIIe siècle, in Guerre et concurrence entre les états européenns du XIVe au XVIIIe siècle, a cura di P. Contamine, Puf, Paris, 1998, pp.239-267; Kroll S., Krüger K., Militär und Ländliche Gesellschaft in der Frühen Neuzeit, Lit, Münster-Hamburg-London, 2000; Alessandra Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, pp.132, 142.
[472] Dattero, Soldati a Milano - Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca, Franco Angeli collana Storia Studi e Ricerche, Milano, 2014, pp.186, 189.
[473] Johann Svoboda, Die Theresianische Militär-Akademie und Ihre Zöglinge von der Gründung der Anstalt bis auf Unsere Tage, Erster Band, Druck der Kaiserlich-Königlichen hof und Staatsdruckerfi, Wien, 1894, p. II.
[474] Officiers-Register k.u.u. Kriegs-Archivs e presso Fach-Rechnungs-Abtheilung. In “Geschichte des k.u.k. Infanterie-Regiments Guidobald Graf von Starhemberg N.13 Im Auftrage des Regiments-Commandos bearbeitet von Hauptmann Friedrich Mandel, Ester Band Mit 1 Porträt und 3 Tafeln, Krakau Selbstverlag des Regiments, Druck von Wl. L. Anczyc & Comp.Unter der Leitung des J. Gadowski. 1893, p.475
[475] Francesca Terraccia, In attesa di una scelta – Destini femminili ed educandati monastici nella Diocesi di Milano in età moderna, Viella Libreria Editrice, Roma, 2020, p.52-53; Archivio Storico Diocesano di Milano, fondo “Educande”, y 2181, 1936, 1927, 2119, 1819, 3692, 2198, 1789, 2025, 1815, 2129, 2147, 2113, 2041, 1975, z 48, 2025, 3848, 2036, 1821, 1854, 1926, 5246, 2208, 2136, 1855, 1855 bis, 2052, 1829, 2120, 2060, 2116, 1816, 2239, 2121, 2217, 2245, 2032, 2033, 1950, 2055, 2064, 2057, 1820, 1974, 2112, 2183, 1946, 2246, 1866, 2109.
[476] “Unternehmensgeschichte 1816–1818 Zeit Der Gründung Und Des Provisoriums,” Oesterreichische Nationalbank (OeNB) Eurosystem, accessed October 5, 2024, https://www.oenb.at/Ueber-Uns/unternehmensgeschichte/1816-1818.html .
[477] Alphabetisches Nahmen-Verzeichniss am 31. December 1818 bestandenen Herren Actionnäre der privilegirten Oesterreichischen National-Bank. S.l: N.p., Bayerische Staatsbibliothek, InBindeeinheit Signatur: 2 J.austr. 59 d, 1818; Alphabetisches Nahmen-Verzeichniss der sämmtlichen Herren Actionnäre der privilegirten Oesterreichischen National-Bank, am 31. December 1819, Bayerische Staatsbibliothek, 2 J.austr. 59 d, München, 1820, p.215.
[478] Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien; Vienna, Austria; Katholische Kirchenbücher; Pfarre: St Stephan; Signatur: 9001; Laufendenummer: 03-45. Wiener Neuigkeits-Blatt, Nr.201, Sollinger, J. P., Vienna, 30 agosto 1856. Oesterreichischer Volksfreund Wien, Nr.201, Vienna, 30 agosto 1856.
[479] Familiengeschichtliche Blätter, Band I umfassend I.—III. Jahrgang v. 7. 1903-5 (Lieferung ı bis 36.), Döbeln (Sachsen), 1906, p.207.
[480] Il Prefetto della Provincia di Piacenza, Prot. n.26995/2019/Area II, Piacenza, 17 febbraio 2020.
[481] Comune di Misinto, Provincia di Monza e Brianza, Registri degli Atti di Nascita, atto n.18 P.1, 1881.
[482] Comune di Rovellasca (Como), Registri dello Stato Civile di Rovellasca (Como), 1866-1928, Stato di Famiglia, foglio n.132.
[483] Chiesa della Santissima Trinità, Registro dei Matrimoni, atto n.215, Milano, 8 novembre 1913.
[484] Chiesa della Santissima Trinità, Registro Duplicati degli Atti di Nascita e di Battesimo, numero progressivo 218, Milano, 3 giugno 1917.
[485] Ministero della Guerra, Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli ufficiali e sottufficiali del R. esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare, Disp. 103° - Anno 1942-XXI – Ricompense al Valor Militare, Roma, 5 novembre 1942, p.8226.
[486] Sito istituzionale AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, La Storia, accesso il 22 dicembre 2024, https://aiba.it/la-storia/ .
[487] Paola Pica, La Guerra dell’esclusiva tra agenti e broker, Corriere della Sera, Soldi & Famiglia/6, 22 febbraio 1987, p.20; Fausto Panzeri, Ventimila professionisti a 100 milioni l’anno, Corriere della Sera, Soldi & Famiglia/6, 22 febbraio 1987, p.20.
[488] Matrimonio tra broker nel ramo assicurativo, La Repubblica, 39 Economia, 5 settembre 1990.
[489] Rivalutazione monetarie ISTAT, https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/Widget/calcolatoreWidget.jsp
[490] Major Companies of Europe 1991/92, Vol 2 Major Companies of the United Kingdom, a cura di R. M. Whiteside, A. Wilson, S. Blackburn, S.E. Hörnig, C.P. Wilson, Graham & Trotman, London, 1991, p.133, https://www.google.it/books/edition/Major_Companies_of_Europe_1991_92/9HrrCAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.
[491] Lloyds, History, Important people from our past, Cuthbert Heath, https://www.lloyds.com/about-lloyds/history/important-people-from-our-past/cuthbert-heath consultato il 25 gennaio 2025.
[492] Matrimonio tra broker nel ramo assicurativo, La Repubblica, 39 Economia, 5 settembre 1990.
[493] Milano Finanza, Numero 211, 26 ottobre 2000, pag. 28, https://www.milanofinanza.it/news/nasce-assiparos-sara-il-leader-del-brokeraggio-assicurativo-italiano-944190
[494] Nicoletta Prevost, Voglia di ritratto - La Milano che conta si mette in posa - Clic d’autore con blasone per l’album d’oro dei vip, La Repubblica, Grande Milano, 20 aprile 1990, p.XII; Angelo Spina, Sorrisi Dorati, Chorus, febbraio 1990.
[495] Sergio Rebora, Archivio Storico ASP Golgi-Redaelli, I personaggi, Autori delle opere d’arte, Anna Prati (1911 – 1997), consultato il 28 gennaio 2025: https://www.culturagolgiredaelli.it/i-personaggi/autori-delle-opere-darte/anna-prati/
[496] Micromégas – rivista di studi e confronti italiani e francesi, Vol. 1-2, Bulzoni Editore, Roma, settembre-dicembre 1974 , p.147; Annali – Sezione Romanza, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, Vol. 18-19, Unior Press, Napoli, 1976, p.383-384; Alla bottega, Vol.14, 1976, p.62.
[497] Corriere della Sera, Dentro Milano, Cronaca Flash – Libri/Presentazioni, 8 novembre 1988, p.37; Italian Poets of the twentieth century, Casalini Libri, Fiesole, 1997, p.109; Misure Critiche, Vol. 70-77, La Fenice, 1989, p.209; Les Langues néo-latines, Vol. 268-271, Société des langues néo-latines, 1989, p.121;
[498] Paolo Lagazzi, La stanchezza del mondo – Ombre e bagliori dalle terre della poesia, Moretti & Vitali, Bergamo, 2014, pp. 238-247.
[499] Comune di Rovellasca (Como), Registri dello Stato Civile di Rovellasca (Como), 1866-1928, Pubblicazioni di Matrimonio, atto n.17, 1893.
[500] Comune di Rovellasca (Como), Registri dello Stato Civile di Rovellasca (Como), 1866-1928, Atti di Morte, atto n.4, 1920.
[501] Sito del Comune Di Rovellasca, Itinerario “Conoscere Rovellasca”, Villa Carugo (ora palazzo comunale), accesso il 21 dicembre 2024: https://www.halleyweb.com/c013201/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/141 .














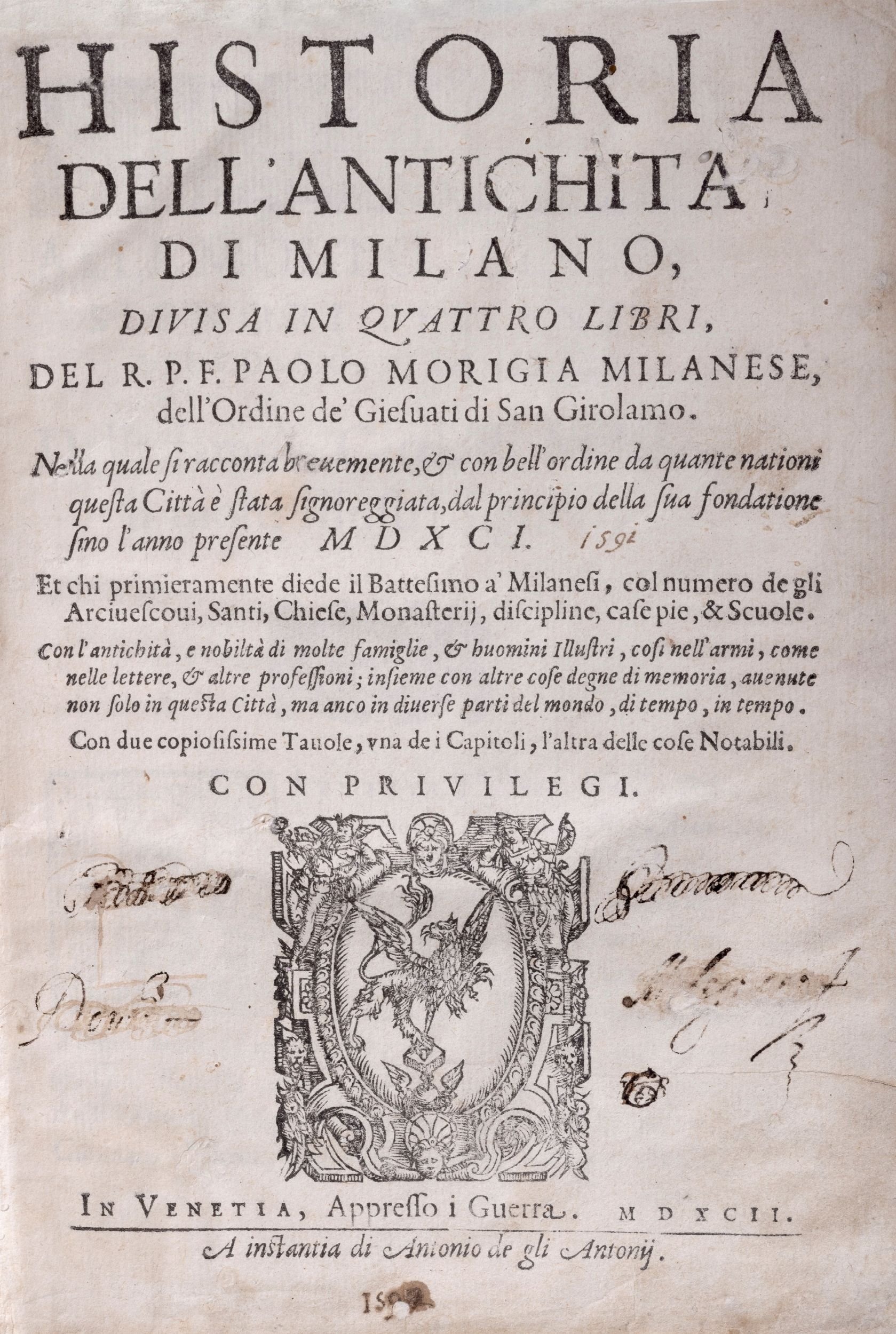
















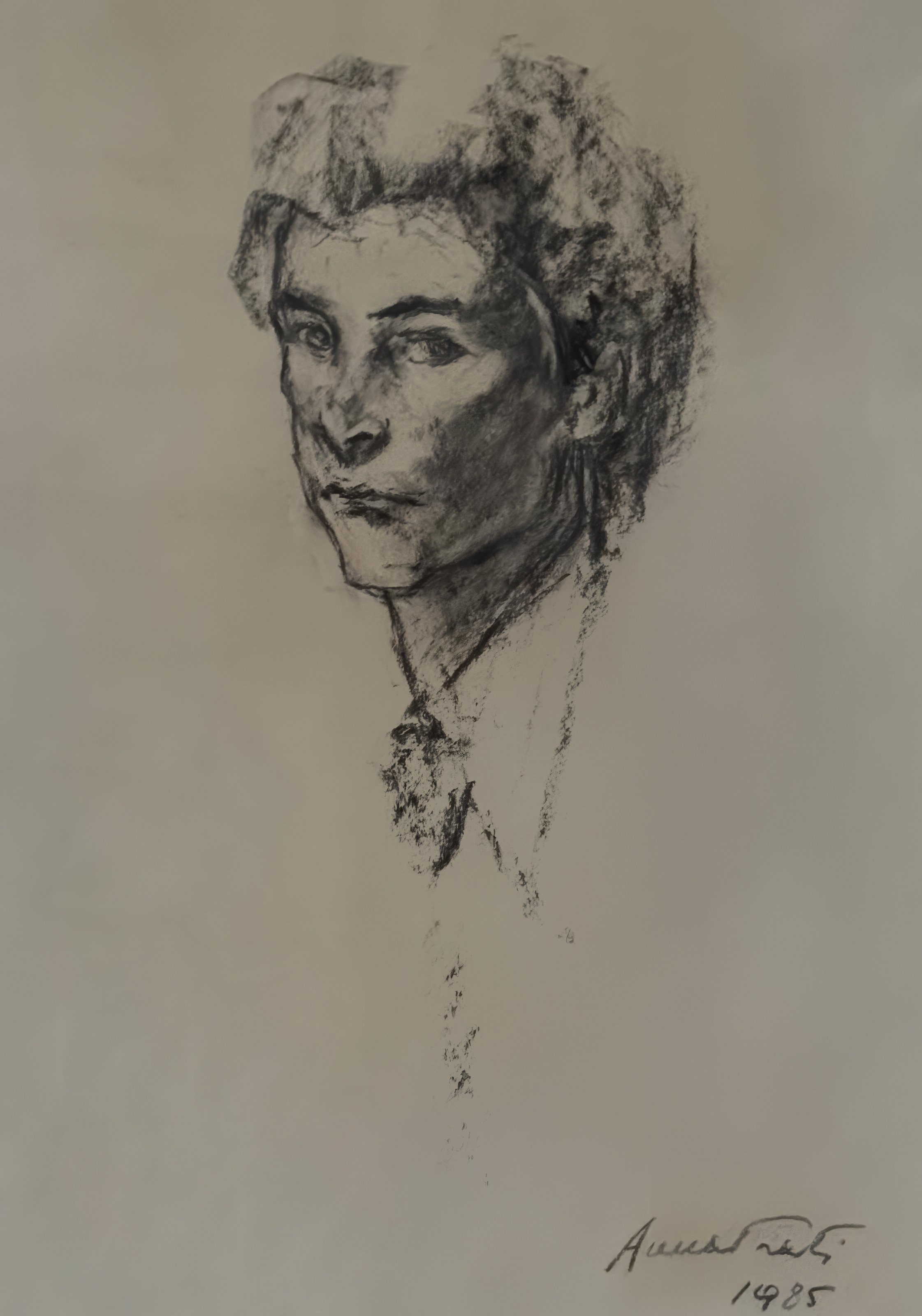
![Copia degli inviti personali rilasciati dal libraio e scrittore Cesarino Branduani in occasione della presentazione del volume “Testi e Poesie” di Alberto Valli Fassi [von Karuck Soheve]; Milano, 1975.](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/67d0a0eac76dd32850e146a2/93449e84-5b8c-4396-8963-c3bf63fd5aa8/Cesarino+Branduani+-+Valli+Fassi+von+Karuck+Soheve.jpg)
